Conoscenza
La conoscenza è la consapevolezza e la comprensione di fatti, verità o informazioni ottenuti attraverso l'esperienza o l'apprendimento (a posteriori), ovvero tramite l'introspezione (a priori).[1] La conoscenza è l'autocoscienza del possesso di informazioni connesse tra di loro, le quali, prese singolarmente, hanno un valore e un'utilità inferiori.[2]
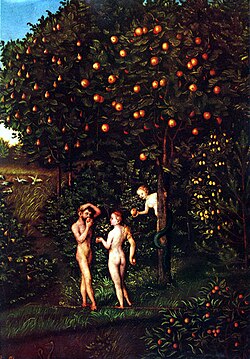
ma per seguir virtute e canoscenza.»
Introduzione generale
"Conoscenza" è un termine che può assumere significati diversi a seconda del contesto, ma ha in qualche modo a che fare con i concetti di significato, informazione, istruzione, comunicazione, rappresentazione, apprendimento e stimolo mentale.
La conoscenza è qualcosa di diverso dalla semplice informazione. Entrambe si nutrono di affermazioni vere, ma la conoscenza è una particolare forma di sapere, dotata di una sua utilità. Mentre l'informazione può esistere indipendentemente da chi la possa utilizzare, e quindi può in qualche modo essere preservata su un qualche tipo di supporto (cartaceo, informatico, ecc.), la conoscenza esiste solo in quanto c'è una mente in grado di possederla. In effetti, quando si afferma di aver esplicitato una conoscenza, in realtà si stanno preservando le informazioni che la compongono insieme alle correlazioni che intercorrono fra di loro, ma la conoscenza vera e propria si ha solo in presenza di un utilizzatore che ricolleghi tali informazioni alla propria esperienza personale. Fondamentalmente la conoscenza esiste solo quando un'intelligenza possa essere in grado di utilizzarla.
In filosofia si descrive spesso la conoscenza come informazione associata all'intenzionalità. Lo studio della conoscenza in filosofia è affidato all'epistemologia (che si interessa della conoscenza come esperienza o scienza ed è quindi orientata ai metodi ed alle condizioni della conoscenza) ed alla gnoseologia (che si ritrova nella tradizione filosofica classica e riguarda i problemi a priori della conoscenza in senso universale).
Scetticismo, conoscenza ed emozioni
Quando si risponde di no alla domanda se sia veramente possibile raggiungere la conoscenza, o se sia possibile mai giustificare abbastanza le nostre convinzioni da poterle chiamare "conoscenza", si approda allo scetticismo filosofico, a cui oggi aderiscono alcuni scienziati e filosofi. Lo scetticismo filosofico è la prospettiva che indaga criticamente se la conoscenza degli uomini sia vera; i suoi seguaci sostengono che non è possibile ottenere una conoscenza "vera", poiché la giustificazione non è mai del tutto certa. Questa posizione differisce dallo scetticismo scientifico, che è invece la prospettiva per la quale non sarebbe possibile accettare la veridicità di un'affermazione se non dopo averla verificata sperimentalmente.
A ogni modo, la conoscenza è spesso vista anche come una sorta di antidoto all'irrazionalità delle pulsioni ed emozioni umane. Come dice Ralph Waldo Emerson: «La conoscenza è l'antidoto della paura; Conoscenza, Uso e Ragione, coi loro ausili più elevati. Il bambino su una scala, o un graticolato, o in una vasca da bagno, o con un gatto, è in pericolo quanto il soldato davanti al cannone o a un’imboscata. Ciascuno sormonta le paure non appena comprende precisamente il pericolo e impara i mezzi di resistenza. Ciascuno è soggetto al panico, che è, esattamente, il terrore dell'ignoranza arresa all’immaginazione».[3]
Distinzione tra conoscere la cosa e conoscere il come
Facciamo un esempio. Quando Mimma dice: «Il modo di nuotare più veloce è lo stile libero: si tratta di agitare le gambe a turno, muovendo al contempo le braccia più o meno in circolo attorno alla spalla», ella dispone di una conoscenza proposizionale del nuoto e del come nuotare in stile libero.
Quando Mimma acquisisce questa conoscenza proposizionale tramite un'enciclopedia, non acquisisce al contempo la capacità di nuotare: ella dispone, certo, di una conoscenza proposizionale, ma non di quella procedurale, ovvero del cosiddetto know-how. In generale, mentre è facile mettere in pratica un certo know-how (basta eseguire le operazioni in questione), non è altrettanto facile dimostrare la validità di una conoscenza meramente proposizionale.[4] In questo caso si tratta di quella forma di conoscenza tacita indagata da Michael Polanyi.
La conoscenza quindi non è solo la capacità di interpretare messaggi sensoriali provenienti dal mondo esterno, saper immaginare, inventare, risolvere problemi ma è anche la capacità di intraprendere una certa azione oppure, a seconda delle esigenze, di non intraprenderla. Nel caso di Mimma, sopra riportato, ella, dopo essere saltata nella piscina, comincerà a nuotare nel modo che le è noto (il che le consentirà di non affogare). Viceversa, saltare in una piscina avendo letto qualcosa sul nuoto, ma senza conoscere realmente il metodo, può essere fatale. Ne risulta che la conoscenza ha a che fare con la saggezza: è opportuno che Mimma salti in piscina subito dopo aver mangiato?
Differenze tra conoscenza inferenziale e conoscenza fattuale
La conoscenza viene anche distinta in fattuale o inferenziale. La prima si basa sull'osservazione diretta; non è esente da una certa dose di incertezza, a causa dei possibili errori di osservazione e di interpretazione, oltre che dalla possibilità che i sensi possano essere ingannati da una illusione.
La conoscenza inferenziale è invece basata sul ragionamento a partire non da un'esperienza ma da un fatto acquisito, o da una ulteriore conoscenza inferenziale, quale ad esempio una teoria. Una tale conoscenza può essere o meno verificabile tramite l'osservazione o l'esperimento. Per esempio, tutta la conoscenza relativa all'atomo è di tipo inferenziale. La distinzione tra conoscenza fattuale ed inferenziale è studiata dalla semantica generale.
Attraverso l'esperienza, l'osservazione e l'inferenza, gli individui e le culture ottengono una conoscenza sempre maggiore. Il modo in cui questa conoscenza si diffonde dagli uni agli altri è esaminata dalla "teoria antropologica della diffusione". Questa esplora i fattori che portano gli uomini a divenire consapevoli, esperti, e ad adottare idee e pratiche nuove.
In proposito, alcuni studiosi mettono in rilievo come si abbia conoscenza solo grazie alla memoria, ad esempio Gustav Meyrink.
Diverse forme di conoscenza
Nella disciplina chiamata "gestione della conoscenza", o Knowledge Management, si distinguono vari tipi di conoscenza: quella tacita, quella esplicita e quella incorporata.
Conoscenza esplicita
È quella forma di conoscenza che può in qualche modo essere rappresentata, o meglio, che può essere trasferita da un individuo ad altri tramite un supporto fisico, quale può essere un libro o un filmato, o direttamente, attraverso una conversazione o una lezione. Un documentario, un manuale, un corso, sono tutti contenitori di conoscenza esplicita.
Conoscenza tacita
È quella forma di conoscenza che ci è più propria, ovvero ciò che sappiamo, anche se a volte non siamo capaci di esplicitarlo. Non tutta la conoscenza tacita è in effetti esplicitabile, e quando lo è, non è detto che lo possa essere completamente. Il «saper fare» qualcosa è conoscenza tacita, così come lo è quella particolare forma di conoscenza al quale diamo il nome di «intuizione», e che altro non è che la capacità di utilizzare in modo inconscio la propria esperienza per risolvere in modo apparentemente magico e inspiegabile, problemi anche molto complessi.[5]
La maggior parte della conoscenza di un individuo o di un gruppo di individui è tacita e non può essere esplicitata in toto o in parte. Quindi, in un sistema di conoscenza, gli esseri umani non sono semplici utenti, ma parte integrante del sistema.
Conoscenza incorporata
È quella forma di conoscenza che, pur esplicitata, non lo è in forma immediatamente riutilizzabile, ma richiede a sua volta conoscenza per essere estratta. Ad esempio, un processo nasce dalla formalizzazione di un'esperienza, ma pur essendo consapevoli di quali siano i passi per eseguirlo, si può ignorare il perché debbano essere eseguiti in quella determinata maniera. Solo chi ha una certa esperienza può comprendere perché quel processo è stato definito in quel modo. Un oggetto ha la conoscenza incorporata nell'ergonomia del design piuttosto che nella realizzazione delle funzionalità.
L'esempio del libro
Un libro è un contenitore di tutti e tre i tipi di conoscenza: quella esplicita è nel contenuto, in ciò che dice; quella incorporata è nello stile di scrittura piuttosto che nel modo in cui è stato realizzato, non solo come testo, ma come oggetto fisico (rilegatura); quella tacita è in tutto ciò che non è stato scritto, ovvero nel lavoro preparatorio che solo l'autore del testo potrebbe cercare di raccontare, nelle scelte fatte e nella capacità stessa di averlo scritto.
Note
- ^ L'etimologia deriva dalla particella latina cum + il vocabolo greco antico gnòsis (cfr. dizionario etimologico). Termini arcaici sono conoscienza, canoscenza, cognoscenza (cfr. dizionario italiano).
- ^ Diceva in proposito Aristotele che «il tutto è maggiore della somma delle parti».
- ^ R. W. Emerson, tratto da Coraggio, in Society and Solitude, 1870.
- ^ Cfr. Gilbert Ryle, The Concept of Mind, 1949.
- ^ Cfr. Michael Polanyi, The tacit dimension, 1966.
Bibliografia
- Valerio Meattini, Anamnesi e conoscenza in Platone, ETS, Pisa 1981.
- A. P. Viola, Elementi di filosofia della conoscenza, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2001.
- A. Levi, Studi di filosofia greca, a cura di Vittorio Enzo Alfieri e Michele Untersteiner, ed. Laterza, Bari 1950.
- A. Livi, Senso comune e metafisica. Sullo statuto epistemologico della filosofia prima, Leonardo da Vinci, 2002.
- Creath, Richard, Induction and the Gettier Problem, Philosophy and Phenomenological Research, Vol.LII, No.2, June 1992.
- Feldman, Richard, An Alleged Defect in Gettier Counterexamples, Australasian Journal of Philosophy, 52 (1974): 68-69.
- Gettier, Edmund, Is Justified True Belief Knowledge?, Analysis 23 (1963): 121-23.
- Goldman, Alvin I., Discrimination and Perceptual Knowledge, Journal of Philosophy, 73.20 (1976), 771-791.
- Hetherington, Stephen, Actually Knowing, The Philosophical Quarterly, Vol.48, No. 193, October 1998.
- Lehrer, Keith and Thomas D. Paxon, Jr., Knowledge: Undefeated Justified True Belief, The Journal of Philosophy, 66.8 (1969), 225-237.
- Levi, Don S., The Gettier Problem and the Parable of the Ten Coins, Philosophy, 70, 1995.
- Swain, Marshall, Epistemic Defeasibility, American Philosophical Quarterly, Vol. II, No. I, January 1974.
- V. Meattini, Filosoficamente abita l'uomo. Etica e conoscenza, G. Laterza, Bari 2005.
- V. Meattini, Temi filosofici nella dottrina platonica della conoscenza, "Filosofia", 30 (1979), pp. 113–128.
- C. Ronchi, L'albero della conoscenza. Luci e ombre della scienza, Jaca Book, 2010 ISBN 978-88-16-40936-1
Voci correlate
Altri progetti
- Wikiquote contiene citazioni sulla conoscenza
- Wikizionario contiene il lemma di dizionario «conoscenza»
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su conoscenza