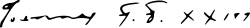Papa Giovanni XXIII
Giovanni XXIII[1] (in latino: Ioannes PP. XXIII, nato Angelo Giuseppe Roncalli; Sotto il Monte, 25 novembre 1881 – Città del Vaticano, 3 giugno 1963) è stato il 261º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica (il 260º successore di Pietro), Primate d'Italia e 3º sovrano dello Stato della Città del Vaticano (accanto agli altri titoli connessi al suo ruolo). Fu eletto papa il 28 ottobre 1958 e in meno di cinque anni di pontificato riuscì ad avviare il rinnovato impulso evangelizzatore della Chiesa Universale. È ricordato con l'appellativo di "Papa buono". Fu terziario francescano ed è stato beatificato da papa Giovanni Paolo II il 3 settembre 2000.
| Papa Giovanni XXIII | |
|---|---|
| File:Giovannixxiii.jpg | |
| 261º papa della Chiesa cattolica | |

| |
| Elezione | 28 ottobre 1958 |
| Incoronazione | 4 novembre 1958 |
| Fine pontificato | 3 giugno 1963 |
| Motto | Oboedientia et Pax |
| Cardinali creati | vedi categoria |
| Predecessore | papa Pio XII |
| Successore | papa Paolo VI |
| Nome | Angelo Giuseppe Roncalli |
| Nascita | Sotto il Monte (BG), 25 novembre 1881 |
| Morte | Città del Vaticano, 3 giugno 1963 (81 anni) |
| Sepoltura | Basilica di San Pietro |
| Firma | |
| Beato Giovanni XXIII | |
|---|---|
Romano pontefice | |
| Nascita | Sotto il Monte, 25 novembre 1881 |
| Morte | Città del Vaticano, 3 giugno 1963 |
| Venerato da | Chiesa cattolica |
| Beatificazione | 3 settembre 2000 da papa Giovanni Paolo II |
| Ricorrenza | 3 giugno (11 ottobre localmente) |
| Angelo Giuseppe Roncalli | |
|---|---|
| Dati militari | |
| Paese servito | |
| Forza armata | |
| Arma | Esercito |
| Corpo | Sanità |
| Anni di servizio | 1915 - 1918 |
| Grado | |
| Guerre | Prima guerra mondiale |
| voci di militari presenti su Wikipedia | |
Biografia
Nato a Sotto il Monte il 25 novembre 1881, da Giovanni Battista Roncalli e da Marianna Mazzola, quarto di tredici fratelli, veniva - a differenza del suo predecessore, Eugenio Pacelli, che era di stirpe nobile - da una famiglia di umili origini: i suoi parenti lavoravano infatti come mezzadri. Questo non gli impedì, grazie all'aiuto economico di uno zio, di studiare presso il seminario minore di Bergamo, per poi vincere una borsa di studio e trasferirsi al Seminario dell'Apollinare di Roma, l'attuale Pontificio Seminario Romano Maggiore, ove completò brillantemente gli studi e fu ordinato prete nella chiesa di Santa Maria in Montesanto, in Piazza del Popolo, nel 1904.
Da ragazzo, e durante il seminario, manifestò la venerazione per la Vergine con numerosi pellegrinaggi al Santuario della Madonna del Bosco ad Imbersago.[2]
Nel 1901 era stato coscritto ed arruolato nel 73º Reggimento fanteria, brigata Lombardia, di stanza a Bergamo.
I primi passi nella carriera ecclesiastica
Nel 1905 fu scelto dal nuovo vescovo di Bergamo, Giacomo Radini-Tedeschi, quale segretario personale. Roncalli si segnalò per la dedizione, la discrezione e l'efficienza. A sua volta Radini-Tedeschi rimarrà sempre guida ed esempio per Angelo Roncalli. Roncalli restò al fianco di Radini-Tedeschi fino alla morte di questi, il 22 agosto 1914, durante questo periodo si dedicò altresì all'insegnamento della storia della Chiesa presso il seminario di Bergamo. Fu richiamato nel 1915, a guerra iniziata, nella sanità militare e ne fu poi congedato col grado di tenente cappellano.
Nel 1921 papa Benedetto XV lo nominò prelato domestico (che gli valeva l'appellativo di monsignore) e presidente del Consiglio Nazionale Italiano dell'Opera della Propagazione della Fede. In tale ambito egli si occupò fra l'altro della redazione del motu proprio di Pio XI Romanorum pontificum, che divenne la magna charta della cooperazione missionaria.
Le missioni diplomatiche
In Bulgaria
Nel 1925 papa Pio XI lo nominò visitatore apostolico in Bulgaria, elevandolo alla dignità episcopale e affidandogli la sede titolare, pro illa vice titolo arcivescovile, di Areopoli. Si trattava di una diocesi antica della Palestina, un tempo chiamata in partibus infidelium, ossia, semplicemente, un titolo disponibile per attribuire il rango di vescovo - in questo caso a Roncalli - senza dovere affidare al prescelto le cure pastorali di una diocesi effettiva. Roncalli scelse come motto episcopale Oboedientia et pax ("Ubbidienza e pace", in latino), frase che divenne il simbolo del suo operato e che aveva ripreso dal motto del cardinale Cesare Baronio Pax et oboedientia. La consacrazione episcopale, presieduta dal cardinale Giovanni Tacci Porcelli, Segretario della Congregazione Orientale, si tenne il 19 marzo 1925 a Roma nella chiesa di San Carlo al Corso.
In Bulgaria, dove aveva principalmente il compito di riorganizzare la disastrata comunità di rito orientale, si ritrovò a contatto con la maggioranza ortodossa della popolazione, nei confronti della quale dimostrò una particolare carità. Tale approccio era d'altronde unionista, funzionale cioè a far ritornare all'unica vera Chiesa, quella cattolica, i dissidenti. In seguito dovette occuparsi pure del matrimonio tra il re bulgaro Boris III, ortodosso, e la figlia del re d'Italia Vittorio Emanuele III, Giovanna di Savoia. Papa Pio XI aveva infatti concesso la dispensa per il matrimonio di mista religione a condizione che lo sposalizio non venisse ripetuto nella Chiesa ortodossa e che l'eventuale prole fosse battezzata ed educata cattolicamente. Dopo la cerimonia cattolica celebrata ad Assisi il 25 ottobre 1930, il 31 ottobre 1930 la coppia reale, pur senza rinnovare il consenso matrimoniale, diede ad intendere al popolo bulgaro di aver ripetuto il connubio nella cattedrale ortodossa di Sofia. La profonda irritazione di Papa Pio XI per l'accaduto diede luogo a una solenne protesta papale. Il battesimo ortodosso dei figli della coppia, a partire da quello di Maria Luisa nel gennaio del 1933, diede spunto ad ulteriore indignazione, che prese la forma di nuova pubblica protesta pontificia.
A Istanbul
Nel 1934 fu nominato arcivescovo titolare di Mesembria, antica città della Bulgaria, con l'incarico di delegato apostolico in Turchia e in Grecia ed inoltre di amministratore apostolico "sede vacante" del Vicariato apostolico di Istanbul. Questo periodo della vita di Roncalli, che coincise con la seconda guerra mondiale, è ricordato in particolare per i suoi interventi a favore degli ebrei in fuga dagli stati europei occupati dai nazisti.
Roncalli strinse uno stretto rapporto con l’ambasciatore di Germania a Istanbul, il cattolico Franz von Papen, ex cancelliere del Reich, pregandolo di adoperarsi in favore degli ebrei. Così testimonierà l’ambasciatore tedesco: "Andavo a Messa da lui nella delegazione apostolica. Parlavamo del modo migliore per garantire la neutralità della Turchia. Eravamo amici. Io gli passavo soldi, vestiti, cibo, medicine per gli ebrei che si rivolgevano a lui, arrivando scalzi e nudi dalle nazioni dell’est europeo, man mano che venivano occupate dalle forze del Reich. Credo che 24 mila ebrei siano stati aiutati a quel modo"[3].
Durante la guerra, una nave piena di bambini ebrei tedeschi, miracolosamente sfuggita ad ogni controllo, giunse al porto di Istanbul. Secondo le regole della neutralità, la Turchia avrebbe dovuto rimandare quei bambini in Germania, dove sarebbero stati avviati ai campi di sterminio. Mons. Roncalli si adoperò giorno e notte per la loro salvezza e, alla fine - grazie anche alla sua amicizia con von Papen - i bambini si salvarono[3].
Con l'occupazione tedesca dell'Ungheria, iniziarono le deportazioni e le esecuzioni di massa anche in quel paese. La collaborazione tra Roncalli e il diplomatico svedese Raoul Wallenberg consentì a migliaia di ebrei di evitare la camera a gas. Venuto a conoscenza - grazie a Wallenberg - che migliaia di ebrei erano riusciti a varcare il confine dell'Ungheria e a rifugiarsi in Bulgaria, Roncalli scrisse una lettera a re Boris (in debito verso il nunzio, che aveva fatto celebrare il suo matrimonio, nonostante le difficoltà sopra descritte), pregandolo di non cedere all'ultimatum di Hitler che aveva ordinato di rispedire indietro i profughi. I vagoni con gli ebrei erano già al confine, ma il re annullò l'ordine di deportazione. Una ricerca portata avanti dalla Fondazione Wallenberg e dal Comitato Roncalli, con la partecipazione di alcuni storici, ha messo in luce che il delegato apostolico, approfittando delle sue prerogative diplomatiche, provvide a inviare, agli ebrei ungheresi, falsi certificati di battesimo e di immigrazione per la Palestina, dove infine giunsero. Il suo intervento si estese a favore degli ebrei di Slovacchia e Bulgaria e si moltiplicò per molte altre vittime del nazismo[4].
Nel luglio del 1943 scrisse sul diario: «La notizia più grave del giorno è il ritiro di Mussolini dal potere. L'accolgo con molta calma. Il gesto del Duce lo credo atto di saggezza, che gli fa onore. No, io non getterò pietre contro di lui. Anche per lui sic transit gloria mundi. Ma il gran bene che lui ha fatto all'Italia resta. Il ritirarsi così è espiazione di qualche suo errore. Dominus parcat illi (Dio abbia pietà di lui)»[5].
A Parigi
Nel 1944 papa Pio XII lo nominò nunzio apostolico a Parigi. Fra i suoi maggiori successi a Parigi si segnalò la riduzione del numero di vescovi di cui il governo francese reclamava l'epurazione in quanto compromessi con la Francia di Vichy. Egli riuscì a fare sì che Pio XII fosse costretto ad accettare soltanto le dimissioni di tre vescovi (quelli di Mende, Aix e Arras), oltre quello di un vescovo ausiliare di Parigi e di tre vicari apostolici delle colonie d'Oltremare. Quando in seguito fu creato cardinale, nel 1953, il presidente francese Vincent Auriol (benché socialista e notoriamente ateo), reclamò un antico privilegio riservato ai monarchi francesi e gli impose personalmente la berretta cardinalizia durante una cerimonia al Palazzo dell'Eliseo (lo stesso presidente francese gli conferì la Gran Croce della Legione d'Onore della Repubblica Francese il 14 gennaio 1958)[6].
Il Patriarcato di Venezia
Nel 1953, oltre a essere creato cardinale nel concistoro del 12 gennaio di quell'anno, fu nominato patriarca di Venezia.
Già durante questo periodo si segnalò per alcuni gesti di apertura. Fra i tanti va ricordato il messaggio che inviò al Congresso del PSI - partito ancora alleato del PCI i cui dirigenti e propagandisti erano stati scomunicati da papa Pio XII nel 1949 -, quando il 6 febbraio 1957 i socialisti si riunirono nella città lagunare. Ciò nonostante, non rinnegò mai la continuità con le posizioni storiche della Chiesa nei confronti delle sfide quotidiane: Jean Guitton, accademico di Francia e osservatore laico al Concilio Vaticano II, ricorda che, come riportato in una rivista del 2 gennaio 1957, Angelo Roncalli individuava le «cinque piaghe d'oggi del Crocifisso» nell'imperialismo, nel marxismo, nella democrazia progressista, nella massoneria e nel laicismo[7].
L'elezione
Di rosso, alla fascia d'argento, alla torre al naturale chiusa e finestrata di nero attraversante sul tutto e accostata in capo da due gigli d'argento, col capo patriarcale di Venezia: d'argento, al leone alato passante, guardante e nimbato, tenente con la branca anteriore destra un libro aperto recante la scritta PAX TIBI EVANGELISTA MEUS, il tutto d'oro.
A seguito della morte di papa Pio XII, Roncalli, con sua grande sorpresa, fu eletto Papa il 28 ottobre 1958 e il 4 novembre dello stesso anno fu incoronato, divenendo così il 261º Sommo Pontefice.
Secondo alcuni analisti sarebbe stato scelto principalmente per un'unica ragione: la sua età. Dopo il lungo pontificato del suo predecessore, i cardinali avrebbero perciò scelto un uomo che presumevano, per via della sua età avanzata e della modestia personale, sarebbe stato un Papa di «transizione».[senza fonte] Ciò che giunse inaspettato fu il fatto che il calore umano, il buon umore e la gentilezza di Giovanni XXIII, oltre alla sua esperienza diplomatica, conquistarono l'affetto di tutto il mondo cattolico e la stima dei non cattolici, in un modo che i suoi predecessori non avevano mai ottenuto.[senza fonte] Fin dal momento della scelta del nome, molti cardinali si accorsero che Roncalli non era ciò che loro si aspettavano, infatti Giovanni era un nome che nessun papa adottava da secoli (nel Novecento quasi tutti i papi si erano chiamati Pio e questo è ciò che molti si aspettavano) perché nella storia, dal 1410 al 1415, c'era stato un antipapa di nome Giovanni XXIII.
Inoltre, fatto che non succedeva dall'elezione di Pio IX, al momento dell'apertura momentanea della Cappella Sistina per far entrare mons. Alberto di Jorio, segretario del Conclave, subito dopo l'elezione e l'accettazione, appena il prelato si inginocchiò in segno di omaggio davanti a lui, il nuovo Papa, ancora seduto sul suo scranno da porporato, vestito degli abiti cardinalizi, si tolse dal capo lo zucchetto rosso e lo posò in testa a Di Jorio, nominandolo così cardinale. Primo atto sovrano "da Papa", fra la sorpresa generale dei cardinali confratelli che lo attorniavano e che si accorsero, da questo fatto, che il nuovo Pontefice sarebbe stato un uomo di sorprese e non un "vecchietto accomodante"[8].
Scelse quale segretario privato Loris Francesco Capovilla, che già lo assisteva quand'era patriarca di Venezia. Capovilla è restato, dopo la morte di Roncalli, un fedele custode della sua memoria.[senza fonte]
Il pontificato
Già nel dicembre 1958 papa Giovanni XXIII provvide a integrare il Collegio cardinalizio, che a causa dei rari concistori di Pio XII era ormai numericamente assai ridotto. Il nuovo Papa mostrò subito un tratto di novità, in effetti egli portò il numero massimo di cardinali a settantacinque, superando il tetto di settanta cardinali ormai fermo dai tempi di papa Sisto V.
Il suo pontificato fu segnato da episodi indelebilmente registrati dalla memoria popolare, oltre che da un'aneddotica celeberrima e vastissima. I suoi «fuori programma», talvolta strepitosamente coinvolgenti, riempirono quel vuoto di contatto con il popolo che le precedenti figure pontificie avevano accuratamente preservato come modo di comunicazione distante e immanentista del «Vicario di Cristo in Terra», quale è il ruolo dogmatico del pontefice.
Per il primo Natale da Papa visitò i bambini malati dell'ospedale romano Bambin Gesù, ove benedisse i piccoli, alcuni dei quali lo avevano scambiato per Babbo Natale.
Il giorno di santo Stefano sempre del suo primo anno di pontificato, il 26 dicembre 1958, visitò i carcerati nella prigione romana di Regina Coeli, dicendo loro: «Non potete venire da me, così io vengo da voi...Dunque eccomi qua, sono venuto, m'avete visto; io ho fissato i miei occhi nei vostri, ho messo il cuor mio vicino al vostro cuore..la prima lettera che scriverete a casa deve portare la notizia che il papa è stato da voi e si impegna a pregare per i vostri familiari». Memorabilmente, accarezzò il capo del recluso che, disperato, inaspettatamente gli si buttò ai piedi domandandogli se «le parole di speranza che lei ha pronunciato valgono anche per me»[9].
Quando la moglie del presidente degli Stati Uniti, Jacqueline Kennedy, arrivò in Vaticano per incontrarlo, egli iniziò a provare nervosamente le due formule di benvenuto che gli era stato consigliato di usare: «mrs Kennedy, madame» o «madame, mrs Kennedy». Quando la Kennedy arrivò, comunque, per il divertimento della stampa, abbandonò entrambe e le venne incontro appellandola semplicemente «Jackie!».[senza fonte]
Il Concilio Vaticano II e l'Ecumenismo della Chiesa Universale
Il radicalismo di papa Giovanni XXIII non si fermò all'informalità. Fra lo stupore dei suoi consiglieri e vincendo le remore e le resistenze della parte conservatrice della Curia, indisse un concilio ecumenico, meno di novant'anni dopo il Concilio Vaticano I, Giovanni XXIII ebbe rapporti fraterni con i rappresentanti di diverse confessioni cristiane ed in particolar modo con il pastore David J. Du Plessis, ministro pentecostale della Chiese Cristiane Evangeliche Assemblee di Dio. Mentre i suoi consiglieri pensavano a tempi lunghi (almeno un decennio) per i preparativi, Giovanni XXIII lo programmò e lo organizzò in pochi mesi.
Giovanni XXIII incontrò al Vaticano Geoffrey Francis Fisher, arcivescovo di Canterbury, per circa un'ora il 2 dicembre 1960. Fu la prima volta in oltre 400 anni che un capo della Chiesa Anglicana visitava il Papa.
Il 4 ottobre 1962, ad una settimana dall'inizio del Concilio Vaticano II, Giovanni XXIII si recò in pellegrinaggio a Loreto e Assisi (Roncalli era dall'età di 14 anni terziario francescano) per affidare le sorti dell'imminente Concilio alla Madonna e a San Francesco. Per la prima volta dall'unità d'Italia un papa varcò i confini del Lazio ripercorrendo i territori che anticamente erano appartenuti allo Stato pontificio. Il breve tragitto ripristinò l'antica figura del papa pellegrino, ed il suo esempio venne poi seguito dai suoi successori Paolo VI e, in particolare, da Giovanni Paolo II.
La gente accolse favorevolmente questa iniziativa affollando non solo i due santuari meta del tragitto (ad Assisi persino i frati salirono sui tetti antistanti la basilica), ma anche le varie stazioni dove sostò il treno papale. Nello stesso anno (1962) il Sant'Uffizio nella figura di Alfredo Ottaviani redasse il Crimen sollicitationis, con l'avallo di Papa Giovanni: un documento diretto a tutti i vescovi del globo, che stabilisce le pene da comminare secondo il diritto canonico nelle cause di sollicitatio ad turpia (latino, «provocazione a cose turpi»), cioè quando un chierico (presbitero o vescovo) veniva accusato di usare il sacramento della confessione per fare avances sessuali ai penitenti. Il documento regola inoltre lo svolgimento dei processi canonici relativi e ordina di mantenere sui fatti scoperti un segreto totale, comprendente anche i nomi delle vittime degli abusi, pena la scomunica.
Il 3 gennaio 1962 si diffuse la notizia che Papa Giovanni XXIII avesse scomunicato Fidel Castro dando seguito al decreto del 1949 di Papa Pio XII che vietava ai cattolici di appoggiare i governi comunisti. In realtà tale atto non è stato mai effettuato dal Pontefice, come ha rivelato il 28 marzo 2012 l'allora segretario di Angelo Giuseppe Rocalli, monsignor Loris Capovilla, secondo cui la parola "scomunica" non faceva parte del vocabolario del Papa Buono[10]. A testimonianza di quanto dichiarato, basti leggere il diario di Giovanni XXIII in cui egli non accenna al provvedimento né il 3 gennaio 1962 (data in cui parla solamente delle sue udienze) né in altre date[10].
A parlare di scomunica fu l'arcivescovo Dino Staffa, in quel momento segretario della Congregazione per i seminari, che in base ai suoi studi di diritto canonico la considerava già operata de facto se non di diritto[11]; inoltre altri importanti esponenti della curia volevano con questa mossa lanciare un segnale ostile al centrosinistra nascente in Italia[10]. L'autorevolezza di tali voci fece in modo che la leggenda della scomunica non venisse smentita dal Papa (che però ci rimase molto male[10]) e che fosse creduta da tutti, anche dallo stesso Castro, che aveva precedentemente abbandonato la fede cattolica e che dunque lo considerò un evento di scarse conseguenze poiché per sua stessa ammissione non è mai stato credente.[12]
Il discorso della luna
Uno dei più celebri discorsi di papa Giovanni, forse una delle allocuzioni in assoluto più celebri della storia della Chiesa, è quello che ormai si conosce come «Il discorso della luna».
L'11 ottobre 1962, in occasione della serata di apertura del Concilio, piazza San Pietro era gremita di fedeli che, se pur non comprendendo a fondo il valore teologico dell'avvenimento, ne percepivano la storicità, la fondamentalità, la difficoltà[senza fonte], ed erano nel luogo che simboleggia il cattolicesimo, la piazza appunto. A gran voce chiamato ad affacciarsi, cosa che non si sarebbe mai immaginata possibile richiedere al papa precedente[senza fonte], Roncalli disse di non voler parlare, ma limitarsi a benedire i presenti. Poi davvero si sporse, a condividere con la piazza la soddisfazione per il raggiungimento del primo traguardo[senza fonte]: si era arrivati ad aprirlo, il Concilio.
Il discorso a braccio fu poetico, dolce, semplice, e pur tuttavia conteneva elementi del tutto innovativi.
Nel momento che avrebbe dato un nuovo corso alla religione cattolica[senza fonte], con un richiamo straordinario salutò la Luna:
salutò i fedeli della sua diocesi (il papa è anche il vescovo di Roma), e si produsse in un atto di umiltà forse senza precedenti, asserendo tra le altre cose:
(...) Facciamo onore alle impressioni di questa sera, che siano sempre i nostri sentimenti, come ora li esprimiamo davanti al Cielo, e davanti alla Terra: Fede, Speranza, Carità, Amore di Dio, Amore dei Fratelli. E poi tutti insieme, aiutati così, nella santa pace del Signore, alle opere del Bene.»
E, sulla linea dell'umiltà, impartì un ordine da pontefice con il parlare di un curato:
Il Papa ora viveva con la piazza dei fedeli, ne condivideva la serata di fine estate, ne partecipava la sofferenza e la «maraviglia» per quella luna inattesa; la Chiesa era davvero molto più comunitaria di quanto non fosse mai stata in passato[senza fonte]. I fedeli avevano il Papa fra loro, con loro. Proprio ciò per cui il Concilio era stato voluto.[senza fonte]
La crisi dei missili a Cuba
Pochi giorni dopo l'apertura del Concilio ecumenico, il mondo sembra precipitare nel baratro di un conflitto nucleare.
Il 22 ottobre 1962, il Presidente degli Stati Uniti d'America, John F. Kennedy, infatti, annuncia alla nazione la presenza di installazioni missilistiche a Cuba e l'avvicinamento all'isola di alcune navi sovietiche con a bordo le testate nucleari per l'armamento dei missili. Il presidente americano impone un blocco navale militare a 800 miglia dall'isola, ordinando agli equipaggi di essere pronti ad ogni eventualità, ma le navi sovietiche sembrano intenzionate a forzare il blocco.
Di fronte alla drammaticità della situazione, il Papa sente la necessità di agire per la pace. Il 25 ottobre successivo, alla Radio vaticana, rivolge "a tutti gli uomini di buona volontà" un messaggio in lingua francese, già consegnato - in precedenza - agli ambasciatori degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, presso la santa Sede: “Alla Chiesa sta a cuore più d’ogni altra cosa la pace e la fraternità tra gli uomini; ed essa opera senza stancarsi mai, a consolidare questi beni. A questo proposito, abbiamo ricordato i gravi doveri di coloro che portano la responsabilità del potere. Oggi noi rinnoviamo questo appello accorato e supplichiamo i Capi di Stato di non restare insensibili a questo grido dell’umanità. Facciano tutto ciò che è in loro potere per salvare la pace: così eviteranno al mondo gli orrori di una guerra, di cui nessuno può prevedere le spaventevoli conseguenze. Continuino a trattare. Sì, questa disposizione leale e aperta ha grande valore di testimonianza per la coscienza di ciascuno e in faccia alla storia. Promuovere, favorire, accettare trattative, ad ogni livello e in ogni tempo, è norma di saggezza e prudenza, che attira le benedizioni del Cielo e della terra”[13].
Il messaggio suscita consenso in entrambe le parti in causa e la crisi rientra.
L'importanza del passo compiuto dal Papa è testimioniata dal russo Anatoly Krasikov, nella biografia di Giovanni XXIII scritta da Marco Roncalli: “Resta curioso il fatto che negli Stati cattolici non si riesca a trovare traccia di una reazione ufficiale positiva, all’appello papale alla pace, mentre l’ateo Kruscev non ebbe il più piccolo momento di esitazione per ringraziare il papa e per sottolineare il suo ruolo primario per la risoluzione di questa crisi che aveva portato il mondo sull’orlo dell’abisso”[14].
La drammatica esperienza convince ancor più Giovanni XXIII a un rinnovato impegno per la pace. Da questa consapevolezza, nasce, nell’aprile del 1963, la stesura dell’enciclica Pacem in Terris.
Pacem in Terris
La Pacem in Terris resta tuttora un brano fondamentale della teologia cattolica sul versante della socialità e della vita civile. Ed è per altro verso comunque un brano importante anche per la cultura sociale occidentale (anche laica) del Novecento, un testo la cui lettura (peraltro discretamente agevole) è necessaria per la comprensione di alcune tracce della politica vaticana e di quella occidentale.
Giovanni XXIII rivelò[15] che aveva affidato la composizione delle sue encicliche più famose, quelle di carattere sociale, a suoi collaboratori: nel caso della Mater et Magistra fu lui stesso a confermarlo alla finestra di piazza san Pietro, precisando che il gruppo degli esperti incaricati di stendere questo testo si era rifugiato in Svizzera e lui ne aveva perduto ogni traccia. Per l'enciclica Pacem in terris accadde lo stesso: ricevendo il primo ministro del Belgio, Théo Lefévre, che si complimentava per la pubblicazione del documento, gli confidò: «Guardi, a parte alcune righe che sono mie, tutto il resto è il frutto del lavoro di altri... Sono problemi che il Papa non può conoscere a fondo». Anche il giornale umoristico belga Pan riportò l'episodio. È la prima enciclica che oltre al clero e ai fedeli cattolici si rivolge "a tutti gli uomini di buona volontà".
Letta nelle titolazioni dei suoi capoversi, parrebbe un documento pressoché statutario, costituzionale, di organica classificazione di diritti e doveri. Letta storicamente, invece, contiene in sé elementi che valsero di force de frappe per superare l'immobilismo nei rapporti idealistici fra Chiesa e Stati, allora praticamente stagnante.
Il richiamo alle necessità dello stato sociale, mentre nel mondo occidentale cominciavano ad essere proposti schemi di capitalismo oltranzista sullo stile statunitense, giungeva in piena guerra fredda, con nazioni europee intente a pagare anche politicamente ed amministrativamente i tributi della disfatta e per questo più inclini a considerare (ciò che sarebbe stato anche strumento di facilitazione gestionale per i governi) riduzioni delle spese pubbliche per assistenza.
Per contro, l'enciclica non andava certo verso proposte di stato che da sociale potesse divenire socialista, e ristorava il ruolo di centralità dell'uomo, di libero pensiero e intendimento, ragione e motore delle scelte ideali ed obiettivo della socialità. Vale la pena di riportare il punto 5:
La pace, oggetto fondamentale e dichiarato dell'enciclica, può sorgere solo dalla riconsiderazione, in senso forse «particulare» o forse meglio umanistico, del valore dell'uomo "singolo individuo" che non può annientarsi al cospetto dei sistemi, siano essi capitalistici o socialisti. È la poco ricordata «terza via», anche detta «via del buon senso», oggi riscoperta da sempre più persone e gruppi, ma già al tempo ben definita.
La morte
Sin dal settembre 1962, prima ancora dunque dell'apertura del Concilio, si erano manifestate le avvisaglie della malattia fatale: un tumore dello stomaco, patologia che aveva già colpito altri fratelli Roncalli.[16]
Pur visibilmente provato dal progredire del cancro, papa Giovanni firmò l'11 aprile 1963 l'enciclica Pacem in Terris e, un mese più tardi, l'11 maggio 1963 ricevette dal Presidente della Repubblica italiana Antonio Segni il premio Balzan per il suo impegno in favore della pace. Fu il suo ultimo impegno pubblico. Il 23 maggio 1963, solennità dell'Ascensione, si affacciò per l'ultima volta dalla finestra per recitare il Regina Coeli.
Il 31 maggio 1963 iniziò l'agonia. Nel primo pomeriggio del 3 giugno 1963, Papa Giovanni patì di una febbre altissima, circa 42 gradi, in conseguenza alla malattia che lo affliggeva da tempo.
Giovanni XXIII morì alle 19:49 del 3 giugno 1963.
«Perché piangere? È un momento di gioia questo, un momento di gloria» furono le sue ultime parole rivolte al suo segretario, Loris Francesco Capovilla.[17]
Dal Concilio Vaticano II, che Giovanni XXIII non vide dunque terminare, si sarebbero prodotti negli anni successivi fondamentali cambiamenti che avrebbero dato una nuova connotazione al cattolicesimo moderno[senza fonte]; gli effetti più immediatamente visibili consistettero nella riforma liturgica[senza fonte], in un nuovo ecumenismo[senza fonte] e infine in un nuovo approccio al mondo e alla modernità.[senza fonte]
Giovanni XXIII venne inizialmente sepolto nelle Grotte Vaticane e all'atto della beatificazione il suo corpo fu riesumato. La salma fu trovata in un perfetto stato di conservazione (salvo annerimenti vari e lievi colliquazioni nelle parti declivi), grazie al particolare processo d'imbalsamazione eseguito dal professor Gennaro Goglia subito dopo il decesso, consistente tra l'altro nell'iniettare molti litri di liquido conservativo nelle arterie principali, sostituendo il sangue[18]. Praticati alcuni interventi conservativi, sul volto e sulle mani fu applicato uno strato conservativo di cera. Indi, dopo la cerimonia di beatificazione e l'ostensione ai fedeli, la salma fu tumulata in un'urna di vetro in un altare della navata destra della basilica di San Pietro.
La beatificazione e la canonizzazione
Giovanni XXIII fu dichiarato beato da papa Giovanni Paolo II il 3 settembre 2000. Il Martirologio Romano indica come data di culto il 3 giugno, mentre le diocesi di Roma e di Bergamo e l'arcidiocesi di Milano ne celebrano la memoria locale l'11 ottobre, anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II (11 ottobre 1962).
In generale, ai fini della beatificazione, la Chiesa cattolica ritiene necessario un miracolo: nel caso di Giovanni XXIII, ha ritenuto miracolosa la guarigione improvvisa, avvenuta a Napoli il 25 maggio 1966, di suor Caterina Capitani, delle Figlie della Carità, affetta da una gastrite ulcerosa emorragica gravissima che l'aveva ridotta in fin di vita. La suora, dopo aver pregato papa Giovanni XXIII insieme alle consorelle, avrebbe avuto una sua visione, seguita dalla subitanea guarigione, dichiarata in seguito scientificamente inspiegabile dalla Consulta Medica della Congregazione per le Cause dei Santi[19]. Dal 2000 numerose sono state le segnalazioni e i presunti miracoli. Uno di questi avrebbe passato il vaglio delle consulte mediche e dei teologi della Congregazione per le Cause dei Santi. Giovanni XXIII sarà canonizzato da Papa Francesco nel mese di dicembre del 2013 insieme ad un altro Papa, Giovanni Paolo II.
La memoria di Papa Giovanni a Sotto il Monte
Questo piccolo paese del bergamasco, che diede i natali ad Angelo Roncalli, è oggi meta di numerosi pellegrinaggi. Oltre la casa natale, particolarmente significativo è il museo che Mons. Loris Francesco Capovilla, Segretario personale di Giovanni XXIII, ha allestito dal 1988 nella residenza di Ca' Maitino (sempre presso Sotto il Monte), dove Roncalli era solito recarsi per le sue ferie estive prima di essere eletto Papa. Questo museo conserva innumerevoli cimeli appartenuti a Giovanni XXIII lì raccolti da Mons. Capovilla, fra i quali il letto su cui il Pontefice spirò il 3 giugno 1963 e l'altare della cappella privata.
La scelta del nome
Quando il cardinale Angelo Giuseppe Roncalli fu eletto e divenne papa Giovanni, ci fu una piccola controversia per decidere se lui doveva essere chiamato Giovanni XXIII oppure Giovanni XXIV; lui stesso dichiarò che il suo nome pontificale era Giovanni XXIII chiudendo la questione.
La decisione di Roncalli di non essere chiamato Giovanni XXIV, come ci si poteva aspettare, valeva come una conferma dello stato di antipapa di questo primo Giovanni XXIII. La scelta del numerale "XXIII" da parte di Roncalli venne presa, in un certo senso, già nell'estate del 1958 a Lodi dove l'allora ancora porporato, in visita al vescovo Tarcisio Vincenzo Benedetti, visitò la quadreria della Sala Gialla del palazzo vescovile di Lodi, dove sono presenti le effigi dell'antipapa Giovanni XXIII e dell'imperatore Sigismondo, che si incontrarono a Lodi nel 1414. Roncalli fece notare bonariamente all'amico Benedetti che non era conveniente tenere in un palazzo vescovile il quadro di un antipapa. Sorta la discussione circa il nome Giovanni XXIII o XXIV in un'eventuale scelta di "Giovanni" da parte di un nuovo pontefice, Roncalli espresse l'opinione che fosse giusto Giovanni XXIII, poiché Baldassarre Cossa era stato un antipapa. Non sapeva che da lì a pochi mesi sarebbe stato lui, come successore di Pio XII, a compiere quella scelta.
Dal punto di vista storico il problema rimane. I due papi dell'obbedienza pisana, per cinque secoli, furono riconosciuti come legittimi successori di Gregorio XII, e il nome di Alessandro V ne è la prova: il successivo papa Alessandro assunse la numerazione VI, perché allora Alessandro V e il Cossa erano annoverati tra i pontefici; invece il nome del secondo papa pisano, Giovanni XXIII-Cossa, fu ripreso da Roncalli tale e quale, poiché quest'ultimo fu eletto in un periodo in cui l'opinione della storiografia era mutata e lui condivideva tale opinione. In sostanza: il nome "Alessandro" fu ripreso prima che Filargo e Cossa non fossero più considerati veri papi, mentre il nome "Giovanni" fu preso dopo che i due non furono più considerati tali, con gli esiti che abbiamo visto.
Resta il fatto che nella Basilica di San Paolo fuori le Mura i mosaici dei due papi pisani si trovano entrambi esposti, prova che la tradizione successiva li aveva riconosciuti entrambi: Martino V si considerava successore immediato di Giovanni XXIII (del quale era stato sostenitore) e non di Gregorio XII (anche se quest'ultimo, e non Giovanni, fu nominato da Martino, alla sua morte, pontefice emerito di Roma), in quanto Martino pensava, e con lui molti altri, che Gregorio avesse smesso di essere papa già con la deposizione del 1409 e che la sua abdicazione del 1415 fosse stata un'onorevole formalità. Papa Leone XIII nel 1893 fece restaurare la tomba di Alessandro V, in quanto suo predecessore: ciò implica che considerava anche Giovanni XXIII (XXII) suo legittimo predecessore. Per secoli è regnata l'incertezza tra chi, come Martino V, Alessandro VI e Leone XIII, li considerava veri papi e chi no. Dunque Angelo Roncalli scelse di chiamarsi con il nome di un sedicente papa, che era stato presente nelle liste ufficiali (e anche nell'Annuario Pontificio) fino al 1947, perché condivideva la tesi degli storici, adottata da qualche anno anche nella Chiesa, secondo cui Cossa in realtà era stato, così come Filargo, solo un usurpatore.
Nel 1907, nel romanzo Il Padrone del Mondo, Robert Hugh Benson chiama gli ultimi due papi della storia "Giovanni XXIV" e "Silvestro III" poiché allora, e fino al '47, Filargo e Cossa erano considerati veri papi, mentre Silvestro III era considerato un antipapa (infatti il suo ritratto a San Paolo fuori le Mura non c'è), esattamente l'opposto di quanto succede oggi.
La scelta del nome di Roncalli ha chiuso definitivamente la questione. Però, se un giorno Alessandro V e Giovanni XXIII (XXII) venissero reintegrati come veri papi, non sarebbe un problema mettere il Cossa tra i pontefici di nome Giovanni poiché, mancando un papa Giovanni XX (mai esistito), basterebbe rinumerare i papi Giovanni XXI (Pedro Iuliani) e XXII (Jacques Duése) come "XX" e "XXI" ed inserire Baldassare Cossa come "Giovanni XXII". Pur tenendo presente che Giovanni XVI fu in realtà un Antipapa, questa numerazione sarebbe ancora più vicina, rispetto all'attuale, al vero numero dei Papae Ioannes davvero esistiti. Lo storico Edward Gibbon, infatti, si riferisce all'Antipapa Cossa chiamandolo "Giovanni XXII" e mai "XXIII".
Encicliche di Giovanni XXIII
- Ad Petri Cathedram (29 giugno 1959) [2]: conoscenza della verità, restaurazione dell'unità e della pace nella carità
- Sacerdotii Nostri Primordia (1º agosto 1959) [3]: nel centenario del piissimo transito del santo Curato d'Ars
- Grata Recordatio (26 settembre 1959) [4]: sulla recita del rosario per le missioni e per la pace
- Princeps Pastorum (28 novembre 1959) [5]: sulle missioni cattoliche
- Mater et Magistra (15 maggio 1961) [6]: sui recenti sviluppi della questione sociale
- Aeterna Dei Sapientia (11 novembre 1961) [7]: nel XV centenario della morte di san Leone Magno
- Paenitentiam Agere (1º luglio 1962) [8]: invito a far penitenza per il buon esito del concilio
- Pacem in Terris (11 aprile 1963) [9]: sulla pace fra tutte le genti nella verità, nella giustizia, nell'amore, nella libertà
Opere antecedenti il pontificato
- Il Giornale dell'anima, diario che Angelo Roncalli con costanza compilò giorno per giorno dal 1895 alla morte (cfr. Il Giornale dell'Anima).
- Angelo Giuseppe Roncalli. Il cardinale Cesare Baronio. Nel terzo centenario della sua morte. Monza, 1908 (3ª ed. Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 1961)
- Angelo Giuseppe Roncalli. Mons. Giacomo Maria Radini-Tedeschi, vescovo di Bergamo, Edizioni di Storia e Letteratura. Roma, 1963.
Genealogia episcopale
- Cardinale Scipione Rebiba
- Cardinale Giulio Antonio Santorio
- Cardinale Girolamo Bernerio, O.P.
- Arcivescovo Galeazzo Sanvitale
- Cardinale Ludovico Ludovisi
- Cardinale Luigi Caetani
- Cardinale Ulderico Carpegna
- Cardinale Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni
- Papa Benedetto XIII, O.P.
- Papa Benedetto XIV
- Papa Clemente XIII
- Cardinale Bernardino Giraud
- Cardinale Alessandro Mattei
- Cardinale Pietro Francesco Galleffi
- Cardinale Filippo de Angelis
- Cardinale Amilcare Malagola
- Cardinale Giovanni Tacci Porcelli
- Papa Giovanni XXIII
Onorificenze
Template:Infobox titolazione nobiliare
Onorificenze della Santa Sede
Onorificenze italiane
Onorificenze straniere
Note
- ^ L'ordinale XXIII è spesso pronunciato "ventitreesimo", secondo l'uso corrente della lingua italiana; ma la forma più o meno ufficiale, preferita a suo tempo dalla curia romana e dal papa stesso, è quella latineggiante di "vigesimoterzo" (in latino, vigesimus vuol dire "ventesimo"). Cfr. http://www.dizionario.rai.it/poplemma.aspx?lid=2186&r=39845.
- ^ Santuario della Madonna del Bosco
- ^ a b I giusti italiani
- ^ La Fondazione Wallenberg certificherà l'aiuto di Giovanni XXIII agli ebrei, Zenit 24 novembre 2009.
- ^ Marco Roncalli, Giovanni XXIII. Angelo Giuseppe Roncalli. Una vita nella Storia, Mondadori Milano (2006)
- ^ io GIOVANNI XXIII, La vita e i miracoli di Papa Roncalli narrati da lui stesso, Alberto Peruzzo editore, 1988, p.170
- ^ Enciclopedia Treccani
- ^ io GIOVANNI XXIII, La vita e i miracoli di Papa Roncalli narrati da lui stesso, Alberto Peruzzo editore, 1988, p.252
- ^ Marco Roncalli, op. cit., pag. 444
- ^ a b c d Il segretario di Giovanni XXIII: «La scomunica al Líder Máximo? Non c'è mai stata» Corriere della Sera 28 marzo 2012
- ^ Fidel Castro, il <<giallo>> della scomunica, La Stampa, 4 febbraio 2012]
- ^ Documentario Comandante di Oliver Stone del 2003
- ^ Radio Vaticana, 23 ottobre 2012
- ^ Lorenzo Carlessio, La Stampa, Vatican insider, 24 aprile 2013
- ^ Intervista al cardinale Oddi, su Il Sabato, 10 novembre 1990, riportata in [1]
- ^ Marco Roncalli. op. cit., p. 562
- ^ Denis Mack Smith, L'Italia del XX secolo, vol. VI (1961-1970), Rizzoli, 1977.
- ^ Famiglia Cristiana, n. 22 del 3/6/2001.
- ^ Dall'Osservatore Romano del 3 settembre 2000
Televisione
- Papa Giovanni, miniserie tv del 2002 diretta da Giorgio Capitani. Papa Giovanni ha il volto di Massimo Ghini (dai 20 ai 60 anni) e di Edward Asner (dai 60 agli 81 anni).
- Il papa buono, miniserie TV del 2003 in due puntate che racconta la vita di papa Giovanni XXIII, interpretato da Fabrizio Vidale (dai 20 ai 45 anni) e da Bob Hoskins (dai 50 anni fino alla morte), per la regia di Ricky Tognazzi.
Bibliografia
- L. Botrugno, L'arte dell'incontro. Angelo Giuseppe Roncalli Rappresentante Pontificio a Sofia, Edizioni Marcianum Press, Venezia, 2013.
- A.G. Roncalli, Il lupo, l'orso, l'agnello. Epistolario bulgaro con don K. Raev e mons. D. Theelen, a cura di Paolo Cortesi, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2013.
- Giovanni XXIII, Il congedo. Lettere a L. F. Capovilla, a cura di Ezio Bolis, Ed. Studium, 2013.
- A.G. Roncalli/Giovanni XXIII, Il giornale dell'anima e altri scritti di pieta, a cura di Loris Francesco Capovilla, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2003.
- A.G. Roncalli/Giovanni XXIII, Pater amabilis. Agende del pontefice 1958-1963, ed. critica e annotazione a cura di Mauro Velati, Istituto per le scienze religiose di Bologna, Bologna 2007.
- L. F. Capovilla, I miei anni con Papa Giovanni. Conversazione con Ezio Bolis, Rizzoli 2013.
- L. F. Capovilla, Giovanni XXIII, sette letture, Libreria Editrice Vaticana, SCV 1963.
- Giovanni XXIII nel ricordo del segretario Loris Francesco Capovilla, intervista di Marco Roncalli, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1994.
- L. F. Capovilla, Papa Giovanni segno dei tempi, Ed. Paoline, Roma 1967.
- Giovanni e Paolo, due papi. Saggio di corrispondenza (1925-1962), a cura di Loris Francesco Capovilla, Edizioni Studium, Roma 1982.
- L. Bizzarri, Giovanni XXIII. Il Papa Buono, Edizioni RAI - ERI, Roma 2000.
- N. Fabbretti, La storia di Papa Giovanni, Ed. Mursia, Milano 1967.
- E. Galavotti, Processo a Papa Giovanni. La causa di canonizzazione di Angelo Giuseppe Roncalli (1965-2000), Ed. Mulino, Bologna 2005.
- R. Iaria (a cura di), Il mio Dio è tutto. Le preghiere di Papa Giovanni XXIII, Edizioni Segno
- M. Roncalli, Giovanni XXIII. Angelo Giuseppe Roncalli. Una vita nella Storia, Milano 2006.
- M. Benigni & G. Zanchi, Giovanni XXIII. Biografia ufficiale a cura della diocesi di Bergamo, Ed. San Paolo, Milano 2000.
- G. Napolitano, E. Bolognini, T. Bertone, D. Tettamanzi, P. Poupard, L. F. Capovilla, B. Forte, L. Bettazzi F. Aloise, E. Malnati, Giovanni XXIII, di chi è questa carezza?, Edizioni Marcianum Press, Venezia 2009.
- Io GIOVANNI XXIII. La vita e i miracoli di Papa Roncalli narrati da lui stesso, Alberto Peruzzo editore, 1988
- F. Della Salda, Obbedienza e pace: il vescovo A. G. Roncalli fra Sofia e Roma, 1925-1934, Marietti, Genova 1989
- A. Melloni, Fra Istanbul, Atene e la guerra: la missione di A. G. Roncalli, 1935-1944, Marietti, Genova 1993
- G. Sabatini, Dalla crisi di Cuba alla «Pacem in terris». Giovanni XXIII e la pace attraverso la stampa italiana, Uni Service, Trento 2007
- P. Hebblethwaite, Giovanni XXIII. Il Papa del Concilio a cura di Marco Roncalli, Castelvecchi Editore, Roma, 2013
Voci correlate
Altri progetti
- Wikisource contiene una pagina dedicata a Ioannes XXIII
- Wikiquote contiene citazioni di o su Ioannes XXIII
- Wikibooks contiene testi o manuali su Ioannes XXIII
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ioannes XXIII
Collegamenti esterni
- Papa Giovanni XXIII
- Sul paese natale e i luoghi legati al futuro Papa
- Papa Giovanni XXIII: testi con concordanze e liste di frequenza
- Opera Omnia in varie lingue
- Pellicole della Filmoteca Vaticana sul Concilio (fine pagina - numeri 5 e 6), contenenti anche il famoso "discorso della Luna"
- La Stella più Fulgida, Monumento a Giovanni XXIII e la Concilio Vaticano II, opera dello scultore Alberto Sparapani, collocato presso la chiesa dei SS. Martino e Stefano di San Miniato Basso (Pi)
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 62340644 · ISNI (EN) 0000 0004 3433 6979 · SBN CFIV016383 · BAV 495/40488 · ULAN (EN) 500356830 · LCCN (EN) n79018752 · GND (DE) 118557920 · BNE (ES) XX1721425 (data) · BNF (FR) cb118866322 (data) · J9U (EN, HE) 987007263564505171 · NSK (HR) 000033655 · NDL (EN, JA) 00444720 · CONOR.SI (SL) 13182307 |
|---|