Anfiosso
| |
Benvenuto/a su Wikipedia, Anfiosso! |
Con le tue conoscenze puoi migliorare l'enciclopedia libera. Scrivi nuove voci o modifica quelle esistenti, ma non inserire contenuti inadatti. Il tuo contributo è prezioso!
Wikipedia ha solo alcune regole inderogabili, i cinque pilastri. Per un primo orientamento, puoi guardare la WikiGuida, leggere la Guida essenziale o consultare la pagina di aiuto. Se contribuisci a Wikipedia su commissione si applicano condizioni d'uso particolari. Ricorda di non copiare testi né immagini da libri o siti internet poiché NON è consentito inserire materiale protetto da copyright (nel caso sia tu l'autore/autrice, devi seguire l'apposita procedura), e di scrivere seguendo un punto di vista neutrale, citando le fonti utilizzate. Buon lavoro e buon divertimento da parte di tutti i wikipediani!
Altre informazioni
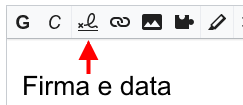
Serve aiuto?
Se hai bisogno di aiuto, chiedi allo sportello informazioni (e non dimenticare che la risposta ti verrà data in quella stessa pagina). Se avessi bisogno di un aiuto continuativo, puoi richiedere di farti affidare un "tutor". | |
Naturalmente benvenuto anche da parte mia e se avessi bisogno non esitare a contattarmi. --Jacopo (msg) 16:47, 8 mar 2006 (CET)
Ciao, le categorie nn si costruiscono in quel modo. Perfavore leggi i link indicati nel messaggio di benvenuto.. ciao RdocB 10:12, 21 lug 2006 (CEST)
re: Email
Ciao, il messagio mi è arrivato. Tieni presente che cliccando su "scrivi all'utente" invii un messaggio di posta elettronica mentre accedendo e modifcando la pagina di discussione dell'utente, nel mio caso clicca su (msg) a destra del mio nome, puoi scrivere più rapidamente sfruttando il software di wikipedia. Se ti servisse una mano per qualsiasi cosa chiedimi pure. Ciao --Jacopo (msg) 14:03, 22 lug 2006 (CEST)
Callas
Attenzione ai wikilink! è abitudine non ripeterli nella stessa voce (vedi Norma, Tosca ecc...) e inoltre in alcuni casi il link non porta all'opera. Bisognerebbe controllare con pazienza. Li avevo sistemati. Potresti per favore rimettili com'erano? Grazie --Al Pereira 15:02, 17 nov 2006 (CET)
Callas
Scusami tanto, Al Pereira. Rimedio tutto in giornata (ho poco tempo per la connessione e devo fare tutto a pizzichi e bocconi, ma ci arrivo). Ciao. Utente:Anfiosso
Ancora Callas
Cercherò di pensare, nei prossimi giorni, a come spiegare la questione nel modo migliore all'interno della voce. Capisco il tuo punto di vista, che tra l'altro conosco, ma provo a spiegarti meglio il mio precisando alcuni punti. L'"intento filologico" di fatto non ci fu: ci fu piuttosto il desiderio della riscoperta e l'amore per alcuni compositori e alcuni personaggi. Molto probabilmente tu conosci il personaggio Callas meglio di me e quindi sai che il suo approccio artistico fu sempre molto caldo e "passionale", nonostante la straordinaria tecnica. Insomma se la Callas ha eliminato determinate incrostazioni interpretative l'ha fatto con istinto di artista, non con scrupolo da filologa. Quanto ai tagli, negli anni 50 erano una prassi ma non per questo erano filologici! Il discorso vale a maggior ragione nel caso di opere fuori repertorio, per le quali non esisteva una ahimè consolidata tradizione di tagli come per Lucia o Sonnambula (a meno che non salisse sul podio Bernstein.... magari proprio con la Callas!). Ma in questi casi i tagli risultano ancora più pesanti e - onestamente - maldestri che nelle opere di repertorio. Così come le cadenze. Tra le lezioni che la Callas tenne negli anni 70 (non ricordo esattamente dove) e che furono pubblicate, ne esiste una in cui parla proprio di Bellini e Donizetti, del suo grande amore per questi autori, ma al tempo stesso afferma chiaro e tondo (come docente!... e non più negli anni 50) che questi spartiti sono pieni di difetti e che compito preciso del cantante è correggerli. Purtroppo non ho l'intervista, altrimenti varrebbe la pena di citarla, ma ricordo il passo dato che quando lo lessi mi colpì molto. Riguardo alle modifiche alle linee vocali, purtroppo ci sono anche quelle, e non mi riferisco alle variazioni delle ripetizioni delle cabalette (le rarissime volte che le canta) che come osservavi fanno parte di una prassi esecutiva dell'epoca (malauguratamente cristallizzatasi nelle variazioni rossiniane di Ricci, ma questo è un altro discorso). Mi riferisco ad altre modifiche, sia pure non altrettanto frequenti. Penso ad esempio al suo Pirata. Non si tratta di riscritture creative ma in genere di semplificazioni. Ripeto: questo non toglie che posso riscrivere il passaggio in modo da renderlo meno perentorio. Riguardo al fatto che queste modifiche rientrassero nella prassi del tempo di Bellini e Donizetti, è vero ma non bisogna dimenticare che era una prassi che loro stessi combattevano, limitando sempre più i passaggi ad libitum del cantante e combattendo gli abusi. Comunque quando il cantante "compone" entro i passaggi deputati (ripetizioni di cabalette e alcune cadenze), niente da ridire, ma se lo fa dove vuole lui, allora siamo di nuovo fuori da ogni prospettiva filologica. Mi pare indicativo del suo approccio naïve verso le "riscoperte", il fatto che dove si trovano ancora le vecchie corone ad indicare passaggi ad libitum, la Callas esegua la nota scritta, senza aggiungere gli abbellimenti che pure dovrebbero esserci. Devo anche dirti, già che siamo entrati nel discorso, che ho molte riserve anche sul fatto che il modo di cantare della Callas avesse troppo a che fare con il modo di cantare delle grandi cantanti degli anni 20-40 dell'Ottocento (non parliamo dei soprani rossiniani), tanto è vero che fu magnifica come Tosca e come Gioconda. Un giorno un noto ex critico musicale veneziano mi disse che secondo lui la Callas fu una strana miscela di epoche e stili diversi, e tenderei ad essere d'accordo. In questo senso fu unica. È anche interessante il fatto che le opere che ha "riscoperto" hanno fatto clamore ma non hanno avuto in seguito una gran fortuna, credo proprio perché il loro successo era legato all'elemento aleatorio della sua presenza (anche scenica) e di determinati suoi colpi d'ala, non alla scoperta di una chiave interpretativa che altri potessero raccogliere, com'è accaduto invece poi nel caso delle riscoperte rossiniane, dietro le quali esiste una consapevolezza storica e filologica. Colpa dei direttori? Certo, ma dubito che la Callas avrebbe accettato un direttore che le modificasse la linea interpretativa: forse forse se ci fosse stato Vincenzillo in persona... Scusa la chiacchierata e intanto grazie per i contributi alla voce. Ciao --Al Pereira 02:09, 21 nov 2006 (CET)
Ti rispondo qui (Callas)
Grazie a te per la pazienza e la precisione. Non so se so più di te a riguardo del personaggio Callas piuttosto che della musicista: sicuramente è vero che sul personaggio posso avere idee come ne hanno tutti, mentre non ho competenze di tipo musicale. Ma questo può forse essere utile a indicare quelle formulazioni troppo "tecniche" che finiscono coll'avere un tono indesideratamente limitante. Ti ringrazio di aver pensato ad una formulazione meno perentoria, intanto. Voglio solo ricordare una cosa: la Callas non fu l'unica e sola a riesumare opere. Il Maggio Musicale Fiorentino fu una vera fucina di riscoperte; la Piccola Scala e Palazzo Reale a Napoli, negli anni Cinquanta e Sessanta, anche a prescindere dalla Callas, e comunque prima del suo avvento, ha riesumato titoli numerosissimi titoli sei-settecenteschi, con la Zeani, per esempio (Giulio Cesare di Haendel), la Sciutti (molto assidua) e anche cantanti da grande repertorio, come la Barbieri (a cui ho dedicato una voce, che mancava) e persino la Tebaldi, che all'inizio ha cantato anche di coloratura, etc. Per quanto riguarda il protoromanticismo, non è stato tanto infrequente che cantanti particolarmente interessati a quel tipo di vocalità abbiano riproposto quel repertorio: Lauri Volpi con gli Ugonotti, la Moffo con la Luisa Miller (che è un esempio-limite) etc. La Callas ha fatto la stessa cosa, con una differenza: che dopo di lei i titoli che ha riesumato *sono rientrati* in repertorio, a differenza di quanto avveniva con altri, tant'è vero che ci sono state poi difficoltà a far accettare al pubblico, specie alla Scala ma non solo, interpretazioni delle stesse opere da parte di cantanti diversi. Mi pare oggettivo che la Callas abbia trovato una chiave interpretativa più valida di altri, altrimenti il revival di tante opere vecchie-e-nuove (alcune delle quali francamente inutili, o certamente meno meritevoli rispetto a quelle del repertorio di tradizioni) non sarebbe stato possibile; né l'entrata nel repertorio stabile delle varie Anne Bolene, di Gluck, del Pirata &c.
Attenzione, quindi, a sostenere che
«è interessante il fatto che le opere che ha "riscoperto" hanno fatto clamore ma non hanno avuto in seguito una gran fortuna, credo proprio perché il loro successo era legato all'elemento aleatorio della sua presenza (anche scenica) e di determinati suoi colpi d'ala, non alla scoperta di una chiave interpretativa che altri potessero raccogliere, com'è accaduto invece poi nel caso delle riscoperte rossiniane, dietro le quali esiste una consapevolezza storica e filologica».
Anna Bolena, Ifigenia in Tauride, Macbeth, il Pirata sono opere eseguite con regolarità in ogni contesto. Le opere di Rossini (alla Sigismondo, alla Torvaldo e Dorliska, non esclusi anche -- però -- titoli più importanti; persino Armida e il Turco in Italia, nonostante siano state eseguite [nel sec. scorso] le prime volte dalla C., si sono un po' affossate. Non sarà mica colpa della consapevolezza storico-filologica dei nostri dotti giorni?) sono eseguite, o almeno sono promosse, essenzialmente nei festival rossiniani. Credo che quanto sostieni in questo caso risenta di un punto di vista fin troppo appassionato, che ti porta a vedere nero il bianco e viceversa. Alla Callas conseguono la Gencer, la Sutherland, la Caballé e un esercito di altre. Al Festival di Pesaro che cosa consegue? Che grandi cantanti ha ispirato?
Sono più che d'accordo circa la "strana" mescolanza di stili (già quella misteriosa signorina Santrina, se ben ricordo, le insegnò un impasto di stile italiano e un 'metodo francese' che la C. definiva "attraverso il naso"): ma la sua non era un'impostazione troppo dissimile da una precisa linea di soprani drammatici recenti, basta sentire la Ponselle o la Muzio per sentire una forte "aria di famiglia". Per quanto riguarda la sua parentela, forse troppo ingenuamente rilevata, con le Malibran e le Pasta &c., è chiaramente una schematizzazione. Serviva a dire che la C., per prima, si è trovata *perfettamente a suo agio* in un repertorio che era anche, grosso modo (molto grosso, volendo: la C. non faceva né il Don Giovanni, o la Zauberfloete, tanto per iniziare, ma non certo perché non ne fosse in grado), il loro. Ma non bisogna dimenticare che la Pasta e la Malibran, come, volendo, le Grisi e molte altre cantanti in vista furono interpreti altamente idiosincratiche, fortemente caratterizzate e nient'affatto afferenti ad un "tipo" anche genericamente identificabile. Senza entrare nello specifico delle qualità vocali e interpretative rilevate dai critici all'epoca (sarebbe insulso: bisognerebbe poterle ascoltare, e non si può), c'è almeno da rilevare, e con grande forza, come quelle cantanti facessero, servendosi peraltro di mezzi eccezionali, quindi non "medii" -- non si può dire che "Norma" all'epoca "si cantasse *COSI'*", Norma è un'opera eccezionale scritta per una cantante eccezionale -- grande ricorso a risorse che non limitabili all'àmbito della tecnica di canto. Che poi si stabilissero alcuni canoni interpretativi certi è un fatto. Quanto ai tagli, anche lì è molto opinabile. 'Anna Bolena', per esempio, è un'opera [oggi, per "colpa" della C., in un certo senso, fin troppo rappresentata e incisa] zeppa (ti dico il mio parere) di pagine abbastanza inutili. Scorciata è stata sicuramente trasformata in un'altra cosa, e in una cosa migliore. Almeno, la finalità era questa, ed è una finalità secondo me raggiunta (non ho venerazione per Gavazzeni, tutt'altro, ma nella sua funzione di "tagliator cortese" ha avuto molto spesso tutte le ragioni, e Anna Bolena è stato uno dei casi che, anche non solo secondo me, lo dimostrano). Posso anche capire il taglio dell'aria di Raimondo, che non monda nespole, e della scena della torre (pleonastica, per quanto bella) dalla 'Lucia di Lammermoor'. Sono tagli che tengono conto della tenuta drammatica, che oggi è passata in cavalleria rispetto al problema musicale ma pure è una componente (teoricamente) fondamentale. Già un'Anna Bolena integrale è drammaticamente meno incisiva di una tagliata. Se i tagli sembrano 'goffi' ad un musicista, dal punto di vista drammatico possono essere quanto di più saggio. Bene o male, un'opera è un dramma, racconta una storia, e le lungaggini tolgono molto all'insieme. Ho letto anch'io le lezioni alla Juilliard, la C., ricordo, consigliava di falciare via i torciglioni (ma ricorderò bene?) alla fine della prima cabaletta, li definiva troppo fioriti. In effetti non sono una gran bellezza. Poi, sicuramente, faceva cose che oggi non si farebbero più: nel Turco in Italia ha rinunciato a un da capo, in compenso inserendo una cadenza enorme (anche nell'Armida). Non so se sia da considerare "naif", questo, come rinunciare a mettere un abbellimento dove c'è una corona: so che all'epoca il da capo dava problemi enormi, perché ci si chiedeva (anche Toscanini ha lasciato qualche osservazione in merito) a che scopo ripetere il già detto (con pochissime eccezioni) -- osservazioni che oggi fanno ridere, ma che all'epoca si era portati a fare. La C. doveva tenere conto di un pubblico che tendeva ad avere reazioni allergiche rispetto, in genere, al meccanismo dell'iterazione. Per questo la C. doveva far rientrare certe cose un po' di contrabbando, o di sorpresa. Può essere anche molto istruttivo, volendo, proprio perché oggi non esiste più un'attenzione del genere, che pure ha dato i suoi risultati. d.
- Mi pare che una tua osservazione possa essere il punto di partenza per aggiustare il passaggio: quando noti che l'assenza di rigore filologico era una caratteristica comune ai direttori e agli interpreti dell'epoca. Intendo precisare questa cosa affinché non sembri una peculiarità della Callas.
- Per il resto ci sono questioni su cui non sono troppo d'accordo. Sul fatto che le opere "riesumate" dalla Callas siano entrate in repertorio forse hai dei riscontri statistici che a me mancano. Lasciamo stare Macbeth, che tra l'altro fu diretto niente meno che da De Sabata. Ma davvero si dà così tanto Anna Bolena? Forse hai ragione, ma spero di no! :) O l'Alceste e l'Ifigenia in Tauride di Gluck? all'estero magari.... Se sai di qualche rappresentazione del Pirata invece dimmelo perché ci vado! Tu stesso riconosci che Armida e persino Il turco in Italia ormai non si fanno spesso. Per carità, le ragioni per cui un'opera rientra o no in repertorio possono essere le più svariate, non è certo solo colpa o merito dell'interprete che l'ha riproposta. Ma determinati successi legati alla presenza di un fuoriclasse secondo me restano più nel mito che altro. Altra cosa è riuscire a dare una rilettura organica ad una partitura musicale, ma per questo servono un'edizione fatta come si deve e un direttore che sappia quello che dirige. Chiacchierando di tagli d'epoca, mi è venuta in mente l'eccezione straordinaria di Bernstein che propose alla Scala la Sonnambula pressoché integrale, proprio con la Callas. Mi piacerebbe conoscere i retroscena di quell'evento: se la Callas fu contenta o meno, se piacque l'esecuzione ecc. Certo quella per me è La sonnambula, mentre quella di Votto no (e non solo a causa dei tagli). So che i fautori dei tagli in genere invocano il fattore teatralità, cosa che in parte capisco. Tuttavia persino per fare i tagli bisogna prima conoscere a fondo la partitura per quello che è, lo stile di un autore e le convenzioni di un'epoca, non si può incontrare qualche battuta che non piace e dire "via": perché i pezzi hanno una forma e quella battuta non particolarmente interessante nel contesto è necessaria. Paradossalmente trovo più accettabile l'eliminazione di un'intera scena (tu accennavi a quelle due di Lucia di Lammermoor) che una cabaletta senza ripresa, in genere tenendo la coda alla fine col risultato di avere - per dire - 1 minuto di strofa, 40 secondi di coda e sicuramente acuto sparato alla fine, perché il risultato è goffo, sia in se stesso che nel contesto del numero musicale. Insomma, la musica ha i suoi percorsi e la sua logica. A volte sono stati gli stessi compositori a tagliare, ma nel farlo hanno seguito una logica compositiva. Tu accennavi a Gavazzeni, che a volte è vero ha fatto dei tagli, ma a me è capitato di sentire opere di quel repertorio eseguite da lui in versione quasi integrale. Il suo Pirata è ben altra cosa rispetto a quello con la Callas. Riguardo al Festival di Pesaro, non ti pare che abbia allevato parecchie voci, alcune grandi (non necessariamente italiane e non necessariamente soprani) che hanno cantato quel repertorio in Italia e all'estero? Magari le cose stessero così per altri autori!.... Oggi quando si esegue un'opera di Rossini, anche senza un grande cast, le probabilità che il risultato sia almeno discreto sono elevate, perché si è creato un gusto, nell'ascoltarlo e nell'eseguirlo, grazie allo studio delle sue partiture e all'approccio filologico. Non importa se le singole opere non vanno in scena spesso: è lo stile di un autore che è stato messo a fuoco. Certo, Sigismondo o Torvaldo e Dorliska hanno i loro problemi, ma direi che hai preso due esempi un po'.... particolari ;-) Diverso è il caso degli autori che furono considerati proprio il cavallo di battaglia della Callas, come Donizetti e soprattutto Bellini. Ti faccio un esempio: Abbado è un direttore rigoroso quando esegue Rossini, ma i suoi Capuleti degli anni 60 sono un esempio di tutto ciò che non si deve fare eseguendo Bellini. Evidentemente gli mancava la consapevolezza di cosa sia quella musica e probabilmente gli mancherebbe ancora adesso. Questo non a proposito della Callas ma per dire che senza partire dalla filologia raramente si va lontano. Tornando alla Callas, resto dell'idea che forzò il repertorio belliniano e donizettiano in chiave tardo-ottocentesca: ciò che riusciva ad adattare alla sua visione estetica lo cantava, magari in modo sublime, il resto (o anche i pertichini altrui!) lo ridimensionava o lo eliminava. L'idiosincrasia per le ripetizioni, di cui l'opera del primo Ottocento è piena, mi pare molto indicativa di questa distanza culturale, dato che si trovano tali e quali qualunque fosse stata la prima interprete dell'opera.
- Queste osservazioni comunque restano su queste pagine, nella voce prometto di aggiustare il passo in questione. Ciao --Al Pereira 08:32, 22 nov 2006 (CET)