Friuli
Il Friùli (Friûl in friulano, Forum Iulii in latino, Furlanija in sloveno, Friaul in tedesco) è una regione storico-geografica che corrisponde alle odierne province di Udine, Pordenone, Gorizia. L'appartenenza al Friuli del Mandamento di Portogruaro, in provincia di Venezia e del comune di Sappada, attualmente in provincia di Belluno, pur trovando ampio riconoscimento nella dottrina, non viene universalmente accettata ed è, da lungo tempo, oggetto di discussione[2][3]. Capitale storica e città più importante del Friuli è Udine già sede, in età medievale, del Patriarcato di Aquileia. Se si include il Mandamento di Portogruaro, centri principali oltre a Udine, sono Pordenone (capoluogo di provincia), Gorizia (capoluogo di provincia), Portogruaro, Sacile, Codroipo, Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Tolmezzo.
| Friuli | |
|---|---|
| Friuli (in italiano) — Friûl (in friulano) Furlanija (in sloveno) — Friaul (in tedesco) | |
(dettagli)
| |
| Stati | |
| Regioni | |
| Territorio | Province di Udine, Pordenone e Gorizia. Anche il Mandamento di Portogruaro (VE) e il Comune di Sappada (BL) vengono considerati appartenenti al Friuli storico[1]; taluni ritengono però che tali territori non ne facciano parte. |
| Capoluogo | Udine |
| Superficie | 8,240 km²con il Mandamento di Portogruaro e il Comune di Sappada. Senza le aree menzionate: 7,549 km² |
| Abitanti | circa 1,060,000 con il Mandamento di Portogruaro e il Comune di Sappada (966,000 senza le aree menzionate) (2005) |
| Densità | circa 128 ab./km² |
| Lingue | italiano, friulano, sloveno, tedesco, veneto |
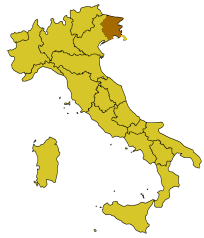 | |
| Sito principale | |
alpestre piano e lagunoso in sessanta miglia da tramontana a mezzodì»
Geografia[4]
La pronuncia corretta di Friuli in italiano è Friùli /fri'uli/ (ovvero con l'accento sulla u). Sebbene alcuni dizionari ed enciclopedie riportino anche la pronuncia alternativa Frìuli /'friuli/ (cioè con l'accento sulla i) va messo in evidenza che questa pronuncia non è in alcun modo presente nel territorio friulano né in quelli limitrofi. Dal punto di vista etimologico, Frìuli non è sostenibile, in quanto non si giustificherebbe lo spostamento dell'accento d'intensità dalla u del nome latino originario (Forum Iulii) alla vocale i breve, derivata da una semivocale anteriore atona.
Il Friuli è delimitato ad ovest dal fiume Livenza, a nord dalle Alpi carniche, ad est dalle Alpi Giulie e dal fiume Timavo, a sud dal Mar Adriatico[5]. Numerosi sono i fiumi che scorrono da nord verso sud. Tra i più importanti, oltre a quelli già citati, il Torre, il Natisone, lo Stella, l'Isonzo, l'Ausa, il Tagliamento. Tutta la parte settentrionale del Friuli è costituita da territorio montano: i suoi più importanti rilievi, da occidente ad oriente, sono: tra le Dolomiti friulane la Cima dei Preti (2703 m), il Duranno (2652 m) e la Cridola (2580 m); tra le Alpi carniche il monte Peralba (2691 m), il monte Bìvera (2474 m) e il monte Coglians (2780 m); tra le Alpi Giulie, lo Jôf Fuârt (2666 m), lo Jôf di Montasio (2754 m), il Mangart (2677 m) e il monte Canin (2587 m), che domina la pianura. Le montagne friulane hanno come spina dorsale il corso del fiume Tagliamento, che all'altezza di Gemona sbuca prima nelle colline che occupano la fascia centrale del Friuli, poi nella vasta pianura alluvionale da esso creata. Un paesaggio tipico della pianura friulana sono i Magredi, zone brulle e piene di sassi (grebanos in lingua friulana) trasportati dal letto del Tagliamento nel corso dei millenni. La pianura è comunemente suddivisa in alta pianura friulana e bassa pianura friulana convenzionalmente delimitate dalla strada Napoleonica che collega le città di Codroipo e Palmanova; a sud di questa strada si estende la zona delle cosiddette risorgive, in cui l'acqua sgorga in modo naturale attraverso delle polle che si trovano sparse un pò dappertutto sul territorio. Tale acqua, prevelata attraverso particolari pozzi detti pozzi artesiani, viene utilizzata anche come sostituto naturale dell'acquedotto. Al termine delle pianure, verso sud, si aprono le lagune di Marano e di Grado, oasi naturali protette, con flora e fauna uniche nel loro genere.
La superficie del Friuli è di 8.240 km², suddivisi tra le province di Udine (4.905 km²), Pordenone (2.178 km²) e Gorizia (466 km²), il Mandamento di Portogruaro (629 km²) e il Comune di Sappada (62 km²). Senza queste due ultime aree la superficie è di 7.549 km².
Una delle prime delimitazioni geografiche del Friuli si ritrova in una sentenza, citatissima, del legato pontificio Ugo da Ostia, il quale nel 1221 fu chiamato a dirimere una controversia tra il Patriarca ed i Trevisani. Il legato stabilì che al Patriarca appartenevano:
“omnia loca, castra, curias, villas, et vicos […] ab Aqua Liquentia usque ad ducatum Meraniae et a montibus usque ad mare per totum Forumjuli” [6].
Ovvero: “tutti i luoghi, castelli, corti, ville e villaggi […] dal fiume Livenza fino al ducato di Merania e dai monti fino al mare in tutto il Friuli.”
Con il secolo XVI i documenti contenenti notizie di tale natura si moltiplicano. Ad esempio tra il 1502 ed il 1503 Marco Antonio Sabellico e Marino Sanudo fissavano i limiti del Friuli al Livenza ed al Timavo[7]. Nello stesso secolo i Luogotenenti della Patria del Friuli, nelle loro relazioni inviate a Venezia, citavano occasionalmente i confini del Friuli. Ad esempio, nel 1529 Giovanni Basadona scriveva che:
“La Patria de la plaga orientale comintia a San Zuan del Carso miglia zinque de là da Monfalcon. Da occidente il territorio de Sacil inclusive. Da septentrione a mezo il ponte de la Ponteba miglia sette de là da la Schiusa. Da ostro il mare”[8]. .
A margine di una carta del Friuli stampata a Venezia nel 1553 compariva un testo esplicativo intitolato “La vera descritione del Friuli”, nel quale si leggeva che:
“La patria antedetta confina da Levante con l’Istria e Iapidia al presente detta Carso, da ponente con il territorio Tervisano, Belunese da Settentrione con l’alpe de Alemagna e, da Meggio giorno con la parte del mare Adriatico quale è tra il porto del fiume Timavo, e Livenza”.
La stessa “Descritione” continua poi citando le città e le fortezze del Friuli, tra cui Udine, Gruaro, Pordenone, Concordia, Monfalcone, Gorizia e Gradisca. Nel 1544 a Venezia venivano pubblicati i Commentarii dei Fatti d’Aquileia di Giovanni Candido. L’autore non fornisce un’esplicita e dettagliata delimitazione geografica del Friuli, ma ne individua, nel primo capitolo, alcuni limiti approssimativi. Egli colloca il confine orientale del Friuli al fiume Timavo. A settentrione il limite sarebbe stato rappresentato dalle Alpi, ma la Val Canale era probabilmente considerata esclusa dal Friuli. Ad occidente Candido comprende nel territorio friulano anche alcune località ad Ovest del Livenza. A Sud il Friuli sarebbe arrivato fino al mare[9]. Sempre cinquecenteschi sono i versi di Erasmo di Valvasone, che così tracciava i limiti geografici del Friuli:
“Siede la Patria mia tra il monte e il mare: Quasi teatro ch’abbia fatto l’arte Non la natura, ai riguardanti appare, E il Tagliamento l’interseca e parte. S’apre un bel piano ove si possa entrare Fra il meriggio e l’occaso, e in quella parte Quanto aperto ne lascia il mare, e il monte, Chiude Livenza con perpetuo fonte”[10]
Nel 1585 il Luogotenente Pietro Gritti nella sua relazione inviata a Venezia scriveva che il Friuli si estendeva:
“dal fiume Timavo nel levante verso l'Istria, e ‘l Carso fino al fiume Livenza verso il Trivigiano in ponente”[11].
Il suo successore Stefano Viaro nel 1599 era più preciso nella sua descrizione, in quanto sosteneva che il Friuli:
“ha sette confini. Verso ponente il suo confin è a Termine, il secondo verso ostro, confina alla Trinità, e dal detto capo della Livenza fino dove entra in mare termina la Patria, il terzo confina verso levante, fino a San Giovanni di Capo di Ponte, il quarto confina a Tolmino, il quinto alla Porta Plezziana, il sesto alla Ponteba, et il settimo confina con il monte di Sezis, dove scatturisce la Piave, e di lì poi va a Termine, et là finisce la Patria”[12]. .
Pochi anni più tardi l’umanista Partenopeo individua i confini del Friuli rifacendosi ad alcuni limiti amministrativi di età romana:
“Questa Regione del Friuli […] dall’Oriente hà per termine il fiume Risano, che già fù detto Formione, il quale divide da questo lato l’Istria dal Friuli. Dall’Occidente hà per termine il fiume Limino. Avvertendo però, che se bene il termine è stato così da Moderni diviso per cognitione de i luoghi, che si contengono nella Marca Trevigiana; nondimeno l’antico, et vero confine della Patria del Friuli s’intende il fiume detto Sile […]. Dal Borea hà per confini gli alti monti Iapidi; che dividono l’Italia dalla Germania; et da mezo giorno hà il mare Adriatico”[13]
Alla Fine del Settecento Pietro Maniago, in un suo poemetto, descriveva in modo allusivo i confini del Friuli:
“ […] in questo suolo, Che da Giulio si noma, il cui confine Segna due fiumi [Livenza e Timavo], e l’alpe chiude e ‘l mare”[14].
Dalle descrizioni appena citate emergono una serie di considerazioni interessanti. In primo luogo è bene osservare che i confini non seguono mai criteri linguistici, etnici o definiti in base a qualunque altra caratteristica culturale. Essi, tuttavia, non sono neppure di carattere strettamente amministrativo, in quanto queste descrizioni dei confini del Friuli sembrano non prendere in considerazione le divisioni politico-amministrative posteriori al 1420[15]. . Infine, se è vero che vi è una certa costanza nel prendere come punti di riferimento il Livenza, il Timavo, le Alpi ed il mare, si registrano alcune oscillazioni del confine orientale e di quello occidentale. Alcune volte il Friuli viene esteso oltre questi confini. Ad esempio Flavio Biondo e Leandro Alberti estendono il Friuli ad occidente fino al Lemene, mentre il Biondo ne sospinge il limite orientale fino al fiume Risano in Istria[16]. . Entrambi gli autori, tuttavia, scrivevano senza conoscenza diretta del territorio e trattavano del Friuli in opere non ad esso specificamente dedicate. Le loro delimitazioni del Friuli, pertanto, non sembrano meritare ulteriore attenzione.
L’interpretazione di un goriziano della fine del Seicento era tutto sommato coerente con le precedenti. Infatti, secondo Gaspare Brumatti de Jacomino e Sigisberg la Contea di Gorizia comprendeva territori che facevano parte del Friuli (la parte occidentale della Contea, Gorizia inclusa) e terre del Cragno:
“Io lo [il Contado di Gorizia] giudico un misto di parte del Cragno, e parte del Friuli, e così parte Schiavo, parte Forlano, medio frà il residuo dell’uno, e dell’altro, poiché à Levante, Tramontana, e Mezzogiorno, confina con il Cragno […] et a Ponente, confina col Friuli, e pur da quella parte, è circondato da esso, né si può per mio sentimento, dire, che il Cragno si stenda sin à dove questo Contado s’interna nel Friuli, con tutto assai più à dentro d’esso, [né] per contrario, che il Friuli giunga sin dove, à drittura, et attorno, penetra nel Cragno; ma piuttosto, che da dove comincia nel Cragno, à drittura, et attorno, sino à Gorizia sij parte del Cragno, e da dove principia dal Friuli sin pure à Gorizia, sij parte del Friuli, come mostra d’aver inteso anche il Moisesso nella situazione, che ci fà di Gorizia nella parte di Levante, sui fini della Patria e dell’Italia in detta Historia dell’ultima Guerra nel Friuli: lib 1 Can. 2 e si raccoglie anche dall’uso delle lingue, appunto da Gorizia verso il Cragno, à drittura, et attorno, Schiava, e da Gorizia verso il Friuli, precisamente Forlana”[17]
Sempre in relazione ai confini, va, infine, segnalata l’opera di Girolamo da Porcia, il quale nel Cinquecento aveva redatto una Descrizione della Patria del Friuli. A proposito di Gorizia il da Porcia scrive che essa:
“per essere di là del Lisonzo, però solamente mezo miglio, è riputata fuori d’Italia; ma i più la tengono in Friuli, ed è spiritualmente sotto Aquileia”[18].
L’opera del periodo prerisorgimentale in cui è più ampiamente affrontata la questione dei confini è il “notizie delle cose del Friuli” di Gian Giuseppe Liruti. L’autore approfondisce l’argomento in modo a tratti moderno, nel senso che egli fornisce una descrizione diacronica dei confini del Friuli, evidenziandone gli spostamenti nel corso dei secoli. Ma l’aspetto potenzialmente più moderno dell’analisi di Liruti risiede nel fatto che egli opera una distinzione tra confini geografici e politici del Friuli, dedicando a ciascuno di essi un capitolo separato. Per quanto riguarda i confini politici del Friuli, Liruti osserva che essi “si andarono cangiando, secondo che si andava cangiando la maniera del governo”[19]. Tuttavia, la modernità dell’approccio di Liruti rimane solo potenziale, in quanto ciò che differenzia i due capitoli non è il criterio differente cui fanno riferimento per definire i confini. Infatti il capitolo dedicato ai confini geografici in realtà tratta dei confini amministrativi in epoca preromana e romana, mentre quello riguardante i confini politici è dedicato ai confini ed agli organi amministrativi della tarda antichità e del Medioevo. Secondo Liruti in epoca preromana, quando il Friuli era dominato dai Veneti:
“questa provincia fu compresa nell’antichissima Venezia […] aveva essa a levante in confine Geografico, che mai ad essa sino al giorno d’oggi si mutò, per poco con l’Istria, e quasi interamente con la Giapidia, o sieno i monti, che ora chiamiamo del Carso; a mezzodì ebbe pure, come sempre, il Mare Adriatico; a settentrione quello dell’Alpi; ed all’occaso con Padova quello de’ Galli”[20].
Se al tempo dei Romani i confini del Friuli rimasero immutati, con i Longobardi furono:
“alterati i confini da due parti, dal Settentrione, e dall’Occidente; né mi è avvenuto di sapere, quando la variazione avvenisse verso Settentrione, inoltrandosi questo confine non poco dentro dell’Alpi. […] Non solo verso Settentrione nell’Alpe i nostri confini erano accresciuti, ma anche verso Occidente oltre la Livenza si aggiunse al Friuli non poco particolare Territorio”[21].
Con la conquista del Friuli da parte dei Franchi il Ducato del Friuli, trasformato in Marca, avrebbe finito con l’includere anche parte della Carinzia e dell’Istria[22].
Non deve sorprendere che il periodo in cui i confini del Friuli sono stati definiti in modo più chiaro e senza che sorgessero dubbi sul loro tracciato sia proprio quello precedente al 1866. La ragione di ciò è del tutto estranea alle Guerre di Indipendenza italiane, ma va ricercata nel fatto che, prima della coniazione del termine Venezia Giulia da parte del linguista Graziadio Isaia Ascoli, esistevano nell’area nord-orientale d’Italia una serie di regioni storico-amministrative ben individuabili. Una di queste era il Friuli, i cui confini venivano individuati in modo del tutto simile da una pluralità di autori. Il primo di essi, Giuseppe Girardi, che scriveva animato da evidentissimo patriottismo, lamenta il fatto che dopo la conclusione dell’epopea napoleonica il Friuli amministrativo fosse limitato ad Est dal Judrio:
“Si attende però dalla Sovrana Sapienza che vengano rettificate quelle linee ove dai privati riguardi, anziché dal pubblico bene, fossero state parzialmente dirette”[23].
A Pacifico Valussi, invece, va senz’altro attribuita la responsabilità dell’applicazione al Friuli del concetto di “regione naturale” o “provincia naturale”. Egli, segnalando l'importanza degli studi statistici annota:
"E quando trattasi d'una naturale Provincia, la quale forma un tutto da sé, sotto molti aspetti diverso da tutto ciò che lo circonda, come è il caso del Friuli, la statistica deve essere la più completa possibile e discendere alle più minute particolarità"[24].
Egli riprese il concetto di ‘provincia naturale’ in più occasioni, ad esempio nel redigere le considerazioni relative ai confini ed alla popolazione del Friuli contenute nel rapporto della Camera di Commercio del Friuli[25] stampato per il governo austriaco. In relazione alla delimitazione geografica del Friuli Valussi scrisse che:
“Questa è una statistica approssimativa della popolazione della Provincia naturale; cioè della Provincia amministrativa, colla giunta del Distretto di Portogruaro e della parte del Circolo di Gorizia che sta dentro i confini del Friuli” [corsivo nell’originale][26].
Nel 1883 Valussi mise per iscritto una delle prime citazioni della definizione del Goriziano come Friuli “al di là dal clap ”[27]. È interessante notare come tale espressione, utilizzata nell’Ottocento con finalità di rivendicazione irredentista, avrebbe perso completamente tale accezione nel secolo successivo. Giulio Andrea Pirona, nel 1855, riprendeva la definizione classica del Friuli in un passo che è probabilmente l’ultimo scritto in latino a questo proposito:
“Forijulii Regio plagam Italiae septentrionalis ad orientem tenens, intra certos fines, tum soli figura tum aeris temperie, ideoque et specie adeo est varia, ut quam maxime naturalis philosophiae cultorum studiis commendanda videatur. Aquilonem versus circumscripta Alpibus Juliis seu Carnicis in semiorbem procurrentibus, in grande panditur amphitheatrum, cuius latera ad occidentem Mons Caballus cum Liquentia flumine, ad ortum Montes Japidici cum Timavo novem capitibus exurgente perstringunt, ad Meridiem Adriaticus sinus adlambit”[28].
Ippolito Nievo, quando nel 1857 a Milano pubblicava Il Conte Pecoraio, scriveva che il Friuli:
“comprende, ne’ suoi confini naturali: la regione fra Livenza e Tagliamento con S. Vito, Pordenone e Portogruaro; il pedemonte e la pianura fra il Tagliamento, l’Isonzo e il mare, con Udine, Cividale, S. Daniele, Gemona, Palmanova e Latisana; la montagna superiore a tutte queste fiumane, soprannominata la Cargna; le vallate fra Tagliamento ed Isonzo, nelle quali son chiusi i comuni slavi del Friuli, divisi nelle due popolazioni disparatissime per indole, dialetto e costumi, di Resia e di S. Pietro; parte della Contea di Gorizia colla città di questo nome che parla una varietà del friulano; finalmente il così detto Territorio fra Isonzo, il Carso Triestino ed il mare, con Gradisca, Monfalcone, Aquileia e Grado, già appartenente alla Repubblica di Venezia ed ora con tutta la Contea di Gorizia aggregata al Regno Illirico. I distretti alpini del Cadore e del Comelico stettero altre volte col Friuli”.
In breve, Nievo intendeva per Friuli la terra tra la Livenza ed il Carso, tra le Alpi Carniche ed il Mare. È interessante notare come Nievo, per definire il confine orientale, adotti criteri diversi tra loro e contraddittori: egli include esplicitamente i comuni sloveni dell’attuale Udinese, ma esclude quelli slavi della Contea di Gorizia, della quale considera friulana solo la parte neolatina. Il goriziano Comelli, scrivendo dei confini del Friuli Orientale, li individuava tra nel Timavo e nell’Aussa, includendo però le valli dell’Isonzo e del Vipacco. In tal modo il Friuli Orientale veniva fatto quasi coincidere con la Contea di Gorizia<refComelli F. (1989), Il Friûl Orientâl, in: Friûl di Soreli Jevât, Udine, Società Filologica Friulana, s.p.n.</ref>. Un’opinione del tutto analoga è rintracciabile nelle opere di Prospero Antonini, storico friulano di sentimenti patriottici italiani[29]. Nella seconda metà dell’Ottocento egli aveva pubblicato due opere nelle quali forniva una delimitazione geografica piuttosto precisa del Friuli:
“I suoi [del Friuli] limiti appariscono segnati dalla natura, comeché da un lato il monte Cavallo onde ha origine la Livenza si stacchi dalle alpi Carniche a guisa di contrafforte, e dal lato opposto le ultime giogaie delle Giulie sovrastino tra Monfalcone e Duino alla fonte del Timavo. […] Il Friuli naturale, dedotto il Distretto di Portogruaro, ora compreso nella provincia di Venezia, abbraccia nella sua totalità la provincia di Udine propriamente detta, e la Contea di Gorizia quasi per intero, ed eccettuati i territori carsici di Duino, Comeno, Sesana che, posti al di là del Timavo, geograficamente spettano alla penisola Istriana”[30].
Pochi anni più tardi lo stesso autore ribadiva che:
“La regione geografica del Friuli misura in superficie circa 915 chilometri quadrati. Ne fanno parte, oltre tutta la provincia di Udine, undici distretti della Contea di Gorizia [riportati in nota: di Gorizia città, di Gorizia circondario, di Aidussina, di Canale, di Gradisca, di Cervignano, di Cormonsio, di Monfalcone, di Tolmino, di Plezzo e di Chirchina; i distretti goriziani di Sesana e di Coma appartengono geograficamente alla Carsia, ossia all’Istria montana, perché posti al di là del Timavo; l’isola di Grado poi fu sempre considerata come parte non del Friuli bensì del Veneto estuario e del Dogado, il quale estendevasi alle foci dell’Isonzo e Capodargine] e quasi per intero il distretto di Portogruaro oggi appartenente alla provincia di Venezia”[31].
Per quanto riguarda il confine settentrionale del Friuli, va ricordato che esso si configurava come uno dei più stabili d’Europa, essendo rimasto immutato già dall’epoca dello stato patriarcale friulano. Inoltre al di là del confine settentrionale del Friuli non erano insediati gruppi che, per le loro caratteristiche linguistiche, potessero far sorgere delle rivendicazioni irredentiste. Per questi motivi ad esso non si dedica particolare attenzione. Ci è stato possibile ritrovare solo un passo significativo dedicato a tale confine. Valussi scrisse, infatti, che:
“Pontebba, o meglio il fiume Fella che divide in due il paese portante questo nome, segna il confine fra il Friuli e la Carinzia, fra Italiani e Tedeschi, in modo marcatissimo”[32].
È interessante notare che, come Valussi riteneva evidente che la Val Canale non facesse parte del Friuli, vi sono indizi che cent’anni più tardi si sarebbe ritenuto evidente l’opposto.
Nel corso del tardo Ottocento le descrizioni dei confini del Friuli avevano abitualmente un valore politico ben preciso: l’affermare l’unità del Friuli Occidentale ed Orientale era un argomento portato per rafforzare le rivendicazioni irredentiste. All’epoca parlare dei confini del Friuli significava parlare dei confini d’Italia e la ricerca di una legittimazione storica dei primi era funzionale alla rivendicazione politica dei secondi:
“Che le Alpi Giulie siano state sempre confine d’Italia e del Friuli da questo lato ce lo dice la storia”[33].
Proprio perché funzionale alle rivendicazioni irredentiste, la definizione dei confini del Friuli si concentra più su quello conteso –cioè quello orientale- che sugli altri. Un tempestivo esempio di ciò venne dato dalla Congregazione Provinciale di Udine che, nel 1866, chiese che tutto il Friuli, compreso quello Orientale, venisse incluso nel Regno d’Italia. A sostegno della sua richiesta espose quali fossero i confini del Friuli:
“Questa linea sarebbe quella che comprende tutto l’antico Friuli, lungo la cima dei monti Predile, Terglou, Cucco ec., lasciando al Friuli tutta la sua valle dell’Isonzo, e degli affluenti suoi che sono l’Idria, ed il Vipaco fino al villaggio di questo nome, e fino al Prewald, poi tirando una linea possibilmente retta dal Monte Nanos o Monte Re alla foce del Timavo di qua di Duino”[34].
Una delle definizioni più puntuali dei confini del Friuli è contenuta nelle prime pagine del Compendio di Storia Friulana pubblicato dall’udinese Francesco di Manzano nel 1876. Egli sostiene che:
“[la Regione Friulana] è confinata al Nord dalle alpi carniche e giulie; all’Est dalle valli dell’Isonzo e del fiume Vipaco, dai poggi della Carsia inferiore e dalle fonti del Timavo; al Sud ha confine il mare Adriatico; all’Ovest la valle superiore del Piave e i monti che inferiormente ne circoscrivono il bacino, e la Livenza dalle sorgenti al mare. […] Ne fanno parte oltre i 17 distretti della Provincia di Udine (Udine, S. Daniele, Spilimbergo, Maniago, Sacile, Pordenone, S. Vito, Codroipo, Latisana, Palma, Cividale, S. Pietro, Moggio, Ampezzo, Tolmezzo, Gemona, Tarcento), gli 11 della contea di Gorizia (Gorizia, Aidussina, Canale, Gradisca, Cervignano, Cormons, Monfalcone, Tolmino, Plezzo e Chirchina, Sesana e Comen), e quasi per intero il distretto di Portogruaro, che oggidì appartiene alla provincia di Venezia”[35].
La definizione del di Manzano è, quindi, squisitamente storico-amministrativa, nel senso che il Friuli sarebbe la somma della Contea del Friuli e della Contea di Gorizia. Il criterio linguistico che pochi anni prima aveva spinto Ippolito Nievo ad escludere dal Friuli le aree slovenofone della Contea di Gorizia sembra non essere presente in di Manzano. In relazione al criterio linguistico nella definizione del Friuli, Micelli ha segnalato che dopo il 1873 –anno di pubblicazione dei Saggi Ladini dell’Ascoli, si sarebbe registrata in Giulio Andrea Pirona una tendenza a prenderlo in considerazione per definire i confini della Provincia di Udine[36]. In effetti dopo tale data si annoverano alcune citazioni dei confini del Friuli dal Livenza all’Isonzo. Per citare solo due esempi provenienti proprio dalla zona più direttamente interessata, il goriziano, troviamo che nei versi di Giuseppe Ferdinando Del Torre si legge:
“[…] dall’Alpe al mar, Dal Livenze allis spondis dal Lusinz ”[37].
Ancora, nel 1903, nell’introdurre il proprio volumetto intitolato Idrografia del Friuli Orientale il goriziano Paolo de Bizzaro, riteneva che sarebbe stato più proprio limitare il nome di Friuli Orientale alla sola parte pianeggiante del Goriziano:
“Il paese trà le Alpi Carniche e Giulie a Settentrione, gli estremi declivî del Carso a Levante, il fiume Iudrio a Ponente ed il bel mar Adriatico a Mezzogiorno, che da alcuni si disegna [sic!] col nome di Friuli orientale, non corrisponde perfettamente a questo appellativo, che denota solamente la pianura, mentre la nostra provincia comprende anche la regione montuosa [sic!]”.
Il di Manzano dedicò uno specifico scritto alla questione dei “confini del Friuli e della sua nazionalità”. In tale articolo egli cercava di dimostrare come, dal punto di vista storico, i confini orientali del Friuli (cioè d’Italia) fossero sempre stati ben definiti ed avessero incluso il Goriziano. Secondo l’autore i limiti territoriali del Friuli sarebbero rimasti praticamente invariati già dal primo millennio a.C.:
“a’ tempi dell’antica nazione italiaca de’ Veneti […] i confini del nostro Friuli, per lunga serie di secoli anteriori la dominazione romana, furono sempre: a settentrione, al sommità delle Alpi; a levante ed agreco, le Alpi ed il Timavo; a mezzodì, l’Adriatico, ma quale che fosse il confine dalla parte di ponente non ci è dato di poter rilevare […] anche i Gallo-Carni […] presero possesso delle Alpi storicamente chiamate Venete cui essi tennero sempre, nel lungo tempo che qui si stanziarono, siccome confini naturali della Provincia nostra […] sappiamo che ai tempi di Giulio Cesare e di Augusto il territorio Aquileiese (cioè il nostro Friuli) avea i seguenti confini: a settentrione le Alpi, a oriente il Timavo, a occidente il Tagliamento, a mezzodì l’Adriatico. […] Avvenuta poscia nel 586 l’invasione dei Longobardi, questi istituirono allora in Ducato Forogiuliese il nostro Friuli, i di cui confini estenderonsi nel piano dalla Livenza all’Isonzo e dall’Adriatico al Monte Croce nella Carnia: ne’ monti abbracciarono il Norico Mediterraneo (che ora fa parte della Carintia) piegando anche verso l’Adriatico fino al Medalino, monte dell’Istria bagnato da quel mare. L’allargamento de’ confini a settentrione e a mezzodì fatto con la fondazione del Ducato Forogiuliese, non tolse al Friuli i naturali ed antichissimi confini di cui parlammo […] nel 592 comincia una nuova era per la Provincia nostra, sì riguardo ai confini e sì in parte riguardo agli usi e ai costumi; e ciò avvenne a motivo della separazione fatta da Ottone il Grande della Marca Veronese e Friulana dal Regno d’Italia […]. Cangiamento questo sommamente notevole, perché se non tolse la nazionalità ai popoli friulani, ne modificò alquanto però i costumi e gli usi, e mutò nei nuovi confini politici i confini naturali del Friuli, che per immemorabili secoli segnarono sempre anche i limiti d’Italia da questo lato, protraendo quelli della Germania, e poi dell’Austria, sul suolo Friulano, che con varie alterazioni durarono e durano tuttora. E qui, quantunque […sia ] probabile che a questo tempo i duchi suddetti [di Baviera e di Carintia] prendessero ad occupare i paesi dell’Isonzo, pure le grandi concessioni e donazioni fatte dagl’Imperatori e Re di Germania ai Patriarchi e al Patriarcato d’Aquileja […] valgono a comprovare quasi completamente esteso nel Friuli orientale il dominio dei Patriarchi e quindi la nazionalità friulana nei secoli XI e XII. […] E diciamo inoltre che fino alla metà del secolo XII pochi e non importanti cangiamenti alterarono i confini del Friuli”[38].
Un chiaro intento irredentista è reperibile anche in una delle prime guide turistiche del Friuli mai pubblicate. In essa spazio è dedicato, oltre alle località della Provincia di Udine, anche a Concordia, a Portogruaro ed al Goriziano. Di esso Valentinis scrive:
“Ancora soggetto all’Austria è il Friuli orientale (contea di Gorizia e Gradisca) in cui vivono 76.514 italiani, parlanti il friulano o il veneto. Il Friuli redento forma la Provincia di Udine […]”[39].
Accanto alle definizioni di carattere storico, che assegnavano al Friuli i territori compresi in unità amministrative più o meno antiche, esisteva anche una tendenza ad individuare dei confini orografici del Friuli. L’accento era posto in particolar modo sulle Alpi, che si voleva costituissero il confine naturale d’Italia. Così ad esempio Antonini, attualizzando un passo dell’opera di Tito Livio, considerava:
“le Alpi il confine insuperabile tra l’Italia e le genti barbare” (Antonini 1873: 25),
e l’irredentista triestino Giuseppe Caprin disse che esse:
“serrando il nostro paese ne determinano fisicamente il confine. Si disegnano sull’orizzonte come fossero schierate in fila. Sembra che, nascondendoci ogni altro lembo di paese, vogliano obbligarci a non guardare che il nostro” (Caprin 1895),
mentre il goriziano Seppenhofer condivideva l’idea di Antonini nel considerare le Alpi una:
“maestosa barriera messa da Dio per dividere i popoli latini dalla altre schiatte nordiche” (Seppenhofer 1895: 20).
Una delle definizioni geografiche più dettagliate del confine orientale del Friuli viene da un opuscolo goriziano del 1901, nel quale si sosteneva che:
“i suoi confini, anche politici, verso il Cragno, sotto tutti i dominii che ha dovuto subire, sono presso a poco rimasti sempre li stessi; cioè il vertice delle Alpi Giulie, ossia lo spartiacqua tra la vale [sic!] dell’Isonzo, del Vipacco e del Timavo, e quella della Sava” [corsivo nell’originale] (Latini e Slavi… 1901: 7).
Nella fase che inizia con la Prima guerra mondiale la definizione geografica del Friuli inizia a prospettarsi come gravida di possibili conseguenze pratiche, e non più solo come una forma di rivendicazione territoriale. Infatti, poiché l’annessione della Contea Principesca di Gorizia e Gradisca al Regno d’Italia diveniva possibile, la delimitazione dei confini del Friuli poteva avere delle conseguenze amministrative. Dei confini del Friuli era ovviamente possibile dare delle definizioni in base a criteri diversi. Possiamo individuare tre criteri principali: geografico-naturale, linguistico, storico. Il primo criterio, che pareva essere invocato nelle fasi precedenti, era formulato in base a criteri fondati sulle scienze naturali, soprattutto la geografia. Il secondo criterio, che non fu mai invocato con particolare convinzione per delineare i confini del Friuli, era basato su un tratto culturale importante quale la lingua. Il terzo, che era ed è quello maggiormente utilizzato, tendeva a presentare come confini del Friuli quelli delle unità amministrative del passato. Il ricorso ad uno dei tre criteri appena citati non escludeva il contemporaneo utilizzo anche degli altri in funzione di supporto. In generale, anzi, si può facilmente comprendere come il confine risulti tanto più legittimato e chiaro quanto più l’applicazione dei tre criteri da risultati uguali. Pier Silverio Leicht fornì una definizione esclusivamente storica dei confini del Friuli. Egli, innanzi tutto, distingue tra lo stato patriarcale (che comprendeva, oltre alla Contea del Friuli, per alcuni periodi anche Trieste, Carniola ed Istria) e la Contea del Friuli. Di quest’ultima egli scrisse che:
“Il suo confine occidentale è segnato dal fiume Livenza che la divide dalla Trivigiana. Questo limite fu stabilmente fissato nel 1221 […] Il confine settentrionale segue il crinale dei monti che separano il bacino del Tagliamento da quelli del Piave e della Gail […]. Verso oriente la contea Friulana confina in primo luogo colla contea di Gorizia. Quali fossero, storicamente, i veri rapporti del patriarcato coi conti Goriziani non è chiaro. I conti riconobbero, nel 1150 e nel 1202, che la signoria di Gorizia e quella di Mosburg (in Carinzia) erano feudi della chiesa Aquileiese ed ammisero la reversione alla chiesa stessa in caso di estinzione della loro famiglia; nelle successive investiture, però, tale punto non è chiaramente definito e, di fatto, dalla seconda metà del secolo XIII essi si comportano come principi affatto indipendenti. La contea estese, per successive usurpazioni, il suo dominio, occupando successivamente Lucinico e Cormons dal lato occidentale, e dal lato orientale Vipacco, che erano patriarcali. Altri tentativi dei conti per estendere il loro possesso nell'alta valle dell'Isonzo furono respinti, così che i possessi comitali rimasero limitati ad occidente dal fiumiciattolo Judri, e più giù dal territorio di Aquileia, e ad occidente dall'Isonzo, oltre il quale si stendeva il territorio patriarcale di Monfalcone, mentre a nord confinava col territorio, pure appartenente alla chiesa Aquileiese, di Tolmino. I possessi patriarcali confinavano poi nell'alta valle dell’Isonzo con quelli delle chiese di Bressanone e di Frisinga, e ad oriente di Monfalcone con possessi della casa d’Austria nella Carniola. A mezzodì poi, il territorio della contea Friulana era limitato, verso il mare, dai possessi Veneziani dell’estuario di Grado” (Leicht 1917: XIX-XXI).
Pochi anni più tardi Leicht, al fine di sostenere la tesi della necessaria unità del Friuli Orientale ed Occidentale, faceva coincidere confini storici e glottologici. Sostenendo tale coincidenza Leicht voleva evidentemente rafforzare l’idea della chiarezza e della legittimità di tali confini:
“quando si rappresentano i limiti della parlata Friulana, quali si trovano nei tempi più prossimi a noi, coi confini del patriarcato Aquileiese, si vedrà che essi coincidono quasi perfettamente. Dalle porte di Monfalcone sino alla Livenza si parla il Friulano, come dal passo di Montecroce sino alla pianura di Aquileia” (Leicht 1920: 6).
Anche Giradini, sebbene il suo pensiero avesse conosciuto una svolta conservatrice e nazionalista, concorda con la definizione storica di un Friuli dal Livenza al Timavo. Nel 1923 egli, infatti, dalle pagine de Il Giornale di Udine dichiarava che:
“Io non consento affatto a considerare il Friuli come una provincia facente parte di una regione presieduta da Trieste: questo […] sarebbe un arbitrio rispetto alla geografia ed una invenzione rispetto alla storia […]. Il Friuli non è la Venezia né da una parte né dall’altra, il Friuli è il Friuli: il Forum Julii raccolto nel nucleo suo primo e infrangibile, che dovrebbe andare dal Livenza, al virgiliano Timavo” (Girardini 1923 in Nazzi 1990: 20).
In un certo senso ‘storica’ è anche la definizione che l’irredentista Carlo Battisti dà della Venezia Giulia. Tuttavia il punto cronologico che egli assume quale riferimento per individuare i confini di tale area è diverso da quelli invocati dagli autori appena citati. Infatti Battisti nel 1920 sostiene che la Venezia Giulia includeva tutti i territori appena conquistati dall’Italia (Val Canale, Contea di Gorizia, Marca dell’Istria, Trieste), nonché Fiume (Battisti 1920: 1). La Venezia Giulia definita in questo modo aveva delle ampie aree di sovrapposizione con il Friuli così come concepito da molti autori contemporanei a Battisti.
Altre definizioni del Friuli tendono a propendere per una descrizione dei confini del Friuli in termini più orografici, come ad esempio quella di Chiurlo, secondo cui:
“Le Alpi, che […] tendono ad abbracciare da tre lati un’ampia pianura, troncata fra oriente e mezzogiorno dal mare, segnano i limiti della regione friulana; ché dai lati ove resta aperta, a oriente sorge, aspro contratto spugnoso, il Carso, a occidente il corso del Livenza […]” (Chiurlo 1922: 5).
Anche lo scarno riferimento di Tellini ai confini era di carattere geografico, nel senso che non ricorreva a motivazioni storiche ma solo idrografiche. Egli, infatti, nel 1924 pubblicava, per i tipi di Trevisini di Milano, una serie di tre eserciziari friulani per le scuole elementari, intitolati:
“Dal Peralba ad Aquileia e dal Livenza all’Isonzo” (Michelutti 1989: s.p.n.).
Se il cenno di Tellini ai confini ci può sembrare di tono neutro e quello di Girardini incentrato su un tema –quello della distinzione tra Friuli e Veneto- che all’epoca non aveva la rilevanza che avrebbe assunto in futuro, altri testi dell’epoca testimoniano, invece, quanta e di che natura fosse l’importanza della questione dei confini del Friuli in quei decenni. Infatti essa era rilevante in quanto era in stretta connessione con il problema dei confini esterni d’Italia. Ciò significa che la maggior parte delle volte l’attenzione era concentrata, come si vedrà tra poco, sul confine orientale del Friuli, percepito come una barriera politica, culturale, linguistica, folkloristica e quant’altro. Sul confine occidentale si trovano invece solo alcuni cenni nei documenti che riguardano le richieste di costituzione del Friuli in Regione. Ad esempio nel 1915 Girardini, per presentare il Friuli agli italiani, ne tracciava i confini nel modo seguente, operando una commistione di criteri geografici e storici:
“Le Alpi Carniche, le Giulie che ne formano la ramificazione meridionale, i brulli e rocciosi monti che dalle Carniche si staccano e si protendono verso nord–est e che si chiamano i monti del Carso, chiudono la regione detta anticamente dei Carni, poi aquileiese e nel Medioevo terra Fori Julii, ora Friuli, che ha per naturali suoi limiti al nord dette Alpi, ad est la valle del Vipacco e le fonti del Timavo, a sud l’Adriatico, ad ovest la valle superiore del Piave, i monti che inferiormente ne circoscrivono il bacino ed il Livenza dalle sorgenti al mar […]” (Girardini 1915).
Nel 1919 il Commissario governativo per la Provincia di Udine aveva scritto a Girardini una memoria in cui gli esponeva le proprie opinioni sul futuro assetto amministrativo del ‘Friuli redento’. In tale memoria, inedita a parte brevi stralci, sono contenute alcune considerazioni iniziali sul
“Friuli fra il Timavo e il Livenza” (Preziosi 1987: 123),
che doveva essere riunito in una sola Provincia.
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, la definizione del territorio della regione di cui si chiedeva la costituzione era ovviamente un argomento inevitabile all’interno dell’Associazione per l’Autonomia Regionale Friulana. Prima ancora di definire che cosa fosse il Friuli, l’Associazione per l’Autonomia Regionale Friulana nel suo statuto specifica da che cosa esso si distingue:
“il Friuli costituisce un’entità regionale assolutamente distinta dalle limitrofe regioni veneta e giuliana” (Comelli 1983: 141-142).
Tessitori e l’Associazione per l’Autonomia Regionale Friulana chiedevano la creazione di una regione che comprendesse i territori delle Province di Udine e Gorizia, nonché del cosiddetto Mandamento di Portogruaro (Comelli 1983: 141). Più nel dettaglio, già nel 1945 si dice che:
“[L’Associazione per l’Autonomia Regionale Friulana] vuol ottenere, insieme con l’auspicatissimo decentramento amministrativo, il riconoscimento della qualità di regione del Friuli, che non deve costituire più una semplice provincia: il Friuli dalla Mauria a Grado, da Sacile a Gorizia” (D’Aronco 1988: 11).
Il Comitato di Studio sulla Regione del Friuli, nella sua monografia pubblicata nel 1946, auspicava che la regione fosse costituita entro i confini:
“delineati dal corso dei due fiumi Livenza e Timavo, comprendendo così le intere province di Udine e Gorizia, con più il distretto di Portogruaro, che attualmente è parte della provincia di Venezia” (Coloni 1982: 168).
Nello statuto del Movimento Popolare Friulano, redatto nel 1947, emerge, come si è accennato in precedenza, il richiamo ai “confini naturali” del Friuli. Essi vengono identificati con i confini “storici della Patria del Friuli: il Livenza a ovest (includendo quindi il cosiddetto mandamento di Portogruaro, appartenente alla Provincia di Venezia) e il Timavo a est” (Di Giusto 1997: 457-458). Il leader del Movimento Popolare Friulano, D’Aronco, già dal 1946 mostra di condividere l’idea che il Friuli sia nettamente distinto dal Veneto e dalla Venezia Giulia:
“La realtà della Regione friulana è sancita dalla storia. Il Friuli non è né Venezia Euganea né Venezia Giulia, ma una regione a sé stante” (D’Aronco 1988: 19),
e scegli e i consueti quattro elementi del paesaggio come confini del Friuli:
“[…] i monti e il mare, la Livenza e il Timavo” (D’Aronco 1988: 19).
Va ricordato che la possibilità di includere il Portogruarese nella Regione Friulana era stata discussa anche dall’Assemblea Costituente, per essere ben presto esclusa (D’Aronco 1983: 72). Anche la Società Filologica Friulana condivideva la delimitazione territoriale del Friuli proposta dagli altri movimenti regionalisti. Ciò è reso esplicito, tra l’altro, nell’ordine del giorno del congresso del 29 settembre del 1946, in cui i soci:
“[…] auspicano la ricostituzione integrale della Patria del Friuli con i territori di Udine, di Gorizia con Grado e Monfalcone, di Pordenone incluso il territorio di Portogruaro” (Comelli 1983: 149).
Se questo è il brano più significativo –in quanto collega la delimitazione geografica del Friuli alla questione della costituzione della Regione- esistono numerosi altri passi che esplicitano la posizione della Società Filologica Friulana a proposito dei confini del Friuli. Ad esempio nel 1947 in un suo documento del 1947 si parla del
“Friuli […] dal Timavo alla Livenza” (di Caporiacco 2001: 80).
e, in un ordine del giorno del 1949 ci si riferisce ai friulani
“[…] dalle Alpi alla Laguna, dal Timavo alla Livenza […] (di Caporiacco 2001: 83).
D’altro canto anche un antiautonomista radicale come Linussa, in un suo articolo comparso sul Messaggero Veneto del 23 gennaio 1947, individua nel Livenza e nel Timavo i confini del Friuli (Luzzi Conti 1987: 276).
Clima
Nella pianura friulana il clima è di tipo sub-mediterraneo umido che nelle zone collinari si trasforma in continentale e, sui rilievi, in alpino. Sulla costa le temperature medie annue sono di poco superiori ai 14°C (Monfalcone: 14,2°C) mentre nelle pianure interne si registra un lieve abbassamento, fino a 13°C - 13,5°C (Udine 13,1°C, Pordenone 13,3°C , Gorizia 13,4°C). Ancora più a nord, Tolmezzo, a 326 m.s.m., presenta una temperatura media di circa 10,6°C. I valori più bassi si registrano nella catena alpina: poco più di 4°C al Passo di Monte Croce Carnico (ad oltre 1300 m.s.m.) e fra i 5,5°C e i 7°C nella Val Canale che però è situata al di sotto degli 850 m.s.m.. Le temperature del mese più freddo (gennaio) variano fra i 4,5°C circa di Monfalcone, ai quasi -5°C di Monte Croce Carnico, passando per i 3°C di Udine e i -2°C o -3°C della Valcanale. Gorizia, a breve distanza da Udine, gode, con i suoi 4°C circa, di un microclima particolarmente favorevole nei mesi freddi che la rese celebre, in epoca asburgica, come stazione di soggiorno invernale. Nel mese più caldo, luglio, le temperature vanno dai 22,5°C - 24,0°C del litorale e le pianure, fino ai 14°C - 16°C della Val Canale.
Le precipitazioni in tutto il Friuli sono relativamente abbondanti e ben distribuite nel corso dell'anno. Presentano un minimo pluviometrico nella parte meridionale pianeggiante, generalmente compreso fra i 1.200 e i 1.500 mm (Gorizia oltre 1.350 mm ed Udine oltre 1.400 mm), ed un massimo nell'arco prealpino ed alpino di circa 3.000 mm Nelle Prealpi Giulie si trova la località più piovosa d'Italia: Musi, con oltre 3.300 mm di precipitazioni annue e con quasi 400 mm concentrati in un solo mese. L'eccessiva piovosità ha spesso provocato, in alcune zone del Friuli, fenomeni di erosione di una certa gravità e straripamenti di molti corsi d'acqua. Per quanto riguarda le precipitazioni nevose queste sono piuttosto scarse nelle pianure meridionali (3 o 4 giorni nevosi a Udine e Pordenone) ma si fanno più consistenti a nord (25 giorni ed oltre in Val Canale, 23 a Sauris, 28 al Passo di Monte Croce Carnico).
Natura [40]
Flora
L'attuale manto vegetale del Friuli risulta ampiamente modificato, rispetto alla sua conformazione originaria, dall'intervento umano. Determinante, a questo proposito, fu il disboscamento radicale cui la Regione fu soggetta in età moderna (XV-XVIII secolo) e che alterò profondamente, sotto il profilo naturalistico, quasi tutta la fascia pianeggiante meridionale e, in parte, anche quella collinare centrale e pedemontana. Le zone litoranee (soprattutto lagunari) ed alpine sono, attualmente, quelle maggiormente incontaminate, nonostante alcune di esse siano meta di consistenti flussi turistici (Grado e Lignano Sabbiadoro sulla costa, Tarvisio e il Tarvisiano, Forni di Sopra, Ravascletto e Arta Terme nelle Alpi). Il territorio friulano presenta una gran varietà di specie vegetali (oltre 3.000) molte delle quali proprie della zona, e si suddivide, sotto il profilo naturalistico, in quattro grandi sub-regioni.
- La zona lagunare adriatica, particolarmente suggestiva e caratterizzata da bacini salmastri, paludi e aggregati insulari. La vegetazione predominante è di tipo arbustivo o erbaceo (cespugli, cespi, giunchi ecc.), anche se non sono rare le pinete, talvolta anche di dimensioni considerevoli. In questa microregione è presente anche una rarissima specie vegetale: l'apocino veneto.
- La zona pianeggiante litoranea (o Bassa friulana) e sub-litoranea coltivata intensivamente (a mais in particolare) e poco alberata (pioppi, carpini e frassini le specie più diffuse) perché soggetta in età moderna a un disboscamento di ampie proporzioni. Anche alcune specie di tipo mediterraneo sono presenti, in numero limitato, sul territorio, fra cui il leccio.
- La zona collinare e prealpina centrale, dalla gran varietà di fiori e di specie vegetali tipiche sia dell'area padana che europea centro-orientale. La superficie boschiva, non molto estesa, è ricca di querceti e di betullacee (carpini in particolare), ma anche di tigli, di olmi e di aceri.
- La zona alpina, contraddistinta, alle quote più basse, da boschi di larici e da abetaie. A partire da una certa altezza (1.700 - 1.800 metri circa) si impongono invece gli ontani e le boscaglie di montagna. Fra le specie vegetali tipiche di tali boscaglie vanno segnalati i rododendri, originari delle Alpi Orientali, e i mirtilli. Nel Tarvisiano è presente anche la rarissima Wulfenia.
Fauna
Dal punto di vista faunistico il Friuli può essere diviso in tre zone.
- L’area alpina, caratterizzata dalla presenza di orsi, linci europee (queste due prime specie sono ricomparse alla fine del XX secolo, provenienti dalla vicina Slovenia), stambecchi (reintrodotti nel XX secolo), cervi, caprioli, camosci, lepri, volpi, tassi, galli forcelli, francolini di monte, lepri, ermellini e marmotte. Sono inoltre presenti falconiformi come la poiana, il falco e l’aquila. Tra i rettili si segnalano l'aspide o vipera comune, il marasso, la vipera dal corno e il non ancora catalogato codâr (rettile del sottordine Lacertilia che è stato avvistato numerose volte in Carnia ma mai catturato). Nei rilievi friulani e in alta collina non sono rare due specie di anfibi diffuse anche in molte altre zone dell'arco alpino: il tritone alpestre e la salmandra alpina. Numerose sono infine le specie ittiche d'acqua dolce presenti nei ruscelli di montagna e nella zona pedemontana: fra queste predominano le trote, le tinche ed i barbi.
- L’area della collina e della pianura, fortemente antropizzata, nella quale spicca la presenza di lepri, volpi, fagiani e cinghiali. Fra le specie ittiche di pianura sono numerose, oltre alle specie che popolano i ruscelli e i bacini lacustri di montagna, anche le carpe (rare sui rilievi più alti) e una particolare specie di trota: il Salmo trutta marmorato (conosciuta generalmente come trota marmorata).
- La zona della laguna, che si caratterizza per essere tappa di numerose specie di uccelli in migrazione come il germano reale, l' alzavola, la marzaiola, il codone, il fischione, il moriglione. Vi sostano anche ardeidi come l’airone cenerino, l’airone rosso e la garzetta. Nelle zone lagunari ha anche una certa diffusione la coltivazione dei molluschi, in particolare ostriche e mitili.
Demografia
La popolazione del Friuli storico, che ammonta a poco più di un milione di persone, è suddivisa tra due Regioni (Friuli - Venezia Giulia e Veneto) e, specificamente, tra cinque province (Provincia di Gorizia, Provincia di Udine, Provincia di Pordenone, il Mandamento di Portogruaro in Provincia di Venezia e il Comune di Sappada in Provincia di Belluno)[41].
| Zona | Popolazione (2005) | Superficie (km²) |
Densità (ab/km²) |
|---|---|---|---|
| Provincia di Gorizia | 140.681 | 466 | 302 |
| Provincia di Udine | 528.246 | 4.905 | 108 |
| Provincia di Pordenone | 297.699 | 2.178 | 137 |
| Mandamento di Portogruaro | 92.481 | 630 | 147 |
| Sappada | 1.339 | 63 | 21 |
| Totale | 1.060.446 | 8.242 | 129 |
Uno dei fenomeni demografici più imponenti che coinvolsero il Friuli fu l'emigrazione. Essa iniziò negli ultimi decenni dell'Ottocento e si esaurì negli anni settanta del Novecento. Si calcola che più di un milione di friulani siano emigrati definitivamente nei circa cento anni in questione. Secondo l'ultimo censimento AIRE (2005) i friulani residenti all'estero sono 134.936. Di questi il 56,0% risiede in Europa, il 24,0% in Sud America, il 10,3% in Nord America ed il 4,7% in Oceania. Si deve tuttavia tenere presente che i dati dell'AIRE riguardano solo i friulani ed i loro discendenti che abbiano cittadinanza italiana. Risultano pertanto esclusi tutti i discendenti di friulani che non siano cittadini italiani.
I friulani nel mondo hanno dato vita a associazioni culturali denominate Fogolârs furlans, che sono 46 in Italia e 156 nel resto del mondo.
L'Ente Friuli nel Mondo
Nel 1953 per assistere i friulani all'estero e per coordinare le attività dei Fogolârs Furlans fu fondato l'Ente Friuli nel Mondo. Esso pubblica un mensile, Friuli nel mondo, che supera le 25.000 copie distribuite in 78 stati. Le attività dell'Ente sono informative, di collegamento e di mantenimento dell'identità friulana soprattutto tra le nuove generazioni.
Storia
Le origini e l'epoca romana
Interessata in età protostorica dalla cultura dei Castellieri, la regione fu popolata, nel corso del IV secolo a.C., da genti di origine celtica ed in particolare dai Carni, che introdussero, nei territori da loro occupati ed in quelli limitrofi, nuove ed avanzate tecniche di lavorazione del ferro e dell'argento.
L'attuale Friuli fu successivamente colonizzato dai Romani (a partire dal II secolo a.C.) e venne profondamente influenzato dalla civiltà latina, grazie anche alla presenza dell'importante centro di Aquileia, quarta città d'Italia e fra le principali dell'impero, capitale della X Regione augustea Venetia et Histria. Gli scavi archeologici effettuati, con particolare riferimento all'estensione delle mura e dell'agglomerato interno alle stesse, ci danno una chiara immagine del suo eccezionale sviluppo urbano e demografico. Ancor oggi Aquileia è, insieme a Ravenna, il massimo sito archeologico dell'Italia settentrionale. La città era inoltre importantissimo porto fluviale sull'allora fiume Natissa, snodo dei traffici adriatici verso l'Europa settentrionale (la così chiamata "Via Iulia Augusta") e verso l'Illiria. Aquileia doveva la sua importanza principalmente ad una posizione strategicamente favorevole, sia sotto il profilo commerciale che militare: sorgeva infatti sul mare Adriatico ed in prossimità delle Alpi orientali permettendo in tal modo a Roma di contrastare più efficacemente le invasioni barbariche provenienti da oriente. Nelle sue campagne militari, Giulio Cesare era solito portare le sue legioni a svernare proprio ad Aquileia durante l'inverno. Il greco Strabone, geografo di età augustea, in una sequenza della sua opera annota che il porto di Aquileia, colonia romana «...fortificata a baluardo dei barbari dell'entroterra... si raggiunge... risalendo il fiume Natisone per sessanta stadi... e serve come emporio per i popoli illirici stanziati lungo l'Istro (Danubio)»[43]. Va al riguardo segnalato che mentre al giorno d'oggi il Natisone è tributario dell'Isonzo, all'epoca sfociava direttamente in mare. Lo sviluppo di altri centri oltre ad Aquileia, quali Forum Iulii (Cividale del Friuli) e Iulium Carnicum (Zuglio) contribuì ad assicurare alla regione un notevole rigoglio economico e culturale che riuscì a mantenere, nonostante le prime incursioni barbariche, fino agli inizi del V secolo. Negli ultimi decenni del III secolo Aquileia divenne la sede di uno dei vescovati più prestigiosi dell'Impero, contendendo in Italia il secondo posto per importanza, dopo Roma, alle capitali imperiali di Milano e, successivamente, Ravenna. Nel 381 vi si tenne un importante concilio, presieduto dal vescovo Valeriano ma fortemente voluto da sant'Ambrogio, che aveva preferito Aquileia alla sua sede episcopale di Milano per far condannare pubblicamente l'eresia ariana e i suoi seguaci.
L'invasione unna segnò l'inizio della decadenza: Aquileia, protetta da forze esigue, si arrese per fame e venne espugnata e rasa al suolo da Attila nel 452 (in alcune fondamenta sono state ritrovate le tracce lasciate dagli incendi). Terminata l'ondata unna, i superstiti, che avevano trovato rifugio nella laguna di Grado, ritornarono in città, ma la trovarono completamente distrutta. La ricostruzione di Aquileia, per riportare all'antico splendore quella che era stata la superba capitale della X Regio, fu un'impresa vagheggiata ma mai effettivamente realizzata. La città rimase comunque un punto di riferimento ideale di enorme importanza anche dopo il crollo dell'Impero, grazie alla costituzione del Patriarcato, naturale successore del vescovato omonimo a partire dalla metà del VI secolo e sede di una fra le massime autorità cristiane del tempo.
L'insicurezza della pianura friulana, punto di passaggio di tutte le grandi invasioni barbariche, spinse in quell'epoca molte persone a trovar rifugio nelle isole o nei borghi fortificati sulle colline, determinando in tal modo lo spopolamento della parte più fertile della regione ed un suo generale impoverimento.
- 1000 a.C.-400 a.C. - L'attuale territorio del Friuli è abitato in gran parte da popolazioni paleovenete ed illiriche (queste ultime solo in alcune zone sudorientali). Sviluppo della cultura dei Castellieri procedente dall'Istria;
- 400 a.C.-300 a.C. - La popolazione celta dei Carni occupa gran parte dell'attuale Friuli, inserendosi attivamente nella cultura dei Castellieri;
- 221 a.C. - Alcune legioni romane dirette in Istria attraversano il Tagliamento e l'Isonzo. È questo il primo contatto, storicamente accertato, fra i Romani e le popolazioni autoctone della regione;
- 181 a.C. - Viene fondata in prossimità dell'Adriatico e sul fiume Natisone la Colonia di diritto latino di Aquileia. I Carni vengono ricacciati nelle prealpi friulane;
- 148 a.C. - Viene fatta costruire dal console Spurio Postumio Albino la Via Postumia, che unisce Genova ed Aquileia;
- 131 a.C. - Costruzione, per volere del pretore Tito Annio Rufo, della Via Annia che congiunge Aquileia ad Adria passando per Padova;
- 115 a.C. - Definitivo assoggettamento dei Carni a Roma, dopo strenua resistenza. Le armi romane erano guidate dal console Marco Emilio Scauro;
- 50 a.C.-49 a.C. - I centri di Forum Julii (l'attuale Cividale del Friuli) e Julium Carnicum (l'attuale Zuglio) divengono entrambi Municipia romani;
- 7 - Viene costituita la X Regio, Venetia et Histria, comprendente l'intera Italia nord-orientale fino al Golfo del Quarnero con capitale Aquileia. La città è all'epoca il quarto centro più popoloso d'Italia;
- 167 - La tribù germanica dei Quadi, oltrepassate le Alpi, cinge d'assedio Aquileia senza riuscire però ad espugnarla;
- 238 - L'imperatore Massimino il Trace perde la vita alle porte di Aquileia, assassinato dai suoi stessi soldati. Aquileia aveva chiuso le porte all'esercito imperiale per paura di saccheggi e spoliazioni da parte delle truppe;
- 300 circa - Potenziamento della zecca di Aquileia da parte di Diocleziano;
- 308-319 - Vescovo di Aquileia è Teodoro, vero artefice della futura grandezza della Diocesi, poi Patriarcato, di Aquileia. Va comunque sottolineato che la Diocesi di Aquileia si era già strutturata come tale nel corso della seconda metà del III secolo ed aveva dato alla chiesa cattolica una serie di martiri, vittime delle persecuzioni contro i cristiani, fra cui il suo primo vescovo Ermacora;
- 361 - L'imperatore Giuliano assedia Aquileia, restata fedele a suo cugino Costanzo II, e fa deviare le acque del fiume Natisone a nord della città, mettendo così fine definitivamente al porto fluviale;
- 381 - Nella città di Aquileia viene celebrato un concilio, promosso da sant'Ambrogio e presieduto dal vescovo della città, Valeriano, dove viene espressa una netta e definitiva condanna della dottrina ariana;
- 388 - Teodosio I cattura e mette a morte ad Aquileia l'usurpatore Magno Massimo che, dopo la Battaglia della Sava, si era rifugiato in città;
- 394 - Teodosio sconfigge, non lontano da Aquileia, l'usurpatore Flavio Eugenio. Il grande scontro, conosciuto come Battaglia del Frigido, ebbe luogo nella vallata del Vipacco, nell'attuale Slovenia. Con questa vittoria Teodosio riunisce nelle sue mani, e per l'ultima volta, l'Occidente e l'Oriente romano;
- 401-402 - Alarico I, re dei Visigoti, tenta di espugnare Aquileia, senza riuscirvi;
- 408 - Nella sua seconda discesa in Italia, Alarico tenta nuovamente, e inutilmente, di espugnare Aquileia;
- 452 - Aquileia cade per mano di Attila, re degli Unni.
Il medioevo
Dopo il crollo dell'Impero romano d'Occidente il Friuli entrò a far parte del Regno di Odoacre e successivamente di quello ostrogoto di Teodorico. La riconquista bizantina voluta dal grande Giustiniano (535-553) fu, per la Regione, di breve durata: nel 568 i Longobardi la occuparono.
La capitale venne spostata a Forum Iulii, fortificata nel corso del medioevo per poter resistere ad altri barbari. In epoca longobarda Forum Iulii si impose come il più importante e popoloso centro della Regione e, nei secoli successivi, mutò il suo nome in quello di Cividale del Friuli. La città, prima ancora di perdere definitivamente la sua denominazione latina, diede a sua volta il proprio nome all'intero territorio. Con successivi passaggi linguistici infatti, il nome Forum Iulii, sulla bocca delle popolazioni friulane di allora, si trasformò in Friûl e si estese fino ad indicare la totalità del ducato longobardo friulano.
I Longobardi lasciarono un profondo segno nella storia del Friuli, creando un forte ducato, che fin dalle sue origini rivestì una funzione militare e politica di primo piano nell'ambito del regno longobardo. Durante tutta la sua esistenza, il ducato del Friuli si configurò come una vera e propria barriera contro le minacce degli Avari e degli Slavi. Tale funzione strategica fu intuita fin dagli albori del dominio longobardo: il ducato del Friuli fu infatti il primo ad essere costituito in Italia e lo stesso Alboino volle affidarlo al nobile Gisulfo, suo parente e braccio destro. Non a caso, molti duchi del Friuli divennero anche re dei Longobardi. Fra questi, Rachis (prima metà dell'VIII secolo), sovrano di ampia cultura e profondamente religioso, fu un convinto sostenitore del processo di fusione fra l'elemento germanico e quello romano o romanizzato che oramai sia in Friuli che nel resto dell'Italia longobarda poteva considerarsi pienamente realizzato. L'adozione della religione cattolica (VII secolo) e della lingua latina avevano infatti permesso ai Longobardi di integrasi con le popolazioni autoctone e di partecipare attivamente allo sviluppo, anche civile e culturale, del territorio. Longobardi del Friuli furono anche Astolfo, successore di Rachis prima come duca del Friuli, poi come re d'Italia, e infine lo storico Paolo Diacono, autore della Historia Langobardorum e professore di grammatica latina presso la corte di Carlo Magno.
Alla dominazione Longobarda seguì quella franca, che iniziò a partire dagli ultimi decenni dell'VIII secolo. I Franchi riorganizzarono il Ducato del Friuli su base comitale e lo inserirono nel Regnum Italiae. Fu poi trasformato in Marca del Friuli nell'846. A cavallo tra i secoli IX e X il Friuli fu coinvolto nella lotta per il controllo d'Italia, quando il marchese Berengario si fece incoronare prima re d'Italia nell'888 e quindi imperatore del Sacro Romano Impero nel 915. Il Friuli estese allora il suo territorio sino al lago di Garda, mentre la capitale veniva spostata a Verona, costituendo la Marca di Verona e Aquileia. Con lo smembramento dello Stato carolingio (IX secolo) assunse sempre maggior importanza per i destini del Friuli la componente germanica dell'Impero.
Il 3 aprile del 1077 è una data che resterà per sempre impressa nella storia del Friuli: in questa giornata memorabile infatti l'imperatore Enrico IV concesse al Patriarca Sigeardo, per la sua fedeltà al potere imperiale, la contea del Friuli con prerogative ducali. Tale linea filo-imperiale, seguita anche dai successori di Sigeardo, che per lungo tempo saranno tutti di origine germanica, permise loro di consolidare lo Stato, la Patrie dal Friûl, che oltre a tale regione incluse in periodi storici diversi anche Trieste, l'Istria, la Carinzia, la Stiria, il Cadore. Lo Stato patriarcale del Friuli si impose ben presto come una delle più ampie e potenti formazioni politiche dell'Italia del tempo, dotandosi, fin dal XII secolo, anche di un Parlamento, espressione massima della civiltà friulana sotto il profilo istituzionale. Tale organismo prevedeva inoltre una rappresentanza assembleare anche dei comuni e non solo dei nobili e del clero. La vita di questa grande Istituzione si protrasse per oltre sei secoli, mantenuta persino sotto la dominazione veneziana, anche se in parte svuotata di potere: si riunirà infatti per l'ultima volta nel 1805. Sarà abolita da Napoleone Bonaparte. Il Patriarca Marquardo di Randeck (1365-1381) raccolse tutte le leggi emanate in precedenza nella Constitutiones Patriae Foriiulii, ossia Costituzione della Patria del Friuli. L'attuale Cividale del Friuli sarà sede del Patriarcato del Friuli fino al 1238, anno in cui il Patriarca si trasferirà a Udine dove farà costruire un superbo palazzo, per se e per i propri successori. Udine assumerà in tal modo sempre maggiore importanza divenendo col tempo la capitale istituzionale del Friuli.
- 476 - Il generale erulo Odoacre depone l'imperatore Romolo Augustolo (ultimo sovrano legittimo dell'Impero Romano d'Occidente) e si proclama re d'Italia;
- 489 - Gli Ostrogoti provenienti dalla Pannonia sotto la guida di Teodorico invadono il Friuli e sconfiggono facilmente Odoacre. Le cronache del tempo parlano del nuovo regno gotico come di un periodo di gravi carestie, inasprimenti fiscali, dissidi tra latini e barbari;
- 535-553 - La guerra gotica pone fine al regno dei Goti ed instaura nella penisola l'amministrazione bizantina;
- 553 - Inizia lo Scisma tricapitolino che vede protagonista la chiesa di Aquileia;
- 568 - I Longobardi, provenienti dalla Pannonia e guidati dal re Alboino invadono il Friuli. La loro invasione avviene lentamente e senza incontrare alcuna resistenza armata; un'invasione molto differente dalle precedenti, le quali avevano invece lasciato dietro a sé morte e rovine. In breve tempo i Longobardi si impadroniscono di gran parte d'Italia; Forum Iulii (Cividale del Friuli) diviene capitale del Ducato del Friuli, prima entità statuale longobarda in Italia;
- 568-776 - Per oltre due secoli la storia del Friuli si confonde con quella dei Longobardi. Il primo secolo coinciderà con un periodo di lotte, congiure, instabilità politica e dalle incursioni degli Avari e Slavi; il secondo sarà invece un periodo di forte sviluppo economico, politico, culturale ed artistico, grazie anche all'adozione da parte dei longobardi del cattolicesimo (prima metà del VI secolo) e della lingua latina. Le vicende di questo periodo sono brillantemente narrate dal cividalese Paolo Diacono (morto nel 799) nel suo libro Historia Langobardorum;
- 698 - Con la fine dello Scisma tricapitolino la chiesa di Aquileia e quella di Roma rientrano in comunione;
- 776 - Carlo Magno, re dei Franchi, invocato da Papa Adriano I che si sente minacciato dal re longobardo Desiderio, entra in Italia con un esercito e sconfigge i Longobardi. Nonostante la sconfitta l'eredità etnica e culturale lasciata dai Longobardi non sarà mai cancellata;
- 776-899 - Il dominio franco non riesce a creare condizioni di stabilità nonostante le particolari cure che lo stesso Carlo Magno dedica al Friuli. In questo periodo tornerà a rifiorire la città di Cividale, adesso chiamata Civitas Austriae e non più Forum Iulii, termine che invece andrà ad identificare il nome dell'intera regione;
- 899-952 - Il Friuli subisce la più lunga e devastante invasione per mano degli Ungari. Provenienti da una zona compresa tra il Volga e gli Urali arrivano a spingersi prima in Germania quindi in Italia. Le loro invasioni non hanno carattere stabile, si tratta bensì di rapide incursioni che lasciano dietro a se incendi, morti e rovine. Le conseguenze delle invasioni ungare saranno fatali per il Friuli: spopolamento della regione, interruzione delle vie di comunicazione, abbandono delle attività produttive;
- 952-1019 - Dopo la vittoria sugli Ungari da parte di Enrico duca della Baviera e della Carinzia, fratello di Ottone I (futuro imperatore), il Friuli, ridotto a semplice comitato, viene incorporato alla marca veronese (955 circa). Nel 989 è annesso al ducato di Carinzia;
- 1019-1077 - Viene avviata, per mano del patriarca di Aquileia, la rinascita materiale e spirituale del Friuli. Questo processo, che porterà al riconoscimento giuridico dello stato patriarcale da parte dell'imperatore, rappresenta uno degli esempi più noti di compartecipazione del potere politico tra chiesa, aristocrazia e società civile laica, tipici del periodo medievale;
- 1077 - A Pavia il 3 aprile del 1077 l'imperatore Enrico IV concede al patriarca Sigeardo l'investitura feudale con prerogative ducali su tutta la contea del Friuli. È l'atto di nascita dello stato patriarcale friulano; con questo atto il Friuli riacquista la sua integrità territoriale e la sua autonomia politica. Nonostante non si possa configurare come un vero stato sovrano, l'esempio friulano rappresenta una delle forme più mature di organizzazione politica unitaria ed accentrata sorte in Europa nel Medioevo;
- 1077-1204 - I successori di Sigeardo, si mantengono fedeli alla politica di Enrico IV e poi del figlio Enrico V facendo dello stato friulano la pedina avanzata della politica imperiale in Italia. All'unità territoriale dello stato friulano (alla fine del XII secolo lo stato più ampio e compatto dell'Italia settentrionale) viene ad affiancarsi anche un'unità etnico-culturale tale da poter essere ormai definita semplicemente friulana;
- 1204-1251 - È il periodo di massimo splendore del patriarcato; il Friuli mai come in questo periodo ha raggiunto tanta autonomia e prestigio internazionale. Sotto il patriarcato di Volchero (1204-1218) grande impulso viene dato ai traffici commerciali ed alle attività produttive, viene migliorata la rete viaria e si sviluppa una brillante attività culturale. A Volchero succede il patriarca Bertoldo di Andechs-Merania (1218-1251) il quale ha fin dall'inizio un occhio di riguardo per Udine che in breve tempo passa da piccolo villaggio a città. Le mire di conquista dei ghibellini Ezzelino III da Romano e Mainardo III, conte di Gorizia, costringono il patriarca a cercare aiuto nel partito avversario (quello guelfo) alleandosi con Venezia e con il duca di Carinzia;
- 1251-1334 - Il Friuli divenuto elemento di forza della lega Guelfa si avvia ad un lento ma inesorabile declino. Il patriarca non riesce più a conservare la coesione tra i comuni friulani e frequenti divengono i tradimenti, le congiure e le lotte tra vassalli; il conte di Gorizia diviene il principale avversario dell'autorità patriarcale;
- 1282- Pordenone diventa patrimonio personale degli Asburgo.
- 1334-1381 - Grazie agli sforzi dei patriarchi viene nuovamente dato lustro e prestigio allo stato friulano, ma i loro propositi sono coronati da un successo parziale ed effimero. Molto si deve al patriarca Bertrando di San Genesio (1334-1350) che, amato dal popolo, consegue numerosi successi sul piano militare e diplomatico senza mai trascurare i suoi doveri di vescovo. Il 6 giugno del 1350, ormai novantenne, rimane vittima di una congiura guidata dal conte di Gorizia e dal comune di Cividale. Il patriarca Marquardo di Randeck (1365-1381) passerà invece alla storia per aver promulgato (11 giugno 1366) la Costituzione della Patria del Friuli (Constitutiones Patriae Foriiulii), base del diritto friulano fino alla caduta della repubblica veneta;
- 1353 - Il 1° agosto, con un diploma di attuazione, l'Imperatore del Sacro Romano Impero Carlo IV di Lussemburgo autorizza il Patriarca ad istituire in Friuli un'università. Avrà sede a Cividale del Friuli. È previsto il dottorato in materie scientifiche, matematiche, giuridiche, ecclesiastiche. Funzionerà, anche se in maniera irregolare, fino al 29 aprile 1429 quando, con decreto, Venezia la chiuderà;
- 1381-1420 - È il periodo della decadenza dello stato patriarcale, principalmente causata da uno spirito di fazione, odio e vendetta tra i comuni friulani, in particolare tra quelli di Udine e Cividale, lite in cui vengono coinvolti altri stati italiani ed esteri. Con Cividale si schierano gran parte dei comuni friulani, i carraresi, Padova ed il Re d'Ungheria; Udine appoggia invece Venezia. Nel 1411 il Friuli divenne campo di battaglia fra l'esercito imperiale (schierato con Cividale) e quello veneziano (schierato con Udine). Nel dicembre di questo stesso anno l'esercito dell'imperatore si impadronisce di Udine; il 12 luglio 1412 nel Duomo di Cividale viene investito dei suoi poteri temporali il patriarca Ludovico di Teck (questa fu l'ultima cerimonia del Sacro Romano Impero in Friuli). Il 13 luglio 1419 i Veneziani occupano però Cividale e si prepararono alla conquista di Udine;
- 1420 - Il 7 giugno 1420, dopo una strenua difesa, l'esercito veneziano entra nella città di Udine; subito dopo cadono Gemona, San Daniele, Venzone, Tolmezzo; è la fine dello stato patriarcale friulano;
- 1445 - Dopo lunghe trattative il patriarca Ludovico Trevisan accetta il concordato imposto da Venezia mediante il quale viene abolita di fatto l'indipendenza del Friuli. Da qui in avanti il Friuli seguirà le vicende della Serenissima Repubblica Veneta.
Dalla dominazione veneziana alla Restaurazione
L'esperienza del Patriarcato, si concluse nel 1420, quando il Friuli fu annesso alla Repubblica Veneta, una delle grandi potenze dell'epoca, con un territorio in piena espansione. Il dibattito storico sul rapporto fra Venezia e i suoi territori coloniali è tuttora aperto ed in gran parte esula da motivazioni propriamente storiche per collegarsi al mito della città lagunare. Secondo la storiografia più tradizionale infatti «la quiete civile e lo stato pacifico della sua classe dominante sarebbero stati i principi su cui si sarebbe fondato il mito di Venezia»[45]. Per la nuova storiografia internazionale invece: «per lungo tempo non è stato possibile dissociare la realtà (di Venezia) dall'immagine, straordinariamente lusinghiera e deformata (di Venezia)...il mito politico veneziano ha per secoli distorto l'approccio e le analisi. Almeno fino al XIX secolo, esso (il mito di Venezia) ha pesato sulla scrittura della storia, poiché la storia aveva come fine principale di confortare il mito»[46]. Solo da pochi anni si è iniziato a investigare sulle supposte deficenze del sistema politico oligarchico veneziano e sui rapporti profondamente conflittuali esistenti tra Venezia e gli altri territori facenti parti del suo Stato. Gli studiosi oggigiorno sono quasi unanimemente concordi nel considerare questo periodo come uno dei più tormentati e difficili di tutta la lunga storia del Friuli.
Nel testo esplicativo a sinistra si legge che "La patria antedetta confina da Levante con l'Istria e Iapidia al presente detta Carso, da ponente con il territorio Tervisano, Belunese da Settentrione con l'alpe de Alemagna e, da Meggio giorno con la parte del mare Adriatico quale è tra il porto del fiume Timavo, e Livenza"
Il Friuli, utilizzato spesso come Stato cuscinetto in funzione antiturca, fu ripetutamente devastato da una lunga serie di guerre per il suo possesso fra Venezia e gli Asburgo. Tali guerre comportavano per le classi rurali disagi e miseria, con l'impossibilità di coltivare la campagna percorsa dagli eserciti in lotta e con la requisizione forzosa di tutti gli animali da allevamento per il vettovagliamento dei soldati. La necessità di procurarsi legname per le proprie imbarcazioni causò inoltre il disboscamento della totalità della bassa friulana e del medio Friuli. Venezia si impossessò delle terre collettive di proprietà delle comunità rurali friulane impoverendole gravemente. Queste terre saranno poi vendute dallo Stato nel corso del '600 per superare la sua grave situazione finanziaria e fare cassa.
D'altra parte a partire dal terzo decennio del XVII secolo la Repubblica Veneta entrò in un processo di decadenza irreversibile dovuto alla perdita di molti suoi mercati tradizionali, alla canalizzazione del risparmio e di importanti risorse finanziarie in investimenti improduttivi (soprattutto di carattere fondiario), e alla perdita di competitività delle sue industrie e dei suoi servizi[47]. Un rapido processo di impoverimento colpì anche il Friuli, soggetto ad una pressione fiscale sempre più opprimente ed alla crisi pressoché totale delle sue industrie e dei commerci.
A questo proposito va detto che la politica populista praticata da Venezia (non riferita particolarmente al Friuli) cercò in ogni modo, secondo alcuni storici, di «limitare gli effetti più oppressivi ed anacronistici della società feudale»[48]. Di differente avviso altri studiosi che affermano che il governo aristocratico veneto tollerava in Friuli, la sopravvivenza dei più pesanti diritti feudali[49]. Questa politica per assicurarsi l'appoggio delle plebi urbane e rurali come contrappeso alle tendenze autonomiste e centrifughe delle oligarchie locali, anche aristocratiche, non poté più essere messa in atto a partire dalla Guerra dei Trent'anni.
Un'importante rivolta popolare, fatto storico molto noto e conosciuta come Joibe grasse 1511 (giovedì grasso 1511), fu iniziata a Udine il 27 febbraio da cittadini udinesi affamati in seguito supportati dai contadini e si estese successivamente all'intero territorio della Patrie dal Friûl. Tale movimento insurrezionale fu uno dei più vasti dell'Italia rinascimentale e si protrasse per tutto il 27 febbraio ed il 28 febbraio, fino a quando, il 1º marzo, fu affogata nel sangue da Venezia che inviò alcune centinaia di cavalieri per sedare i moti. La mancanza di risorse finanziarie adeguate costrinse le classi dirigenti veneziane a non dare più ascolto alle aspirazioni ed esigenze popolari incrementando il già elevato livello impositivo e riallacciando i rapporti con le classi aristocratiche friulane, naturali custodi dell'ordine costituito. Tale politica determinò una perdita generalizzata dei consensi già scarsi di cui godeva Venezia presso le classi popolari. Si tentò infine, a varie riprese, di sostituire o integrare il patriziato friulano con nobili veneti, o di venetizzarli in vario modo, anche attraverso lo strumento linguistico. Alla metà del XVI secolo gli abitanti della Patria del Friuli erano 198.615, nel 1599, secondo la stima del Luogotenente del tempo, Stefano Viario, erano solo 97.000. Il tasso di mortalità infantile era elevatissimo e raggiunse il suo massimo storico nel 1629[50].
Con i patti di Noyon del 1516 i confini tra la Repubblica Veneta e la Contea di Gorizia e Gradisca, ormai in mano agli Asburgo, vennero ridefiniti. Venezia perdeva l'alto bacino dell'Isonzo (cioè la gastaldia di Tolmino con Plezzo ed Idria), ma manteneva Monfalcone. All'arciduca d'Austria rimanevano Marano (fino al 1543) ed una serie di isole feudali sparse nel Friuli Occidentale [51]. Tra il 1615 ed il 1617 Venezia e l'Austria si affrontarono di nuovo militarmente per il possesso della fortezza di Gradisca d'Isonzo. La cosiddetta guerra di Gradisca si concluse con il ritorno allo status quo precedente.
A partire dal 1516 l'Impero Asburgico controllò il Friuli orientale, mentre il Friuli occidentale e centrale rimase veneziano fino al 1797, anno del trattato di Campoformio, quando in seguito alle campagne napoleoniche anche questa parte del Friuli venne ceduta all'Austria, che la perse per un breve periodo in cui fece parte del Regno italico, dal 1805 fino alla Restaurazione. La contiguità tra il Friuli veneto e il Friuli austriaco permetteva confronti e, secondo alcuni studiosi, questi non erano affatto lusinghieri per la Serenissima[52].
- 1499 - Un'incursione turca colpisce il Friuli;
- 1500 - Muore Leonardo, ultimo conte di Gorizia, lasciando in eredità la Contea di Gorizia a Massimiliano d'Asburgo;
- 1508-1509 - La Repubblica di Venezia occupa militarmente la Contea di Gorizia;
- 1508 - Venezia conquista la contea di Pordenone, precedentemente occupata dagli Asburgo;
- 1511 - Una fronda nobiliare e una rivolta popolare si intrecciano negli eventi della Joibe grasse dal 1511; nello stesso anno Gradisca d'Isonzo viene conquistata dagli Asburgo e il Friuli è colpito da un'epidemia di peste, da un terremoto e da una carestia;
- 1516 - Con il Trattato di Noyon la Repubblica di Venezia riconosce agli Asburgo il possesso della Contea di Gorizia e Gradisca;
- 1521 - Con il trattato di Worms l'Austria ottiene definitivamente il controllo di Tolmino, di Plezzo, dell'alta valle dell'Isonzo, della cittadella fortificata di Gradisca e del distretto di Cervignano, mentre quello di Monfalcone rimane veneziano;
- 1543 - Marano Lagunare passa alla Repubblica di Venezia;
- 1593 - Viene eretta la fortezza di Palmanova in funzione antiturca;
Vista aerea di Palmanova - 1596 - Il patriarca di Aquileia Francesco Barbaro abolisce il rito patriarchino;
- 1615-1617 - Venezia e l'Austria si affrontano militarmente per il controllo del Friuli orientale durante la guerra di Gradisca;
- 1626 - La Contea di Gorizia viene incorporata al Sacro Romano Impero Germanico come feudo asburgico;
- 1647 - La Contea di Gradisca si separa da quella di Gorizia e viene infeudata ai conti di Eggenberg;
- 1700 - Un terremoto colpisce la Carnia;
- 1713 - Si ha una rivolta contadina a Tolmino, nella contea di Gorizia;
- 1751 - La bolla papale Injuncta Nobis di Benedetto XIV sopprime il patriarcato di Aquileia e istituisce l'Arcidiocesi di Udine e l'Arcidiocesi di Gorizia;
- 1754 - La Contea di Gradisca viene riunificata a quella di Gorizia;
- 1797 - Con il trattato di Campoformio i territori della Repubblica di Venezia, incluso il Friuli centrale e occidentale, vengono ceduti all'Austria;
- 1805 - Il Friuli centrale e occidentale vengono sottratti all'Austria per entrare a far parte del Regno d'Italia;
- 1805 - Viene soppresso il Parlamento della Patria del Friuli;
- 1809 - Con la pace di Vienna, il Friuli viene nuovamente diviso: il Friuli ex veneto viene suddiviso in più Dipartimenti (Passariano, Tagliamento, Piave, Adriatico) mentre quello ex austriaco è annesso alle Province Illiriche.
Storia contemporanea
Dalla Restaurazione alla Grande guerra
Nel 1815, il Congresso di Vienna sancì la definitiva unione di Veneto e Friuli con la Lombardia austriaca, venendosi in tal modo a costituire il Regno Lombardo-Veneto. Una ventina d'anni più tardi, il il Mandamento di Portogruaro, da sempre friulano per storia, cultura, geografia e a lungo anche per lingua, fu tolto per volontà austriaca dalla Provincia del Friuli (parte integrante, come già si è detto, del Regno Lombardo-Veneto austriaco) e assegnato alla Provincia di Venezia (1838). Oggi sta chiedendo di ritornare a fare parte del Friuli amministrativo[53]. Il Friuli centrale (attuale provincia di Udine) e il Friuli occidentale (attuale provincia di Pordenone) furono annessi all'Italia nel 1866 assieme al Veneto subito dopo la Terza guerra di indipendenza, mentre il Friuli orientale (la cosiddetta Contea di Gorizia e Gradisca) rimase soggetto all'Austria fino al termine della Prima guerra mondiale.
Durante la Prima guerra mondiale il Friuli, che all'epoca si trovava diviso tra Regno d'Italia e Austria-Ungheria (Provincia di Udine per il Regno d'Italia; una parte della Contea di Gorizia e Gradisca per l'Impero d'Austria-Ungheria), fu teatro delle operazioni belliche, che ebbero conseguenze gravose per la popolazione civile, soprattutto dopo la disastrosa rotta di Caporetto.
La proposta di autonomia
Dopo Caporetto, riprese in Austria la vita politica che vide i rappresentanti dei vari popoli dell'Impero battersi per la trasformazione della Monarchia in senso democratico e confederale. In questo clima, i due deputati friulani presso il Parlamento di Vienna Giuseppe Bugatto e Luigi Faidutti, iniziarono una campagna politica per l'autonomia del Friuli orientale (con capoluogo Gorizia). A tale scopo si costituì un Consiglio nazionale friulano, per iniziativa del Partito cattolico popolare del Friuli che rispose positivamente a una serie di proposte formulate da Carlo I mediante un proclama lanciato nell'ottobre del 1918 che prevedeva anche la piena libertà di autoderminazione del popolo friulano in caso di mutamenti di confine. In un celebre discorso pronunciato alla Camera di Vienna il 25 ottobre 1918, Luigi Faidutti ribadì la richiesta di autonomia e il diritto all'autodeterminazione per il popolo friulano. Il discorso si concludeva con le prime e ultime parole pronunciate in friulano nel Parlamento austriaco:
L'opinione pubblica italiana e gli irredentisti locali videro però nella svolta autonomista di Carlo I il disperato tentativo di una monarchia agonizzante di puntellare il proprio potere blandendo quei settori della società del Friuli Orientale tradizionalmente leali agli Asburgo.
Il conflitto si concluse con l'annessione all'Italia di quasi tutti i territori che l'opinione pubblica italiana riteneva fossero geograficamente e/o etnicamente italiani e che le erano stati promessi con il Patto di Londra (1915). Tra questi ultimi il Friuli Orientale, compreso nella Contea di Gorizia e Gradisca e la Val Canale, appartenente amministrativamente al Ducato di Carinzia. In realtà tali territori, pur se legati storicamente al Friuli, erano mistilingui: nella Val Canale gli sloveni costituivano insieme ai germanofoni la componente maggioritaria della popolazione e anche nel Friuli Goriziano esisteva, accanto a popolazioni di lingua friulana e veneta che avevano l'italiano come lingua di cultura, una forte minoranza linguisticamente ed etnicamente slovena.
Il primo dopoguerra e il fascismo
Nel 1923 fu soppressa la Provincia di Gorizia (ex Contea di Gorizia e Gradisca). I suoi territori venivano inclusi in larga parte nella Provincia del Friuli (con capoluogo Udine) ed in quella di Trieste (cui furono attribuiti i mandamenti di Monfalcone, di Sesana, e il Comune di Grado), mentre alla Provincia dell'Istria fu assegnato il solo mandamento di Bisterza [54]. L'abolizione della Provincia di Gorizia, incorporata a quella di Udine per dare luogo alla Provincia del Friuli era il risultato di due volontà: la prima era quella di ridurre l'influenza della minoranza slovena [55] e la seconda, tenacemente perseguita dalle classi dirigenti udinese e triestina, di estendere il proprio controllo sul Goriziano [56]. La Provincia di Gorizia fu ricostituita, con ampie mutilazioni territoriali, con il decreto del 1° gennaio 1927. Essa non riacquistava i mandamenti ceduti alle Province di Trieste e dell'Istria, mentre rimanevano a quella di Udine la Val Canale ed il mandamento di Cervignano [57].
Durante il periodo del fascismo il Friuli dovette subire un processo di assimilazione etnica, di cui furono vittime soprattutto la popolazione slovena e quella tedesca. Forte fu anche la pressione sulla comunità friulana, che il fascismo tentò di usare in funzione anti-slava. L'assimilazione comportava anche la proibizione dell'uso delle lingue slovena, tedesca e friulana, nonché l'italianizzazione forzata di cognomi e nomi sloveni, tedeschi e friulani. Fatto poco noto, la popolazione tedesca della Val Canale fu obbligata (come quella dell'Alto Adige) a optare: le fu imposto, cioè, di scegliere se italianizzarsi o trasferirsi in Germania [58]. La maggior parte della popolazione di lingua e cultura tedesca, scelse di abbandonare l'Italia e fu sostituita da popolazione proveniente da altre regioni italiane o da friulani. Tra gli optanti vi furono anche alcuni sloveni della Val Canale, mentre altri appartenenti a questo gruppo etnico, provenienti dal Goriziano, emigrarono nel Regno di Jugoslavia, in Argentina e in altri paesi. La maggioranza della comunità slovena decise però di non abbandonare le proprie terre nonostante le pressioni da parte delle autorità fasciste.
La Seconda guerra mondiale
A partire dal mese di giugno del 1940 il Friuli fu coinvolto, come il resto d'Italia, nella Seconda guerra mondiale e ne seguì le sorti. Lutti, restrizioni e disagi di ogni tipo si acuirono soprattutto a partire dall'inverno del 1942-1943 con i primi bombardamenti aerei su alcuni centri abitati della Regione. Dopo l'8 settembre 1943 il Friuli venne sottoposto al controllo diretto del Terzo Reich, interessato ad avere uno sbocco sull'Adriatico e a sottrarre le zone confinarie all'influenza della Repubblica Sociale Italiana. Anche il movimento partigiano acquistò una forza sempre maggiore tanto da creare la Repubblica libera della Carnia nel 1944. Il 1º ottobre 1943, era infatti stato istituito dalla Germania nazista l'Adriatisches Küstenland, formato dalle Province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana. Quest'ultima era stata costituita nel 1941, subito dopo l'aggressione nazifascista al Regno di Jugoslavia, con quella parte di territorio sloveno soggetto all'occupazione italiana. I tedeschi si avvalsero anche delle truppe cosacche antistaliniste, per tentare di debellare le formazioni partigiane nell'Alto Friuli.
Nell'inverno 1943-1944 penetrò nelle zone montuose del Friuli orientale (Slavia Friulana) anche il movimento di resistenza sloveno a egemonia comunista, che vi restò attivo fino alla fine della guerra. È proprio all'interno dei tesi rapporti tra la resistenza titoista jugoslava e le varie componenti di quella italiana che si inquadra l'episodio dell'eccidio di Porzûs.
Nell' inverno 1944-45 gli scali ferroviari di Udine e della Val Canale, i ponti sul Tagliamento ed altri obiettivi strategici, subirono nuovi e pesanti bombardamenti aerei anglo-americani. Il 30 aprile 1945 l'intera Regione poteva considerarsi completamente libera dall'occupazione nazista.
Il secondo dopoguerra
Al termine della seconda guerra mondiale si propose il problema della definizione dei confini tra la Jugoslavia e l'Italia, che riguardava anche la fascia orientale del Friuli, da Tarvisio a Monfalcone. Fra il 1945 e il 1947, furono formulate le più svariate proposte sui nuovi confini tra i due paesi. La Jugoslavia premeva per vedersi riconoscere tutti quei territori che riteneva etnicamente sloveni, come anche la Bisiacaria dove era presente un forte movimento comunista filo-jugoslavo. La proposta dell'Unione Sovietica, che appoggiava la Jugoslavia, lasciava a questo Stato il tarvisiano fino a Pontebba, tutte le vallate a est di Cividale del Friuli, Gorizia, Monfalcone, il Carso etnicamente sloveno e tutta l'attuale provincia di Trieste. Contrariamente a quanto a volte si è sostenuto, non ci fu alcuna proposta ufficiale che fissasse il confine sul Tagliamento, un disegno la cui unica traccia è rinvenibile in una lettera inviata da Tito a Stalin.
Nel 1947, quando ancora non era stato ratificato il trattato di pace, nella costituzione italiana, come dimostrazione politica che l'Italia non intendeva rinunciare all'Istria, a Trieste e al Goriziano, fu aggiunto al nome Friuli, anche quello di Venezia Giulia pur se diviso da un trattino. Tale scelta fu avversata dall'opinione pubblica friulana, che proprio nell'immediato secondo dopoguerra, iniziava a rivendicare l'autonomia per la propria Regione.
A tale riguardo va segnalato che nel 1945 nacque a Udine l'Associazione per l'Autonomia Friulana, tra i cui primi iscritti si annoveravano alcuni personaggi che avrebbero svolto un ruolo di primo piano nell'autonomismo friulano dei successivi dieci anni: Tiziano Tessitori, Gianfranco D'Aronco e Pier Paolo Pasolini. L'Associazione per l'Autonomia Regionale Friulana aveva come scopo, così come si legge nello statuto, quello di: far riconoscere che il Friuli costituisce un'entità regionale assolutamente distinta dalle limitrofe regioni veneta e giuliana, e quindi ottenergli la più ampia autonomia politico-amministrativa ed economica nell'ambito dello stato italiano. Nel 1947 dall'Associazione per l'Autonomia Friulana si staccò il più radicale Movimento Popolare Friulano, il cui obiettivo, come emerge dal suo statuto, era quello di ottenere la ricostituzione integrale della Regione del Friuli nei suoi confini naturali, con la più ampia autonomia, entro l'ambito dello Stato italiano. I due movimenti ebbero una vita di pochi anni.
L'autonomismo friulano conobbe una nuova auge a partire dagli anni sessanta. In quell'epoca, infatti, si iniziò a discutere su alcuni temi strettamente collegati tra loro: la creazione della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e di un'università friulana, il problema delle servitù militari che limitavano lo sviluppo economico della Regione, il riconoscimento della lingua friulana, il problema dell'emigrazione che colpiva duramente le terre friulane, la questione dei rapporti tra il Friuli e Trieste. In quel decennio (1966) nacque anche il Movimento Friuli, il partito politico che incarnò le istanze friulaniste per due decenni. Alcuni intellettuali dell'area friulana ravvisarono in questo e in altri movimenti consimili, tendenze separatiste o anti-italiane: netta a questo proposito fu la presa di posizione e la condanna del poeta gradesano Biagio Marin[59]. Nonostante la presenza dei notevoli fermenti autonomisti cui abbiamo fatto cenno, in Friuli la Democrazia Cristiana rimase per decenni il partito di maggioranza relativa (con una presenza più consistente delle sinistre in Carnia, in Bisiacaria e nel Mandamento di Cervignano).
La storia naturale ha visto due eventi tragici in Friuli nel secondo dopoguerra: il disastro del Vajont del 1963 e il terremoto del Friuli del 1976.
- 1815 - Il Congresso di Vienna sancisce l'aggregazione del territorio friulano ex veneto al Regno Lombardo-Veneto, mentre la Contea di Gorizia e Gradisca entra a far parte del Regno di Illiria, costituito nel 1816 e comprendente Carinzia, Carniola e Litorale Austriaco;
- 1838 - Il Mandamento di Portogruaro viene staccato dalla Provincia del Friuli e assegnato alla Provincia di Venezia;
- 1848 - Si hanno insurrezioni armate antiaustriache a Udine, Palmanova e Osoppo;
- 1849 - La contea di Gorizia e Gradisca viene staccata dal Regno d'Illiria e entra a far parte del Litorale Austriaco, insieme a Trieste e all'Istria;
- 1852 - Il comune di Sappada viene staccato dalla Provincia del Friuli e assegnato alla Provincia di Belluno;
- 1866 - Il Friuli centrale e occidentale viene annesso al Regno d'Italia
- 1915 - L'Italia dichiara guerra all'Austria-Ungheria. Iniziano i combattimenti sul fronte friulano (Alpi Carniche, Alpi Giulie, Isonzo);
- 1915-1917 - Nell'ambito della Prima guerra mondiale, le truppe italiane occupano una parte del Friuli orientale;
- 1917-1918 - Nell'ambito della Prima guerra mondiale, le truppe austriache occupano il Friuli centrale e occidentale;
- 1918 - Fallisce la proposta di un'ampia autonomia del Friuli orientale all'interno dell'Austria-Ungheria;
- 1919 - Con il Trattato di Saint-Germain, il Friuli orientale viene annesso al Regno d'Italia;
- 1922 - Le minoranze etniche (soprattutto slovena e tedesca) iniziano a essere sottoposte a un processo di italianizzazione forzata;
- 1923 - Soppressione della Provincia di Gorizia;
- 1927 - Ricostituzione, con un territorio ridotto, della Provincia di Gorizia;
- 1939 - Alla popolazione tedesca della Val Canale viene imposto di scegliere tra l'italianizzazione e l'espatrio;
- 1943 - Inizia la Guerra di Resistenza anche in Friuli;
- 1944 - Viene istituita la Repubblica libera della Carnia, soffocata dai tedeschi per mano dei cosacchi e dai fascisti;
- 1945 - Il Friuli viene liberato dalle truppe alleate;
- 1945 - Nasce l'Associazione per l'Autonomia Friulana;
- 1947 - Nasce il Movimento Popolare Friulano;
- 1947 - La Costituzione prevede l'istituzione della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- 1963 - Viene effettivamente istituita la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- 1964 - Iniziano rivendicazioni per l'Università di Udine;
- 1966 - Nasce il Movimento Friuli;
- 1968 - Viene creata la provincia di Pordenone, per distacco da quella di Udine;
- 1972 - Viene fondato il Comitato per l'Università di Udine;
- 1976 - Il Friuli è colpito da due terremoti, il più grave dei quali causa un migliaio di morti. La ricostruzione viene ultimata in una decina di anni;
- 1977 - La Legge 8 agosto 1977, n. 546 istituisce l'Università di Udine;
- 1991-1992 - Nel Mandamento di Portogruaro si svolgono referendum consultivi per l'adesione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, che danno esito positivo;
- 2004 - Si svolge un referendum per la costituzione di una provincia dell'Alto Friuli, per distacco da quella di Udine. La consultazione dà esito negativo;
- 2006 - Nel Mandamento di Portogruaro si svolgono referendum (non più solo consultivi) per l'adesione alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Tutti i comuni si esprimono largamente a favore, ma solo a Cinto Caomaggiore viene raggiunto il quorum.
Cultura
Lingue
Praticamente tutti gli abitanti della regione utilizzano come lingua amministrativa e di cultura l'italiano (lingua insegnata obbligatoriamente a scuola), e, specialmente a Udine, l'italiano è la prima lingua anche nell'uso domestico, sebbene la lingua friulana sia correntemente utilizzata nelle sue varianti nella maggior parte del territorio del Friuli.
Ai sensi della L.482/99, il friulano, lo sloveno (nelle sue varianti locali) e il tedesco (nelle sue varianti locali) sono riconosciute e tutelate come lingue minoritarie storiche. Queste le zone dove sono parlate le lingue minoritarie diverse dal friulano: 1) il tedesco nelle sue varianti locali (nella Val Canale, a Sappada e nella frazione di Timau, al confine con l'Austria, e Sauris); 2) lo sloveno nelle sue varianti locali (nella Val Canale, nella Benečija, nel Collio e sul Carso goriziano, in alcuni comuni della Bisiacaria e nella Val di Resia).
Sono presenti anche altri idiomi, tra cui si annoverano le parlate venete al confine occidentale (Provincia di Pordenone e Mandamento di Portogruaro), nella laguna di Marano Lagunare e Grado, nonché in Bisiacaria. In serio pericolo di estinzione è il dialetto veneto-udinese, del tutto abbandonato dalle nuove generazioni.
Vanno inoltre ricordate le parlate di Erto e Casso (al confine con il Veneto), oggi praticamente estinte in favore dell'italiano e del bellunese.
Musica
La forma più conosciuta della musica popolare friulana è la villotta. A partire dall'Ottocento si sviluppò un filone colto della musica popolare, ben rappresentato da Rodolfo Lipizer, Arturo Zardini e Orlando Dipiazza. Tra i brani popolari più famosi troviamo Stelutis Alpinis e O ce biel cjiscjel a Udin.
Fa parte del patrimonio musicale friulano anche il canto patriarchino.
Nel panorama musicale attuale si distinguono le figure di Luigi Maieron, Lino Straulino, Elisa, il trio Frizzi Comini Tonazzi, gli Arbe Garbe, i Kosovni Odpadki, gli ´Zuf de Žur, Giulio Venier, Dario Zampa, Aldo Rossi, Toni Merlot, i Beat Les, Sdrindule e i Madrac.
Arte
L'arte in Friuli fa la sua comparsa con i manufatti delle civiltà preromane (in particolare quella dei castellieri, quella venetica e quella celtica). Tuttavia è solo con l'età romana che si raggiunge un livello elevato nelle arti, tra le quali spiccano quelle minori della lavorazione delle pietre dure e del vetro ad Aquileia, nonché l'arte musiva.
Del periodo paleocristiano rimangono testimonianze imponenti nella basilica di Aquileia, in quelle di Grado e in quella di Concordia Sagittaria.
Durante l'età barbarica fiorì l'oreficeria longobarda, di cui sono testimonianza le collezioni del Museo Storico nazionale di Cividale del Friuli. Allo spesso periodo vanno ascritti gli altorilievi in stucco del tempietto longobardo di Cividale del Friuli, nonché l'Ara di Ratchis ed il Battistero di Callisto conservati nel duomo della stessa città.
Dell'età romanica sono testimonianza la basilica ed il campanile di Aquileia, nonché altri edifici religiosi minori (come la chiesa di Santa Maria in Castello di Udine). Nel periodo gotico il Friuli conobbe una certa vitalità artistica, che si tradusse nella costruzione dei duomi di Udine, Spilimbergo, Venzone, Gemona, Sacile e Pordenone. Scarse sono le testimonianze superstiti dell'architettura gotica civile; tra queste si segnalano i municipi di Pordenone e di Venzone nonché la Loggia del Lionello a Udine. In quel periodo fu attivo in Friuli il pittore Vitale da Bologna, che lasciò una testimonianza negli affreschi del duomo di Udine.
Con il Rinascimento si inizia a registrare il nome di pittori locali di un certo rilievo, come Pomponio Amalteo, Il Pordenone o Pietro Fuluto. In quel periodo il Friuli si inserì definitivamente nell'orbita artistica di Venezia, staccandosi dal tradizionale vincolo con l'arte d'Oltralpe che aveva trovato le sue ultime espressioni nelle sculture lignee di Domenico da Tolmezzo e della bottega dei Comuzzo. Per quanto riguarda l'architettura civile, si segnalano il castello di Udine (residenza del Luogotenente della Repubblica di Venezia), Villa Manin di Passariano e una serie di edifici minori. In quel periodo culturale fu anche iniziata la costruzione della città stellata di Palmanova.
Con il passaggio al barocco il Friuli rivela le conseguenze in campo artistico della sua divisione politica. Nel Friuli occidentale, infatti, predominano le tendenze artistiche diffuse da Venezia, che si concretano nella presenza di artisti come Giambattista Tiepolo (che affrescò, a Udine, il Palazzo Patriarcale, il Duomo, la Chiesa della Purità e diverse abitazioni nobiliari udinesi, tanto che Udine è conosciuta come la città del Tiepolo) e nella costruzione di ville nobiliari di campagna (delle quali la più nota è Villa Manin). Nel Friuli orientale, invece, si afferma il barocco austriaco, evidente nel duomo di Gorizia e nella Chiesa di Sant'Ignazio nella stessa città.
Il neoclassicismo attecchisce solo in parte in Friuli, che vede l'attività del pittore goriziano Giuseppe Tominz.
Tra la fine dell'Ottocento ed i primi del Novecento fa capolino l'Historizismus d'Oltralpe, che si esprime nella costruzione del Seminario Minore di Gorizia, in stile neoromanico.
Più di recente spiccano nel panorama artistico friulano nomi come quelli di Afro Basaldella, di Italico Brass e di Tina Modotti e l'architetto Raimondo D'Aronco.
Folklore
Il folklore friulano comprende una serie di manifestazioni che variano da zona a zona e sono particolarmente vive e diversificate nei territori di montagna.
Nell'area alpina si segnalano il tîr des cidulis, il carnevale di Resia (caratterizzato dalle maschere dai copricapi coloratissimi), e i carnevali delle zone di lingua tedesca (caratterizzati dalla presenza di maschere che assumono nomi diversi a seconda della località: Röller a Sauris, Krampus nella Val Canale, Maschkars e Jutalan a Timau).
Nel periodo compreso tra l'ultimo dell'anno e l'Epifania si svolgono anche delle questue rituali, che in alcuni villaggi sono effettuate da bambini travestiti da Re Magi.
Sempre nell'area alpina della Carnia si svolge la benedizione del Mac di Sant Zuan, un mazzo di fiori raccolti il giorno di San Giovanni. I fiori, una volta essiccati, vengono conservati e bruciati per scongiurare il mal tempo.
Per la festa dell'Ascensione a Zuglio si svolge il rito del Bacio delle Croci. La stessa cerimonia si svolge anche nel territorio della Pieve di Gorto e nelle Valli del Natisone.
Nelle aree collinari e pianeggianti si accendono, in occasione dell'Epifania, dei falò (in friulano pignarûl) da cui si traggono presagi per l'anno nuovo. A Grado (GO) si celebra la processione di barche conosciuta con il nome di Perdon de Barbana.
In tutto il Friuli sono diffusi gruppi corali o di ballo che eseguono canti o danze del repertorio tradizionale.
Gastronomia
La cucina friulana è il risultato del contatto della cucina dell'area padana con quella mitteleuropea. In generale abbondano le minestre, i piatti a base di carne di maiale e gli abbinamenti di dolce e salato. I piatti più conosciuti della cucina friulana sono i cjarçons (ravioli ripieni di cun farcia dolce-salata), il frico (piatto a base di formaggio fuso e patate rosolate nelle strutto), la brovada (piatto a base di rape inacidite sotto vinaccia e consumato assieme al muset), la gubana (dolce ripieno di frutta secca), il prosciutto di San Daniele e il prosciutto di Sauris. Tra i formaggi spicca il Montasio.
Tra i vini sono famosi soprattutto i bianchi della zona del Collio come il Tocai [60] e il Verduzzo. Di ottima qualità sono anche le produzioni di Merlot, Cabernet, Sauvignon e dei vitigni autoctoni poco diffusi come il Ramandolo e il Picolit.
Economia
Fino alla metà del novecento, soprattutto a causa delle distruzioni prodotte dagli eventi bellici, il Friuli si presentava come una una terra rurale e povera, al pari di gran parte d'Italia. Le scarse possibilità economiche furono all'origine di un consistente flusso migratorio diretto non solo verso i paesi europei, ma anche verso gli Stati Uniti, il Canada, l'Argentina e l'Australia. Attualmente la provincia di Udine è ai primi posti in Italia per qualità di vita, classificandosi nel 2007 al 10° posto (Il Sole 24 Ore), mentre quelle di Gorizia e di Pordenone si trovano rispettivamente al 22° e 35°.
Negli anni novanta si è verificata la grande apertura dell'economia regionale verso l'estero, favorita sia da fattori politici (come la fine della contrapposizione ideologica tra blocchi all'interno dell'Europa), sia da fattori monetari (la forte svalutazione della lira tra il 1993 ed il 1995). In questi anni l'export delle aziende friulane ha conosciuto una vera e propria esplosione, raddoppiando tra il 1992 ed il 1995. La parte del leone la facevano le province di Udine e Pordenone, seguite da quella di Gorizia. Le industrie meccaniche concentrano tuttora la maggiore quota di export a livello regionale, seguite da quelle del mobile. Le esportazioni agli inizi degli anni novanta erano dirette soprattutto verso alcuni paesi dell'allora CEE. In seguito esse sono state canalizzate sia verso altri mercati occidentali che verso le vicine Slovenia e Croazia. Queste ultime, ormai, considerate globalmente, occupano il secondo posto, dopo la Germania, nella classifica dei destinatari dei prodotti del Friuli. L'export, tuttavia, è solo una delle forme di internazionalizzazione, la meno sofisticata e la più a rischio. Ciò costituisce una debolezza del sistema produttivo regionale, le cui imprese non gestiscono direttamente i canali di scambio ma si affidano il più delle volte ad intermediari.
Il mercato del lavoro in Friuli è, dal punto di vista sociale, molto vicino all'optimum, ma la scarsità di manodopera rappresenta un cruccio per gli imprenditori. Con un tasso di disoccupazione bassissimo, molto vicino a quello strutturale, le aziende hanno fatto ricorso dapprima alla manodopera femminile (non completamente mobilitata fino agli anni novanta) ed in seguito a quella immigrata.
Agricoltura
| Template:Td sxZona di vino doc/docg | Template:Td dxSuperfice in ha |
|---|---|
| Template:Td sxFriuli Grave | Template:Td dx 6.047,85 |
| Template:Td sxColli Orientali del Friuli | Template:Td dx 2.071,18 |
| Template:Td sxCollio | Template:Td dx 1.390,93 |
| Template:Td sxFriuli Isonzo | Template:Td dx 1.281,82 |
| Template:Td sxFriuli Aquileia | Template:Td dx 763,29 |
| Template:Td sxFriuli Latisana | Template:Td dx 264,92 |
| Template:Td sxFriuli Annia | Template:Td dx 81,04 |
| Template:Td sxRamandolo | Template:Td dx 60,41 |
Produzione di vino doc/docg friulano
(fonte: Camere di commercio di Udine,
Pordenone e Gorizia, 2003)
L'agricoltura, arretrata quando costituiva quasi l'unica attività della Regione, non ha più l'importanza di un tempo, ma pur nelle sue ridotte dimensioni, è un settore di punta, ad alto contenuto tecnologico. Grande sviluppo ha avuto la viticoltura, con una produzione di qualità, e vini che competono con i più nobili del catalogo nazionale. A questo proposito va ricordato che il Friuli è sempre stato celebre, fin dall'epoca romana, per i suoi vini. Se i rossi friulani sono squisiti, i suoi eccezionali vini bianchi non sono da meno e da sempre sono apprezzati in tutto il mondo e considerati all'unanimità fra i migliori in Italia. Altra produzione di qualità è quella casearia, con formaggi di grande rinomanza, e quella ortofrutticola. Negli ultimi decenni si è diffusa la coltivazione del mais con rese unitarie da assoluto primato internazionale[61].
Nella tabella a destra si espongono i dati, prodotti a cura delle Camere di commercio di Udine, Pordenone e Gorizia, relativi agli ettari di produzione, nell'anno 2003, di vino friulano a denominazione di origine controllata (doc) ed a denominazione di origine controllata e garantita (docg).
Industria
Già XVIII secolo ebbe inizio una sensibile industrializzazione del Friuli. In particolare l'industria tessile conobbe, grazie al carnico Jacopo Linussio, una forte espansione in tutta la regione friulana. Nel secolo successivo si andò affermando l'industria della seta. L'industria friulana, uscita completamente distrutta da due guerre mondiali, riprese la sua espansione intorno agli anni sessanta con la creazione di quel forte tessuto di piccole industrie e imprese artigianali che costituiscono la base dello sviluppo del Nordest italiano; grande impulso allo sviluppo delle attività secondarie fu dato dalla nascita dei distretti industriali, tra cui ricordiamo il "triangolo della sedia", nella parte sud-orientale della provincia di Udine (Manzano, San Giovanni al Natisone, Corno di Rosazzo), i famosi prosciuttifici di San Daniele del Friuli, il distretto del mobile nella provincia di Pordenone (Brugnera).
Proprio a causa dell'importanza dell'industria serica, il paesaggio friulano è caratterizzato dalla presenza di filari di gelsi, delle cui foglie si nutrono i bachi da seta. Con la crisi dell'industria della seta del XX secolo, la coltivazione dei gelsi ha perso la sua funzione economica e, pertanto, attualmente è in rapida diminuzione il loro numero. A causa della diffusione e dell'importanza di questo tipo di albero, in alcuni dialetti lingua friulana (per esempio nella zona di Udine) la parola morâr, che originariamente indicava solo il gelso, è passata a significare "albero" in senso generico.
A Pordenone è presente anche la produzione di elettrodomestici con la ex Zanussi ora acquisita dalla svedese Electrolux. Nella zona di Udine all'industria siderurgica (Safau, Bertoli) ed alimentare (Birra Moretti) di un tempo si è sostituita una fitta rete di distribuzione commerciale di dimensioni medio-grandi concentrata specialmente a nord della città, mentre le industrie pesanti (acciaierie ABS, Danieli) si sono trasferite nell'hinterland udinese oppure lontano dal capoluogo (Pittini di Osoppo). Grande sviluppo ha avuto negli ultimi anni il distretto industriale dell'Aussa-Corno, incentrato sul porto fluviale di San Giorgio di Nogaro mentre a Cervignano del Friuli negli anni novanta è stato realizzato un importante interporto ferroviario per lo smistamento delle merci nelle direttrici nord-sud (Udine-Pontebbana) ed est-ovest verso la Slovenia e l'est europeo.
Terziario
In provincia di Udine, al 2005, circa due terzi della forza lavoro è ormai impegnata nel settore terziario. Fino ai primi anni novanta erano dislocati sul territorio friulano decine di migliaia di militari di leva, dal momento che il fronte orientale veniva considerato il più a rischio in caso di guerra. Ciò ha contribuito allo sviluppo del settore della ristorazione e del terziario in genere, anche se oggigiorno sono numerose le caserme inutilizzate. A Udine la scomparsa dei militari è stata compensata dalla presenza sempre maggiore di studenti universitari, grazie allo sviluppo costante dell'Università di Udine/Universitât dal Friûl considerata una delle più vivaci e attive tra le nuove Università italiane. Dal 2006 la banca austriaca Hypo Group Alpe Adria ha istituito la sua sede principale per l'Italia a Udine (Feletto Umberto).
Turismo
Una voce importante dell'economia friulana è costituita dal turismo, con le località balneari di Lignano Sabbiadoro e Grado (tra le maggiori mete dell'alto Adriatico), con il centro storico di Udine e con i numerosi agriturismi sparsi un po' in tutta la Regione. Nella stagione invernale le località alpine (Tarvisio, Forni di Sopra, Ravascletto, Sella Nevea, Piancavallo e Sappada) sono frequentate mete sciistiche. Sono inoltre mete turistiche la longobarda Cividale del Friuli, il centro medioevale di Venzone ed il sito archeologico di epoca romana di Aquileia. Dal punto di vista ambientale e naturalistico assume sempre maggiore importanza tutta la regione alpina della Carnia e l'oasi faunistica della Laguna di Marano.
Trasporti
La rete di trasporti via terra in Friuli è tuttora impostata sui due assi principali che furono individuati già in epoca romana. Infatti la direttrice Nord-Sud in epoca imperiale era rappresentata dalla così chiamata Via Iulia Augusta, che partendo da Aquileia si dirigeva verso il Norico attraverso i valichi alpini. La direttice Est-ovest, invece, corrispondeva alla Via Postumia, che collegava Genova alla Pannonia, passando per Aquileia.
Sia la rete autostradale che quella ferroviaria contemporanea seguono le stesse direttrici: l'A4, la della Venezia Giulia e la linea ferroviaria Venezia-Cervignano del Friuli-Trieste, infatti, corrono parallele alla Via Postumia. L'A23, la Pontebbana e la linea ferroviaria Cervignano-Udine-Tarvisio seguono l'antica Via Iulia Augusta.
Per quanto riguarda il trasporto aereo va segnalata la presenza dell'Aeroporto internazionale "Friuli Venezia Giulia" a breve distanza da Ronchi dei Legionari.
Linee ferroviarie
Il primo tronco ferroviario di una certa importanza fu aperto in Friuli nel 1855, durante la dominazione austriaca, e collegava Mestre a Casarsa. Cinque anni più tardi (1860) fu inaugurata la strada ferrata che congingeva Codroipo a Trieste passando per Udine, Gorizia e Monfalcone. La terza guerra di indipendenza e l'annessione del Friuli centrale e occidentale al Regno d'Italia (mentre il Friuli orientale era rimasto sotto la sovranità austriaca), rallentò per qualche anno la realizzazione di alcune ambiziose linee ferroviarie che però nell'ultimo quarto dell'ottocento videro la luce, come la Udine-Pontebba (1879) e quella che congiungeva Mestre a Monfalcone (1897) passando per Cervignano. La rete ferroviaria friulana poteva dirsi già realizzata in gran parte alla vigilia della prima guerra mondiale e nella sua quasi totalità all'inizio del secondo conflitto mondiale.
Linee principali
- (Venezia)-Sacile-Casarsa-Udine
- Udine-Tarvisio
- Udine-Gorizia-Monfalcone
- (Venezia)-Cervignano-Monfalcone-(Trieste)
Linee secondarie
- Ferrovia Casarsa - Portogruaro
- Udine-Cervignano
- Gemona-Sacile
- Gorizia-confine di stato (Nova Gorica)
- Ferrovia Udine-Cividale.
Rete stradale e autostradale
In Friuli una rete statale moderna iniziò a svilupparsi solo agli inizi del XIX secolo per volere di Napoleone Bonaparte e con finalità prettamente militari. In questo periodo furono costruite sia la strada Euganea che congiungeva Udine a Treviso, sia la Napoleonica, fra Codroipo e Palmanova. In età austriaca (1815-1866) e ancor più con l'annessione del Friuli all'Italia (la parte orientale restò però sotto il dominio austriaco fino al 1918) si andò gradualmente articolando quella che poi sarebbe stata la fitta rete viaria della regione che, alla vigilia della seconda guerra mondiale poteva dirsi ormai completata (con l'esclusione di quella relativa alle autostrade).
In epoca fascista venne inaugurata la prima autostrada italiana (1927), la Serenissima (A4), che congiungeva Torino a Trieste passando per il Friuli meridionale. Si dovettero attendere circa sessant'anni per l'apertura (1986) di un'altra arteria di vitale importanza per la Regione: l'autostrada Alpe Adria (A23), mentre la terza autostrada che attraversa (in parte) la regione storica friulana, la Conegliano-Portogruaro, non è stata ancora, a tutt'oggi, completata.
Strade statali
- S.S 13 Pontebbana
- S.S 14 della Venezia Giulia
- S.S 54 del Friuli
- S.S 56 di Gorizia
- S.S 251 Strada Statale 251 della Val di Zoldo e Val Cellina
- S.S 252 Strada Statale 252 di Palmanova
- S.S 351 Strada Statale 351 di Cervignano
- S.S 352 di Grado
- S.S 353 della Bassa Friulana
- S.S 354 di Lignano
- S.S 355 di Val Degano
- S.S 356 di Cividale
- S.S 409 di Plessiva
- S.S 463 del Tagliamento
- S.S 465 della Forcella Laverdet e di Valle San Canciano
- S.S 512 del Lago di Cavazzo
- S.S 552 del Passo Rest
- S.S 646 di Uccea
Autostrade
Il Friuli è attraversato da 3 autostrade:
- l'A4 Serenissima da Torino-Trieste che solca la bassa pianura friulana da Latisana a Villesse;
- l'A23 Alpe Adria da Palmanova-Tarvisio che attraversa il Friuli in direzione nord-sud dal confine di stato con l'Austria all'innesto con l'A4
- l'A28 Portogruaro-Conegliano, attualmente termina a Godega di Sant'Urbano, poco dopo Sacile, è in fase di realizzazione il tratto terminale sino all'innesto con la A27
Trasporto aereo
L'unica struttura di rango internazionale presente sul territorio è l'aeroporto Friuli Venezia Giulia, situato nel territorio comunale di Ronchi dei Legionari. L'aeroporto, aperto nel 1961, dispone di un ampio parcheggio e di un terminal merci di quasi 3.000 mq. È collegato tramite un raccordo a doppia carreggiata con l'autostrada A4 e da un servizio di autobus con le città di Trieste, Udine e Monfalcone. La scarsa offerta di destinazioni disponibili e la presenza del vicino scalo veneziano, non hanno tuttavia mai permesso a questo aeroporto di svilupparsi adeguatamente, soprattutto in considerazione del vasto bacino di utenza che possiede (circa quattro milioni e mezzo di persone distribuite fra Italia, Austria, Slovenia e Croazia).
Curiosità
- A Ovest di Udine, nella base aerea di Rivolto, ha sede la Pattuglia Acrobatica Nazionale, le famose Frecce Tricolori. A Campoformido, inoltre, nell' aeroporto locale che ha visto nascere le Frecce, ha sede il Parco del Volo.
- Il Monte Zoncolan (1750 m.), in Carnia, ha fama di essere, fra gli appassionati di ciclismo, la salita più dura d'Europa: 1.210 metri di dislivello, fra l'abitato di Ovaro e la sua cima, da percorrersi in circa 10 km, con una pendenza media dell'11% ed oltre! Tale caratteristica ha spinto gli organizzatori del Giro d'Italia ad includere ripetutamente tale salita fra le tappe della competizione.
- L'autore della più bella storia romanzata sulla fine del Patriarcato di Aquileia è ...un veneto, Elio Bartolini[62], noto scrittore e cineasta di Conegliano. Nel suo Pontificale in San Marco, Bartolini descrive magistralmente due mondi in crisi: quello veneziano, alle soglie del suo orgoglioso tramonto, e quello friulano, fieramente contrapposto alla Serenissima, che lo sta privando del simbolo stesso della sua storia millenaria e della sua identità.
- Palmanova è una fortezza stellata costruita dai Veneziani per esigenze difensive; nel mondo esistono solo altre 8 città con tale struttura.
- Diversi comuni e località del Friuli presentano toponimi di origine friulana terminanti in 'ars', 'ons', 'ins' e simili; tali nomi vanno pronunciati con l'accento lungo sull'ultima vocale, non sulla prima come spesso capita di sentire. Avremo dunque Gonàrs, Cormòns e così via.
Artisti
- Pomponio Amalteo, pittore rinascimentale
- Giovanni da Udine, pittore
- Tina Modotti, fotografa e attrice
- Il Pordenone, pittore rinascimentale
- Nicolò Grassi, pittore
- Luca Carlevarijs, pittore
- Afro Basaldella, scultore
- Raimondo D'Aronco, architetto
Letterati, filosofi e teologi
- Pier Antonio Bellina, scrittore e traduttore
- Mauro Corona, scrittore
- Paolo Flores D'Arcais, filosofo e politologo
- Ermenegildo Florit, cardinale e teologo
- Paolo Maurensig, romanziere
- Carlo Michelstaedter, filosofo
- Pier Paolo Pasolini, poeta e scrittore
- Francesco Placereani, traduttore e oratore
- Carlo Sgorlon, scrittore
- Achille Tellini, linguista (uno dei padri dell'esperanto)
Musicisti
- Orlando Dipiazza, compositore di musica corale
- Elisa, cantante
- Rodolfo Lipizer, compositore
- Gian-Paolo Martini, musicista, compositore
- Cecilia Seghizzi, musicista, compositrice
- Arturo Zardini, compositore
- Giorgio Mainerio, compositore
Scienziati
- Graziadio Isaia Ascoli, linguista
- Carlo Rubbia, Premio Nobel per la fisica
- Arturo Malignani, scienziato
- Antonio Zanon, economista
- Bonaldo Stringher, economista
Sportivi
- Enzo Bearzot, commissario tecnico della nazionale campione del mondo 1982
- Ottavio Bottecchia, ciclista, vincitore di due Tour de France
- Tarcisio Burgnich, storico terzino della nazionale italiana
- Paolo Camossi, campione mondiale indoor e finalista olimpico di salto triplo
- Fabio Capello, allenatore di calcio
- Primo Carnera, pugile campione del mondo dei pesi massimi
- Roberto Chiacig, giocatore della nazionale di pallacanestro
- "Gigi" De Agostini, ex-calciatore della nazionale e di Udinese e Juventus
- Giorgio Di Centa, sciatore pluricampione olimpico
- Manuela Di Centa, sciatrice pluricampionessa olimpica
- Fulvio Collovati, nazionale di calcio campione del mondo 1982
- Giacomo Galanda, capitano della nazionale di pallacanestro
- Giacomo Kratter, snowborder
- Michele Mian, giocatore della nazionale di pallacanestro
- Edi Orioli, motociclismo: enduro, motorally. Vincitore di varie edizioni Parigi-Dakar
- Gabriella Paruzzi, sciatrice campionessa olimpica
- Pietro Piller Cottrer, sciatore campione olimpico
- Bruno Pizzul, giornalista sportivo
- Daniele Pontoni, ciclista, più volte campione del mondo di ciclocross
- Gianmarco Pozzecco, giocatore della nazionale italiana di basket
- Edoardo Reja, allenatore del Napoli Calcio
- Elisa Togut, giocatrice della nazionale italiana di pallavolo
- Paolo Vidoz, pugile professionista, campione italiano e medaglia di bronzo olimpica nei dilettanti
- Alessandro Zanni, giocatore della nazionale di rugby
- Dino Zoff, allenatore e portiere della nazionale campione del mondo 1982
Viaggiatori ed esploratori
- Ardito Desio, alpinista
- Beato Odorico da Pordenone, missionario e esploratore
- Pietro Savorgnan di Brazzà, esploratore
Cinema e spettacolo
- Giuseppe Battiston, attore
- Andrea Pellizzari (disc jockey), conduttore televisivo e radiofonico
Comuni del Friuli storico
Template:Provincia di Udine Template:Provincia di Pordenone Template:Provincia di Gorizia
Galleria fotografica
-
Piazza Libertà a Udine
-
Municipio di Pordenone
-
Vista di Sacile
-
Palazzo Comunale di Portogruaro
-
Cattedrale di Concordia Sagittaria
-
Vista di Cividale del Friuli
-
Duomo di Gemona del Friuli
-
Castelletto di Artegna
-
Piazza d'armi di Palmanova
-
Il Monte Bìvera presso Sauris
-
Alpi Giulie: Il Jôf Fuart
-
Monti di Sappada
-
Flora friulana: Wulfenia
Note
- ^ Va ricordato che in un referendum tenutosi nel 2006 la maggioranza relativa della popolazione del mandamento (escluso il Comune di Portogruaro dove non si è votato) si è espressa a favore del ricongiungimento
- ^ A questo proposito vedi: Arrigo Lorenzi (a cura di), Il Friuli come regione naturale e storica, Atti del XIII Congresso geografico italiano, vol. I, Udine 1938
- ^ Vedi a questo proposito nota n.1
- ^ Per ulteriori approfondimenti vedi: Autori vari, L'Italia, Friuli Venezia Giulia, pag. 20-57, Touring Editore S.r.l. e La Biblioteca di Repubblica , Vol. XXI Milano 2005,
- ^ Il Friuli non coincide con la Regione Friuli Venezia Giulia. In questa voce enciclopedica ci si attiene alla definizione storica dei confini del Friuli. La definizione dei confini sud-orientali del Friuli (fiume Timavo) è attualmente oggetto di polemiche a livello locale, a causa della sovrapposizione del territorio friulano con quello, di più recente definizione, della Venezia Giulia.
- ^ Pier Silverio Leicht, I diplomi imperiali concessi ai patriarchi d’Aquileja, pag. 157, Pagine Friulane, a. VII (1894), n. 10, Udine 1888-1894
- ^ Rienzo Pellegrini, Tra lingua e letteratura. Per una storia degli usi scritti del friulano, pag.101, Casamassima, Udine 1987
- ^ Rienzo Pellegrini, Tra lingua e letteratura. Per una storia degli usi scritti del friulano, pag.101, Casamassima, Udine 1987
- ^ Commentarii di Giovan Candido giureconsulto dei Fatti d’Aquileia, Pradamano, 1926, pagg. 1-2
- ^ Girardi G. (1841), Storia fisica del Friuli, San Vito, Pascali, pagg. 52-53
- ^ Rienzo Pellegrini, Tra lingua e letteratura. Per una storia degli usi scritti del friulano, pag.101, Casamassima, Udine 1987
- ^ Rienzo Pellegrini, Tra lingua e letteratura. Per una storia degli usi scritti del friulano, pag.101-102, Casamassima, Udine 1987
- ^ Partenopeo H. (1604), Descrittione della nobilissima Patria del Friuli, Con l’origine de i popoli, delle Città, delle Castella, et di molti altri luoghi, che in essa si ritrovano, Udine, Gio. Battista Natolini, pag. 1
- ^ Maniago P. (1797), Il Friuli. Poemetto del Conte Pietro Maniago pubblicato compiendo la reggenza di Udine l’Eccellentissimo Signore Angelo I.° Giustinian, Venezia, Tipografia Curti Q. Giacomo, pag. 2
- ^ Rienzo Pellegrini, Tra lingua e letteratura. Per una storia degli usi scritti del friulano, pag.101, Casamassima, Udine 1987
- ^ Rienzo Pellegrini, Tra lingua e letteratura. Per una storia degli usi scritti del friulano, pag.101-103, Casamassima, Udine 1987
- ^ Brumatti de Jacomino e Sigisberg G. (1682), L’aquila leone di Gorizia ossia il Contado Principato goriziano uno degli incliti immediati stati del S. R. I., ms
- ^ Rienzo Pellegrini, Tra lingua e letteratura. Per una storia degli usi scritti del friulano, pag.105, Casamassima, Udine 1987
- ^ Liruti G. G. (1776-1777), Notizie delle cose del Friuli, Udine, Fratelli Gallici, vol. I, pag 46
- ^ Liruti G. G. (1776-1777), Notizie delle cose del Friuli, Udine, Fratelli Gallici, vol. I, pagg. 35-36
- ^ Liruti G. G. (1776-1777), Notizie delle cose del Friuli, Udine, Fratelli Gallici, vol. I, pagg. 37-38
- ^ Liruti G. G. (1776-1777), Notizie delle cose del Friuli, Udine, Fratelli Gallici, vol. I, pagg. 63-64
- ^ Girardi G. (1841), Storia fisica del Friuli, San Vito, Pascali, pagg. 51-52
- ^ Valussi citato in: Micelli F. (1997), Della storia naturale alla geografia del Risorgimento. Riflessionisull’attività scientifica di Giulia Andrea Pirona, in: Vecchiet R. (cur.), Giulio Andrea Pirona 1822-1895. Atti del Convegno di studi nel centenario della morte, s.l., Comitato per le celebrazioni di Giulio Andrea Pirona, pp. 11-23, pag. 15
- ^ Carli P., P. Valussi (1853), Rapporto della Camera di Commercio e d’Industria della Provincia del Friuli all’Eccelso I. R. Ministero del commercio, dell’industria e delle pubbliche costruzioni sullo stato dell’industria e del commercio della propria provincia negli anni 851 e 1852, Udine, Tipografia Trombetti-Murero
- ^ Carli P., P. Valussi (1853), Rapporto della Camera di Commercio e d’Industria della Provincia del Friuli all’Eccelso I. R. Ministero del commercio, dell’industria e delle pubbliche costruzioni sullo stato dell’industria e del commercio della propria provincia negli anni 851 e 1852, Udine, Tipografia Trombetti-Murero, pag. 24
- ^ Valussi P. (1967), Dalla memoria d’un vecchio giornalista dell’epoca del Risorgimento italiano, Udine, Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Udine, pag. 194
- ^ Pirona citato in: Micelli F. (1997), Della storia naturale alla geografia del Risorgimento. Riflessionisull’attività scientifica di Giulia Andrea Pirona, in: Vecchiet R. (cur.), Giulio Andrea Pirona 1822-1895. Atti del Convegno di studi nel centenario della morte, s.l., Comitato per le celebrazioni di Giulio Andrea Pirona, pp. 11-23, pag. 16
- ^ Marchetti G. (1974), Friuli. Uomini e tempi, Udine, Società Filologica Friulana, pag. 575
- ^ Antonini P. (1865), Il Friuli Orientale, Milano, Vallardi, pagg. 533-534
- ^ Antonini P. (1873), Del Friuli ed in particolare dei trattati da cui ebbe origine la dualità politica di questa regione, Venezia, Naratovich, pag. 2
- ^ Carli P., P. Valussi (1853), Rapporto della Camera di Commercio e d’Industria della Provincia del Friuli all’Eccelso I. R. Ministero del commercio, dell’industria e delle pubbliche costruzioni sullo stato dell’industria e del commercio della propria provincia negli anni 851 e 1852, Udine, Tipografia Trombetti-Murero, pag. 31
- ^ di Manzano F. (1894), Cenni storici sui confini del Friuli e la sua nazionalità, Pagine Friulane, a. VII, n. 3, pp. 42-43, pag. 42
- ^ Antonini P. (1873), Del Friuli ed in particolare dei trattati da cui ebbe origine la dualità politica di questa regione, Venezia, Naratovich, pag. 489
- ^ di Manzano F. (1876), Compendio di storia friulana, Udine, Tipografia di Gio. Batt. Doretti e Soci, pag. 5
- ^ Micelli F. (1997), Della storia naturale alla geografia del Risorgimento. Riflessionisull’attività scientifica di Giulia Andrea Pirona, in: Vecchiet R. (cur.), Giulio Andrea Pirona 1822-1895. Atti del Convegno di studi nel centenario della morte, s.l., Comitato per le celebrazioni di Giulio Andrea Pirona, pp. 11-23, pag. 19
- ^ del Torre G. F. (1892), Il Contadinel. Lunari par l’an bisest 1892, Gorizia, Seitz, pag. 52
- ^ di Manzano F. (1894), Cenni storici sui confini del Friuli e la sua nazionalità, Pagine Friulane, a. VII, n. 3, pagg. 42-43
- ^ Valentinis G. (1903), In Friuli, Udine, Fratelli Tosolini Editori, pag. 6
- ^ Per ulteriori approfondimenti vedi: Autori vari: Conoscere l'Italia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, pag.164 e seguenti (la parte oggetto del rif. è stata interamente scritta da Giorgio Valussi), Istituto Geografico de Agostini, Novara 1979
- ^ Ricordiamo che non esiste unanimità di giudizi sull'appartenenza del Mandamento di Portogruaro e del Comune di Sappada alla regione storico-geografica friulana: vedi a tale proposito quanto segnalato nell' Incipit e nella Scheda Regione
- ^ Citazione tratta da Pio Paschini, Storia del Friuli (Volume 2), pagina 439, Arti Grafiche Friulane, Udine, 1975
- ^ Citazione tratta da Strabone, Geografia, V libro, 1-8. Il V libro è, insieme al VI, dedicato all'Italia (il testo entro le parentesi non è di Strabone)
- ^ Liberamente ispirato alla seguente fonte: www.altrofriuli.com
- ^ Citazione tratta da A. Ventura, Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500, Bari 1964, riportata da: Storia d'Italia Libro I, Autori vari, Einaudi 1974 ed. speciale il Sole 24 Ore, Milano 2005, pag. 374 (parte scritta da Antonio Vivanti, la Storia politica e sociale, dall'avvento delle Signorie all'Italia spagnola)
- ^ Citazione tratta da Elisabeth Crouzet-Pavan, Venezia trionfante gli orizzonti di un mito, pag. 212, Editore Giulio Einaudi, Torino 2001. (L'autrice è docente di Storia medioevale alla Sorbona - Parigi - e ha dedicato alla storia di Venezia studi ritenuti fondamentali)
- ^ Guido Quazza, La decadenza italiana nella Storia europea - pag. 35-51 Einaudi, Torino 1971
- ^ Citazione tratta da: AA. VV. Storia d'Italia Libro I, pag. 373, Einaudi 1974 ed. speciale il Sole 24 Ore, Milano 2005, (parte scritta da Corrado Vivanti, la Storia politica e sociale, dall'avvento delle Signorie all'Italia spagnola)
- ^ Giorgio Valussi, Il Confine nordorientale d'Italia, pag.85, edizioni Lint Trieste, 1972 (pubblicato dall'Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia)
- ^ Tito Maniacco, Storia del Friuli, pag. 106, Editore Newton & Compton, Roma, edizione del 2002
- ^ Pio Paschini, Storia del Friuli, pag.784, Arti Grafiche Friulane, Udine, edizione 1975
- ^ Tito Maniacco, Storia del Friuli, pag. 110 e seg., Editore Newton & Compton, Roma, edizione del 2002
- ^ È del 12 febbraio 1980 la prima richiesta del Consiglio comunale di S.Michele al Tagliamento (mandamento di Portogruaro - provincia di Venezia) di aggregarsi alla regione Friuli-Venezia Giulia. A questo proposito vedi Nelso Tracanelli, S.Michele al Friuli? edizione La Bassa, S. Michele al Tagliamento, dicembre 1981
- ^ Marco Duranti, Gorizia tra autonomismo e antiautonomismo, in: A. Agnelli / S. Bartole (cur.), La Regione Friuli – Venezia Giulia. Profilo storico-giuridico tracciato in occasione del 20° anniversario dell'istituzione della Regione, Il Mulino, Bologna, 1987
- ^ Anna Maria Preziosi, Udine e il Friuli dal tramonto dell'Italia liberale all'avvento del fascismo: le aspirazioni autonomistiche di Girardini, Pisenti e Spezzetti, in: A. Agnelli / S. Bartole (cur.) , La Regione Friuli – Venezia Giulia. Profilo storico-giuridico tracciato in occasione del 20° anniversario dell'istituzione della Regione, pag. 125, Il Mulino, Bologna, 1987
- ^ Sergio Tavano (1999), Gorizia nel 1919 (e oltre). Dall'abbraccio friulano alla soppressione della provincia, pag.190, Ce Fastu?, LXXV, 2, 1999)
- ^ Marco Duranti, Gorizia tra autonomismo e antiautonomismo, in: A. Agnelli / S. Bartole (cur.), La Regione Friuli – Venezia Giulia. Profilo storico-giuridico tracciato in occasione del 20° anniversario dell'istituzione della Regione, pag. 179, Il Mulino, Bologna, 1987
- ^ Marco Scroccaro, Dall'aquila bicipite alla croce uncinata. L'Italia e le opzioni nelle nuove province. Trentino, Sudtirolo, Val Canale (1919-1939). Museo Storico, Trento, 2000
- ^ «Tutti questi rancori non gli impedirono di cambiare orientamento...quando fiutò il pericolo di separatismo anti-italiano, come testimoniano le sue invettive contro il movimento friulano...» cit.tratta dal cap. di Renate Lunzer Irredenti redenti. Una dialettica italo-austriaca da Roberto Finzi, Claudio Magris e Giovanni Miccoli (a cura di), Storia d'Italia, le Regioni dall'unità a oggi. Il Friuli Venezia Giulia Tomo II pag. 1221, Giulio Einaudi Editore, Torino 2002
- ^ Il nome Tocai è stato al centro di un contenzioso con l'Unione Europea, per la sua similarità di denominazione con il Tokaj ungherese, nonostante la chiara differenza tra i due vini. Dal 31 marzo 2007 è proibito l'uso della denominazione Tocai per il vitigno friulano.
- ^ Antonio Saltini, Eugenio Segalla, Dieci secoli di agricoltura, 50 anni di Coldiretti, Udine 1995.
- ^ In realtà Elio Bartolini (1922 - 2006) si trasferì, adolescente, a Codroipo con la famiglia. Durante gli anni di guerra, fu partigiano nelle Alpi Giulie e nel Carso, approfondendo i suoi legami con il Friuli e la sua gente. Nel dopoguerra lo scrittore visse quasi ininterrottamente in Friuli, salvo un breve periodo passato a Roma.
Autori classici
- Tito Livio, Ab Urbe Condita
- Strabone, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ (Geografia), Libro V
Bibliografia
- Graziadio Isaia Ascoli Saggi ladini, Archivio Glottologico Italiano, Milano, 1873;
- AA.VV. - Aquileia - gli affreschi nella cripta della Basilica, edito dalla Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone 1976 - Udine;
- AA.VV. - Tieris di Aquilee - (Miti, fiabe e leggende del Friuli storico, primo volume), Istituto A.Tellini e Chiandetti, Reana del Rojale, 1997;
- AA.VV. - Cjanâl dal Fier - (Miti, fiabe e leggende del Friuli storico, secondo volume), Istituto A.Tellini e Chiandetti, Reana del Rojale, 1999;
- AA.VV. - Tieris di Cividât e de Badie di Rosacis (Miti, fiabe e leggende del Friuli storico, terzo volume), Istituto A.Tellini e Chiandetti, Reana del Rojale, 2000;
- AA.VV. Tieris di Tisane e di Puart - (Miti, fiabe e leggende del Friuli storico, quarto volume), Istituto A.Tellini e Chiandetti, Reana del Rojale, 2001;
- AA.VV. - Lagune de Gravo e de Maran - (Miti, fiabe e leggende del Friuli storico, quinto volume), Istituto A.Tellini e Chiandetti, Reana del Rojale, 2002;
- AA.VV. Friûl des culinis - I - (Miti, fiabe e leggende del Friuli storico, sesto volume), Istituto A.Tellini e Chiandetti, Reana del Rojale, 2004;
- AA.VV. Miniatura in Friuli- crocevia di civiltà, Grafiche Editoriali Artistiche Pordenonesi - Deputazione di storia patria per il Friuli - Convegno internazionale a Passariano Udine 4-5 ottobre 1985 - Pordenone 1985;
- AA.VV. Monfalcon - Società Filologica Friulana - Udine 2006;
- AA.VV. - Il Tagliamento - Cierre edizioni - Sommacampagna (VR)- a cura dell'Università di Udine, Cierre edizioni, Circolo Menocchio - 2006;
- Renzo Balzan, Deutsch Friaul - Friûl todesc , Ribis, Udine 1997;
- Anna Bogaro, Marketing furlan, Camera di Commercio di Udine, 2005;
- Elisabeth Crouzet Pavan, Venezia trionfante, gli orizzonti di un mito , Editore Enaudi,Torino 2001;
- Gianfranco D'Aronco, Miscellanea di studi e contributi (1945- 2000)- - Università degli studi di Udine - Centro internazionale per la ricerca sulla cultura e la lingua del Friuli - Società Filologica Friulana - Udine 2003;
- Antonio De Cillia, Friuli regione di passaggio - dagli scambi neolitici all'attuale economia mondo - Editrice Universitaria Udinese srl - Udine 2002;
- Gianfranco Ellero, Storia dei friulani, - Arti Grafiche Friulane, Udine, ed. 1977;
- Gianfranco Ellero, Viaggio in Friuli 1965-1978, Arti Grafiche Friulane, Udine 1978;
- Gianfranco Ellero, Borghesan C. Gjeografie furlane, Società Filologica friulana, Udine, 2001;
- Franco Fabbro, Il cjâf dai furlans , Kappa Vu edizioni, Udine 2000;
- Franco Finco, Barbara Cinausero, Ermanno Dentesano, Nons furlans di luc/Nomi friulani di luogo, Società Filologica Friulana, Udine, 2004;
- Renato Jacumin, Lotte contadine nel Friuli orientale, Doretti, Udine 1974;
- Tito Maniacco, Storia del Friuli, ed. Newton & Compton, Roma 2002;
- Giuseppe Marchetti, Le chiesette votive del Friuli, Società Filologica Friulana, Udine 1972;
- Mario Martinis, Le Rogge di Udine e Palma - Edizione Ribis - Udine - dicembre 2002;
- Gian Carlo Menis, Storia del Friuli, Società Filologica Friulana, Udine - II ed. 1974;
- Gian Carlo Menis, I mosaici cristiani di Aquiliea, Del Bianco, Udine 1965;
- A.Missio e G. Toniutti,Antiche case friulane, Roberto Vattori Ed., Tricesimo (UD) 1987;
- Faustino Nazzi, Il Duce lo vuole - la probizione dello sloveno nella vita religiosa della Slavia Friulana - Cooperativa Lipa Editrice - S.Pietro al Natisone 1995;
- Faustino Nazzi, La proibizione dell'uso della lingua tedesca nella vita liturgica della Val Canale - Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione - Udine 1984;
- Pio Paschini, Storia del Friuli, Arti Grafiche Friulane, Udine 1975;
- Francesco Placereani, La nestre storie, Associazion dai Longobarts, (testi in friulano, italiano, tedesco e inglese), Cividale 1990;
- Guido Quazza, La decadenza italiana nella storia europea, Einaudi - Torino 1971;
- Aldo Rizzi, Tiepolo a Udine - Palazzo Arcivescovile, Duomo, Chiesa della Purità e Musei -Del Bianco Editore - 1974;
- Aldo Rizzi, "Mostra della Pittura Veneta del Settecento in Friuli", 1966;
- Aldo Rizzi, "Il Friuli", Del Bianco - Udine 1970;
- Aldo Rizzi, "Capolavori d'arte in Friuli", Electa - Milano 1976;
- Aldo Rizzi, "Friuli-Venezia Giulia", Electa - Milano 1979;
- Aldo Rizzi, "Profilo di storia dell'arte in Friuli - dalla Preistoria al Gotico, Del Bianco -Udine 1975;
- Aldo Rizzi, "Il Seicento", Del Bianco - Udine 1969;
- Aldo Rizzi, "Il Settecento, Del Bianco - Udine 1967;
- Bruno Rossi La musica in Friuli, Ribis, Udine, 1979;
- Antonio Saltini, Eugenio Segalla, Dieci secoli di agricoltura, 50 anni di Coldiretti, Udine 1995;
- Sergio Salvi Il Friuli, in Le nazioni proibite , Valecchi, Firenze, 1973;
- Sergio Salvi La minoranza ladino-friulana in Le lingue tagliate, Rizzoli editore, Milano 1975;
- Giorgio Valussi, Il Confine nordorientale d'Italia, Ed. Lint - Trieste 1972;
- Guido Zannier El Friulano, Departimento de Linguistica de la Universidad Montevideo, Montevideo, 1972.
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Il Friuli.it
- Friuli.net
- Il Nuovo Friuli
- (FUR) La patrie dal Friûl
- Ente Friuli nel mondo
- (ES) Friulanos en Argentina
- Fogolârs furlans nel mondo
- Castelliere vista aerea (google maps), in comune di Mereto di Tomba (Udine) località Castelliere.
- [1] - mensile in lingua friulana scaricabile gratuitamente e finanziato dalla regione Friuli-VG. Il sito è stato creato nel 2007.
- [2] - sito della Provincia di Udine dedicato interamente alle minoranze linguistiche (friulani - sloveni - germanofani). Sono presenti le sezioni storia, lingua, letteratura e corso interattivo di lingua friulana. Le sezioni relative alla lingua slovena e tedesca, sono in preparazione. Il sito è stato creato nel 2007.
