Manfredi di Sicilia
Manfredi di Sicilia detto anche Manfredi di Svevia o Manfredi di Hohenstaufen (1232 — † Benevento 26 febbraio 1266), era figlio dell'imperatore svevo Federico II e di Bianca Lancia. Fu reggente dal 1250 e quindi re di Sicilia dal 1258. Morì durante la Battaglia di Benevento, sconfitto dalle truppe di Carlo I d'Angiò.
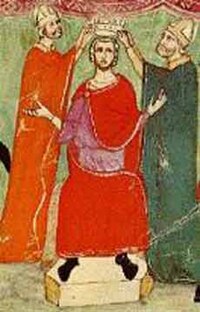
Biografia
Manfredi nacque nel 1232 da una relazione extra coniugale di Federico II con Bianca Lancia e venne legittimato da nozze postume.
Si narra che l'imperatore avrebbe avuto una particolare predilezione fra tutti i suoi figli verso Manfredi ed Enzo, stranamente entrambi nati da relazioni non coniugali. Manfredi, che dagli Svevi e soprattutto da Federico aveva eredito lo spirito combattivo e la passione, inoltre era anche figlio di Bianca Lancia, forse l'unico vero amore dell'imperatore.
Nel 1247 sposò Beatrice di Savoia (n. circa 1223-† circa1257), figlia del conte Amedeo IV e Margherita II di Borgogna e da cui ebbe una figlia Costanza (1249).
La reggenza in Sicilia
Assistette in punto di morte il padre il 13 dicembre 1250 ed assunse per disposizione testamentaria dello stesso Federico la carica di reggente del Regno di Sicilia per conto del fratellastro Corrado IV che in quel momento era impegnato in Germania.
Purtoppo una serie di vicissitudini opporranno Manfredi a Corrado, tanto che quest'ultimo fu costretto a tornare dalla Germania con al seguito un esercito, sbarcando a Siponto (oggi Manfredonia) nell'agosto del 1252 nel tentativo di riprendere possesso del regno di Sicilia. Tuttavia Corrado morirà nel 1254 a Lavello (PZ) per malaria (anche se alcune voci parlarono addirittura di fratricidio, commesso proprio da Manfredi) ed il suo tentativo sarà vano.
Lo scontro con il papato
Il papato non vide mai di buon occhio l'insediamento della casa imperiale di Svevia nel regno di Sicilia, in quanto considerava quel territorio come proprio vassallo. Inoltre con la morte di Federico II il papa Innocenzo IV pensava di essersi liberato definitivamente delle intromissioni e della influenza della casata di Svevia. In questo contesto Manfredi si trovò da subito in chiaro dissidio con il Pontefice. Dichiarato dal Papa l'usurpatore di Napoli egli fu scomunicato nel luglio del 1254 ma, grazie alla fine abilità diplomatica ereditata dal padre, riusciva già nel novembre dello stesso anno a farsi eleggere reggente di Sicilia dal Papa stesso e farsi revocare la scomunica in cambio del riconoscimento dello status di regno vassallo del papato.
Nel corso del 1254 favorì molto Siena ed i centri ghibellini in Toscana. A Siena ad esempio fornì il supporto militare di diversi corpi di cavalieri germanici, una forza che permise al centro toscano di poter sconfiggere la rivale guelfa Firenze. Manfredi riuscì ad ottenere in Toscana una forta influenza sulla Lega formata dalle città filo-ghibelline anche se il potere Svevo erano oramai inesorabilmente in declino.
Tuttavia egli considerava il Regno di Sicilia naturalmente svevo, tanto che già nel 1255 organizzò una prima rivolta in Puglia contro le truppe pontificie.
Nel 1256 fondò la città di Manfredonia, in Puglia.
Nel 1257 Manfredi sposava in virtù di una serie di accordi diplomatici Elena Ducas (n.1235-† Lucera circa 1271) figlia del despota d'Epiro Michele II.
Il 10 agosto 1258 fu eletto dai baroni re di Sicilia, venendo incoronato nella cattedrale di Palermo ma l'elezione non venne riconosciuta dal Papa Alessandro IV. Eletto al soglio pontificio Urbano IV questi scomunico nuovamente Manfredi ed offrì nel 1263 il Regno di Sicilia e quello di Piemonte a Carlo I d'Angiò. L'anno successivo avrebbe investito Carlo della nomina Re di Sicilia: i Francesi d'Angiò venivano ufficialmente chiamati in Italia per una sorta di Santa Crociata nei confronti degli Svevi. Nello stesso anno 1264 moriva il Pontefice Urbano IV, a questi succedeva Clemente IV che proseguì la politica anti-sveva a favorì ulteriormente lo scontro con gli Angiò.
Manfredi affrontò e fu sconfitto da Carlo d'Angiò, presso Benevento in una battaglia passata alla storia e cadde sul campo inutilmente difeso dalla sua Guardia saracena. Il suo corpo fu prima abbandonato sul campo di battaglia, poi salvato e seppellito a capo del ponte di Benevento, ma fu dopo poco dissotterrato per ordine del pontefice e deposto, quale scomunicato, fuori dai confini della Stato della Chiesa.
Dante, nella Divina Commedia incontra il suo spirito nel Purgatorio nel canto III, ai versi 103-145.
La poetica
Alla corte di Federico, ebbe occasione di frequentare i cantori della c.d. Scuola Poetica Siciliana e di scrivere composizioni.
da completare