Numa Pompilio
Numa Pompilio (754 a.C. – 673 a.C.) è stato il secondo re di Roma, regnando per 43 anni[1].
| Numa Pompilio | |
|---|---|
| Re di Roma | |
| In carica | 715 a.C. - 673 a.C. |
| Predecessore | Romolo |
| Successore | Tullo Ostilio |
| Nascita | 754 a.C. |
| Morte | 673 a.C. |
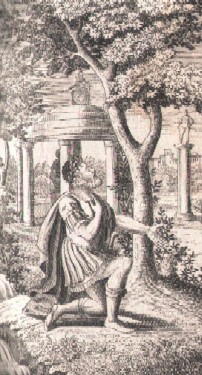
La leggenda
Per la tradizione e la mitologia romana, tramandataci grazie a Tito Livio e a Plutarco che ne scrisse anche una biografia, Numa Pompilio, di origine sabina, regnò tra il 715 a.C. e il 673 a.C. (anno in cui morì ottantenne, dopo 43 di regno[1]) succedendo come re di Roma a Romolo.
Incoronazione
L'incoronazione di Numa non avvenne immediatamente dopo la scomparsa di Romolo, alla cui morte il governo della città passò invece ai Senatori (che governavano a rotazione), in un tentativo di sostituire la monarchia con una oligarchia[2]. I Senatori, incalzati dal sempre maggiore malcontento popolare, furono però costretti ad eleggere un nuovo re.
La scelta apparve subito difficile a causa delle tensioni fra i Romani che proponevano il senatore Proculo ed i Sabini che proponevano il senatore Velesio. Per trovare una soluzione si decise di procedere in questo modo: i senatori romani avrebbero proposto un nome scelto fra i Sabini e lo stesso avrebbero fatto i senatori sabini[3]. I romani proposero Numa Pompilio, appartenente alla Gens Pompilia, che abitava nella città sabina di Cures Sabini ed era sposato con Tazia, l'unica figlia di Tito Tazio (nato addirittura nel giorno in cui Romolo fondò la città eterna). Numa era molto noto in città come uomo di provata fede ed esperto conoscitore delle leggi divine, tanto da meritare l'appellativo di Pius. I Sabini accettarono la proposta[4]. Furono inviati a Cures, per offrirgli il regno, Proculo e Velesio (i due senatori più influenti rispettivamente fra i Romani ed i Sabini))[5]. Inizialmente contrario ad accettare la proposta dei senatori per la fama violenta dei costumi di Roma[6], Numa vi acconsentì solo dopo che furono presi gli auspici degli dei, che gli si dimostrarono favorevoli; Numa fu quindi eletto re per acclamazione da parte del popolo[7].
Governo
La leggenda afferma che il progetto di riforma politica e religiosa di Roma attuato da Numa fu a lui dettato dalla ninfa Egeria con la quale, ormai vedovo, soleva passeggiare nei boschi[8] e che si innamorò di lui al punto da renderolo suo sposo[9]. Appena divenuto re, sciolse il corpo delle guardie del re (i celeres) e nominò, a fianco del sacerdote dedito al culto di Giove ed a quello dedicato al culto di Marte, un terzo sacerdote dedicato al culto del dio Quirino. Riunì poi questi tre sacerdoti in un unico collegio sacerdotale che fu detto dei flamini a cui diede precise regole ed istruzioni[10]. A Numa sono ascritte una serie di riforme tese a consolidare le istituzioni della nuova città, prime tra tutte quelle religiose (raccolte nei commentarii Numae o libri Numae che andarono perduti quando Roma fu saccheggiata dai Galli[11]). Proibì ai Romani di venerare immagini divine a forma umana e di animale perché riteneva sacrilego paragonare un dio con tali immagini e, durante il suo regno non furono costruite statue raffiguranti gli dei[12]. Istituì il collegio sacerdotale dei Pontefici[13], presieduti dal Pontefice Massimo, carica che Numa ricoprì per primo e che aveva il compito di vigilare sulle vestali (vedi sotto) e sulla moralità pubblica e privata e sull'applicazione di tutte le prescrizioni di carattere sacro[14]. Istituì poi il collegio delle vergini Vestali[15] assegnando a queste uno stipendio e la cura del tempio in cui era custodito il fuoco sacro della città; le prime furono Gegania, Verenia, Canuleia e Tarpeia (erano dunque quattro, Anco Marzio ne aggiunse altre due portandole a sei)[16]. Istituì anche il collegio dei Feziali (i guardiani della pace) che erano magistrati - sacerdoti con il compito di tentare appianare i conflitti con i popoli vicini e di proporre al guerra una volta esauriti tutti gli sforzi diplomatici[17]. Nell'ottavo anno del suo regno istituì il collegio dei Salii, sacerdoti che avevano il compito di separare il tempo di pace e di guerra (per gli antichi romani il periodo per le guerre andava da marzo ad ottobre)[18]. Era, questa funzione, molto importante per gli abitanti dell'antica Roma, perché sanciva, nel corso dell'anno, il passaggio dallo stato di cives (cittadini soggetti all'amministrazione civile e dediti alle attività produttive) a milites (militari soggetti alle leggi ed all'amministrazione militare e dediti all'esercitazioni militari) e viceversa per tutti gli uomini in grado di combattere. Migliorò anche le condizioni di vita degli schiavi p.es. permettondo loro di partecipare alle feste in onore di Saturno, i Saturnalia assieme ai loro padroni[19]. Stabilì di unificare ed armonizzare tutti i culti e le tradizioni dei Romani e dei Sabini residenti a Roma per eliminare le divisioni e le tensioni fra questi due popoli, riducendo l'importanza delle tribù e creando nuove associazioni basate sui mestieri[20]
Sácra feréns? Noscó crinís incánaque ménta
Régis Rómaní, primám qui légibus úrbem
Fúndabít, Curibús parvís et páupere térra
Míssus in ímperiúm magnúm.»
«Chi (è) pertanto quello lontano cinto del ramo d'ulivo che porta gli arredi sacri? Conosco i capelli e il mento canuto del re Romano, che consoliderà la prima città colle leggi, chiamato dalla piccola Curi e da una povera terra ad un grande potere.»
Nel Foro, dietro al tempio di Vesta, fece costruire la Regia[21] e lungo la Via Sacra fece edificare il Tempio di Giano, le cui porte potevano essere chiuse solo in tempo di pace (e rimasero chiuse per tutti i 43 anni del suo regno)[22].
Calendario
A lui viene ascritta anche una riforma del calendario, basato sui cicli lunari, che passò da 10 a 12 mesi (355 giorni), con l'aggiunta di gennaio, dedicato a Giano, e febbraio che furono posti alla fine dell'anno, dopo dicembre (l'anno iniziava con il mese di marzo)[23].
Il calendario conteneva anche l'indicazione dei giorni fasti e nefasti, durante i quali non era lecito prendere alcuna decisione pubblica. Anche in questo caso, come per tutte le riforme più difficili, la tradizione racconta che il re seguì i consigli della ninfa Egeria, sottolineando così il carattere sacrale di queste decisioni.
«E divise l'anno in dodici mesi seguendo prima di tutto il ciclo della Luna; e poiché la Luna non lo completa con i singoli mesi di trenta giorni, ma avanzano sei giorni per un anno intero che completi il ciclo dei solstizi, stabilì di interporre mesi intercalari in modo che nel giro di 19 anni i giorni, tornando alla stessa posizione del sole dal quale erano partiti, collimassero in pieno con gli anni. Distinse poi i giorni in fasti e nefasti, perché in certi giorni non si dovessero prendere decisioni pubbliche.»
L'anno così suddiviso da Numa, non coincideva però con il ciclo lunare, per cui ad annate alterne veniva aggiunto come ultimo mese il mercedonio, composto da 27 giorni, togliendo a febbraio 4 o 5 giorni; era il collegio dei pontefici a decidere queste compensazioni, alle volte anche sulla base di convenienze politiche[24].
Feste religiose
La tradizione vuole che Numa avesse istituito, tra l'altro, anche la Festa di Quirino e la Festa di Marte. La festa prima si celebrava a febbraio, mentre la festa dedicata a Marte si celebrava a marzo, e veniva officiata dai Salii. Numa partecipava di persona a tutte le feste religiose durante le quali era proibito lavorare.
A queste riforme di carattere religioso corrispose anche un periodo di prosperità e di pace che permise a Roma di crescere e rafforzarsi, tanto che durante tutto il suo regno le porte del tempio di Giano non furono mai aperte[25].
Morte e sepoltura
Morirà ottantenne e non di morte improvvisa ma consunto dagli anni, quando suo nipote, il future re Anco Marzio, aveva solo cinque anni[26], circondato dall'affetto dei romani, grati anche per il lungo periodo di prosperità e pace di cui avevano goduto. Alla processione funebre parteciparono anche molti rappresentanti dei popoli vicini ed il suo corpo non fu bruciato ma seppellito insieme ai suoi libri in un mausoleo sul GianicoloErrore nelle note: </ref> di chiusura mancante per il marcatore <ref>. Alcune fonti raccontano di un secondo matrimonio di Numa Pompilio con una certa Lucrezia da cui sarebbero nati quattro figli: Pompone, Pino, Calpo e Memerco dai quali avrebbero avuto origine le casate romane dei Pomponi, dei Pinari, dei Calpurni e dei Marci[27].
La critica storico-archeologica
La reale esistenza di Numa Pompilio, come accade per quella di Romolo è discussa. Per alcuni studiosi la sua figura sarebbe principalmente simbolica; un re per metà filosofo e per metà santo, teso a creare le norme ed il comportamento religioso di Roma, avverso alla guerra e ai disordini, diametralmente opposto al suo predecessore, il re guerriero Romolo. L'origine stessa del nome ( Numa da Nómos = legge e Pompilio da pompé = abito sacerdotale[28]) indicherebbe l'idealizzazione della sua figura.
Note
- ^ a b Eutropio, Breviarium ab Urbe condita, I, 3: Postea Numa Pompilius rex creatus est, qui bellum quidem nullum gessit, sed non minus civitati quam Romulus profuit. Nam et leges Romanis moresque constituit, qui consuetudine proeliorum iam latrones ac semibarbari putabantur, et annum descripsit in decem menses prius sine aliqua supputatione confusum, et infinita Romae sacra ac templa constituit. Morbo decessit quadragesimo et tertio imperii anno. (Poi fu eletto re Numa Pompilio, che non condusse alcuna guerra ma non fu alla città meno utile di Romolo. Infatti sia stabilì le leggi e le usanze ai Romani, che, per la consuetudine agli scontri già avevano fama di banditi e semibarbari, sia divise l'anno in dieci mesi, in precedenza confuso, senza nessun calcolo ed inaugurò un gran numero di feste sacre e di templi a Roma. Mori per malattia nel quarantatreesimo anno di regno. -Libera traduzione del curatore-)
- ^ Plutarco: vita di Numa; II, 6-7
- ^ Plutarco: vita di Numa; III, 1
- ^ Plutarco: vita di Numa; III, 3
- ^ Plutarco: vita di Numa; V, 1
- ^ Plutarco: vita di Numa; V, 2-5
- ^ Plutarco: vita di Numa; VII, 1
- ^ T.Livio: Ad Urbe condita; I, 19: Qui cum descendere ad animos sine aliquo commento miraculi non posset, simulat sibi cum dea Egeria congressus nocturnos esse; eius se monitu quae acceptissima dis essent sacra instituere, sacerdotes suos cuique deorum praeficere.
- ^ Plutarco; vita di Numa; IV, 2-3
- ^ Plutarco: vita di Numa; VII, 4-5
- ^ Plutarco: vita di Numa; I, 1
- ^ Plutarco: vita di Numa; VIII, 7
- ^ Plutarco: vita di Numa; IX, 1-4
- ^ Plutarco: vita di Numa; VII, 4
- ^ Plutarco: vita di Numa; IX, 5
- ^ Plutarco: vita di Numa; X, 1-7
- ^ Plutarco: vita di Numa; XII, 4-7
- ^ Plutarco: vita di Numa; XIII, 1-7
- ^ Plutarco: Vite Parallele, Licurgo e Numa; 1, 5
- ^ Plutarco: vita di Numa; XVII, 3
- ^ Plutarco: vita di Numa; XIV, 1
- ^ Plutarco: vita di Numa; XX, 1-3
- ^ Plutarco: vita di Numa; XVIII, 1-4
- ^ Plutarco: vita di Numa; XIX, 1-6
- ^ Plutarco, Vite Parallele: Licurgo e Numa; IV, 7
- ^ Plutarco: vita di Numa; XXI, 4
- ^ Plutarco: vita di Numa; XXI, 1-4
- ^ Antonio Brancati, Civiltà a confronto, Vol. I, Firenze, La Nuova Italia, 1984.
Voci correlate