Reso
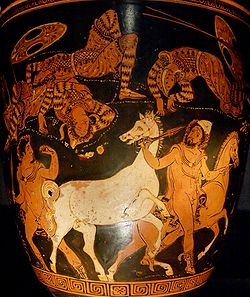
Reso (in greco antico Ῥῆσος Rhêsos) è un personaggio della mitologia greca.
Il mito
Le origini
Reso era un giovane re della Tracia che, secondo l’Iliade, nel corso della guerra di Troia si alleò con i troiani di Priamo. Omero afferma che suo padre era Eioneo,[1] un personaggio altrimenti sconosciuto, sebbene il suo nome sia evidentemente connesso con la città di Eione che si trova nella Tracia occidentale, alla foce dello Strimone. Scrittori di epoche successive attribuirono a Reso un’origine semidivina, sostenendo che fosse figlio di una delle Muse (Clio, Calliope, Euterpe o Tersicore), che suo padre fosse la divinità che sovrintende al fiume Strimone e che fosse stato allevato da alcune Naiadi.
La morte
Reso salì ancora adolescente sul trono di Tracia. Era da poco diventato re quando giunse la notizia della guerra scoppiata tra greci e troiani, e allora inviò in aiuto del re Priamo un grande contingente di uomini guidati da Acamante e Piroo: se egli non poté subito intervenire direttamente in prima persona fu perché nel contempo si trovò a dover difendere il suo regno da un attacco degli abitanti della Scizia. Passarono così dieci anni, e finalmente Reso arrivò a Troia con due cavalli bianchi che gli erano stati donati da Ares, dotati di una grandissima velocità. Gli Achei, preoccupati di questo, inviarono Odisseo e Diomede per rubarglieli. I due eroi, penetrati nell’accampamento con il favore del buio, si introdussero nella tenda di Reso e uccisero lui e dodici suoi uomini mentre dormivano per poi allontanarsi con i preziosi animali. Ironia della sorte, il giovane condottiero in quel momento sognava di essere ucciso da Diomede. Alla strage sopravvisse Ippocoonte, cugino e coetaneo di Reso, nonché suo consigliere.
Questi fatti sono raccontati sia nel libro X dell’Iliade che nella tragedia Reso, la cui attribuzione ad Euripide è tuttora incerta e contestata. Ecco il passo omerico:
" Disse, e spirò Minerva a Dïomede
robustezza divina. A dritta, a manca
fora, taglia ed uccide, e degli uccisi
il gemito la muta aria ferìa.
Corre sangue il terren: come lïone
sopravvenendo al non guardato gregge
scagliarsi, e capre e agnelle empio diserta;
tal nel mezzo de’ Traci è Dïomede.
Già dodici n’avea trafitti; e quanti
colla spada ne miete il valoroso,
tanti n’afferra dopo lui d’un piede
lo scaltro Ulisse, e fuor di via li tira,
nettando il passo a’ bei destrieri, ond’elli
alla strage non usi in cor non tremino,
le morte salme calpestando. Intanto
piomba su Reso il fier Tidìde, e priva
lui tredicesmo della dolce vita.
Sospirante lo colse ed affannoso
perché per opra di Minerva apparso
appunto in quella gli pendea sul capo,
tremenda visïon, d’Enide il figlio.
Scioglie Ulisse i destrieri, e colle briglie
accoppiati, di mezzo a quella torma
via li mena, e coll’arco li percuote
(ché tor dal cocchio non pensò la sferza),
e d’un fischio fa cenno a Dïomede.
Ma questi in mente discorrea più arditi
fatti, e dubbiava se dar mano al cocchio
d’armi ingombro si debba, e pel timone
trarlo; o se imposto alle gagliarde spalle
via sel porti di peso; o se prosegua
d’altri più Traci a consumar le vite.
In questo dubbio gli si fece appresso
Minerva, e disse: Al partir pensa, o figlio
dell’invitto Tidèo, riedi alle navi,
se tornarvi non vuoi cacciato in fuga,
e che svegli i Troiani un Dio nemico.
Udì l’eroe la Diva, e ratto ascese
su l’uno de’ corsier, su l’altro Ulisse
che via coll’arco li tempesta, e quelli
alle navi volavano veloci.
Il signor del sonante arco d’argento
stavasi Apollo alla vedetta, e vista
seguir Minerva del Tidìde i passi,
adirato alla Dea, mischiossi in mezzo
alle turbe troiane, e Ipocoonte
svegliò, de’ Traci consigliero, e prode
consobrino di Reso. Ed ei balzando
dal sonno, e de’ cavalli abbandonato
il quartiero mirando, e palpitanti
nella morte i compagni, e lordo tutto
di sangue il loco, urlò di doglia, e forte
chiamò per nome il suo diletto amico;
e un trambusto levossi e un alto grido
degli accorrenti Troi, che l’arduo fatto
dei due fuggenti contemplâr stupiti. "
(Omero, Iliade X, traduzione di Vincenzo Monti)
Etimologia
Il nome Reso (un antroponimo tracio) probabilmente deriva dalla radice Indoeuropea *reg-, "governare" mutata secondo le caratteristiche tipiche di una lingua Satem. In Bitinia c’era anche un fiume chiamato Reso, al quale la mitologia greca attribuisce una divinità protettrice che porta lo stesso nome. Il re di Tracia Reso fu a sua volta associato alla Bitinia grazie alla sua storia d’amore con la cacciatrice bitina Argantone, come riportato dagli Erotika Pathemata (Pene d’amore) di Partenio di Nicea.
Fortuna dell'episodio
Il tragico destino di Reso fu ben noto a Virgilio, che nel libro I della sua Eneide pose una sua raffigurazione in un tempio di Cartagine. Ma soprattutto il poeta latino creò, nel libro IX del poema, un episodio quasi del tutto analogo, in cui i due grandi amici troiani Eurialo e Niso seminano un'ingente strage nelle tende dei guerrieri italici addormentati.
" nel sonno e nel sopor del vino immersi,
vedono ovunque Rutuli fra l'ombre,
carri funesti col timone al cielo,
uomini ed armi fra le briglie, ed elmi
ed anfore di vino a terra prone.
E l'Irtacide allora: « Questo, Eurialo,
è il momento di osare!» "
(Virgilio, Eneide, libro IX, traduzione di Adriano Bacchielli)
Due personaggi in particolare richiamano il re trace: il condottiero Remo (Eneide), che ha un cocchio da guerra trainato da cavalli, e l'augure Ramnete (Amnete nella traduzione di Adriano Bacchielli), per il dettaglio del russare affannoso. Costituisce invece un'innovazione, rispetto al modello omerico, la morte, mediante decapitazione, di alcune vittime, Remo, Lamiro e Lamo, e il bellissimo Serrano (Eneide): spettacolare quella di Remo, col sangue che intride tutto il letto su cui è coricato l'eroe.
" Così dice, e si tace; e d'improvviso
assale con la spada il tronfio Amnete
che su cumulo folto di tappeti
roco soffiava dai polmoni il sonno:
ed augure egli era, e a Turno caro,
ed egli stesso re; ma l'arte sua
non lo salvò da morte. Poi tre servi
accanto a lui sorprende, alla rinfusa
in mezzo all'armi placidi giacenti,
e l'auriga di Remo fra i cavalli;
e taglia loro la riversa gola.
Poi con un colpo mozza il capo al sire
e lascia il tronco sussultar nel sangue
che il letto intiepidisce e il suolo imbruna;
e a Lamo poi, a Lamiro, a Serrano
che fino a tarda notte avea giocato:
bello d'aspetto, al suol giacente, immemore,
avvinti i sensi nel sopor del vino."
(Virgilio, Eneide, libro IX, traduzione di Adriano Bacchielli)
In età moderna Ludovico Ariosto nel suo Orlando Furioso si ispira all'episodio omerico e in parte anche a quello virgiliano facendo dei due guerrieri saraceni Cloridano e Medoro gli autori di un massacro notturno di cui restano vittime diversi nemici cristiani sorpresi nel sonno.
" Così disse egli, e tosto il parlar tenne,
ed entrò dove il dotto Alfeo dormia,
che l'anno inanzi in corte a Carlo venne,
medico e mago e pien d'astrologia:
ma poco a questa volta gli sovenne;
anzi gli disse in tutto la bugia.
Predetto egli s'avea, che d'anni pieno
dovea morire alla sua moglie in seno:
ed or gli ha messo il cauto Saracino
la punta de la spada ne la gola.
Quattro altri uccide appresso all'indovino,
che non han tempo a dire una parola:
menzion dei nomi lor non fa Turpino,
e 'l lungo andar le lor notizie invola:
dopo essi Palidon da Moncalieri,
che sicuro dormia fra duo destrieri.
Poi se ne vien dove col capo giace
appoggiato al barile il miser Grillo:
avealo voto, e avea creduto in pace
godersi un sonno placido e tranquillo.
Troncògli il capo il Saracino audace:
esce col sangue il vin per uno spillo,
di che n'ha in corpo più d'una bigoncia;
e di ber sogna, e Cloridan lo sconcia.
E presso a Grillo, un Greco ed un Tedesco
spenge in dui colpi, Andropono e Conrado
che de la notte avean goduto al fresco
gran parte, or con la tazza, ora col dado:
felici, se vegghiar sapeano a desco
fin che de l'Indo il sol passassi il guado.
Ma non potria negli uomini il destino,
se del futuro ognun fosse indovino."
(Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, canto XVIII, ottave 174-77)
Note
- ^ Omero, Iliade, libro X, verso 435.
Voci correlate
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Reso
- Wikiquote contiene citazioni da Reso
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Reso