Utente:Yvul/Sandbox
| Chiusa di Casalecchio di Reno | |
|---|---|
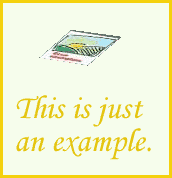 | |
| Ubicazione | |
| Nazione | |
| Città | |
| Provincia | Bologna |
| Regione | Emilia Romagna |
| Informazioni generali | |
La chiusa di Casalecchio di Reno è una chiusa di origine medievale sul fiume Reno. È situata nel comune di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, nella regione Emilia Romagna.
La chiusa di Casalecchio aveva un ruolo fondamentale nella fornitura dell'acqua necessaria ai filatoi da seta della medievale industria serica bolognese. [1]
Storia
Fino alla sistemazione definitiva della chiusa, ordinata dal cardinale Legato Pontificio Cardinale Gil Alvarez Carrillo de Albornoz e posteriore al 1360, i fatti e le date relativi a questa struttura idraulica rimangono incerti. Successivamente a tale intervento, non vi furono sostanziali modifiche a chiusa e relativo canale.
dal secolo XIII al XV
Possiamo rintracciare la prima traccia documentaria relativa alla chiusa nell'anonimo manoscritto ottocentesco B 2238, conservato nella biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna. Questo fissa già nell'anno Mille l'esistenza di una rudimentale chiusa, a cui si riferisce coi termini "Pescaja" e "Steccaia", e di un breve tratto (appena qualche centinaio di metri) del canale di Reno. Tuttavia, pare ragionevole datare l'opera idraulica a un periodo più tardo, benché anteriore al 1191, anno in cui fu costruita una ramificazione del canale di Reno, che giunse così a toccare la cinta muraria di Bologna[1]. Tale ramificazione costeggiava via del Pratello, ove vennero realizzati quattro mulini, attivi fino al 1314, e coloro che facevano uso della sua acqua erano detti Ramisani dalla loro natura di comproprietari di un ramo del Reno. I Ramisani erano riuniti in consorzio e si occupavano delle spese di mantenimento di canale e chiusa.
Non è certo chi fu coinvolto nell'opera di costruzione, ma una possibile ipotesi vede i Canonici Renani, appartenenti alla Canonica di S. Maria del Reno (fondata nel 1130), che erano dotati dei mezzi economici, organizzativi e tecnici necessari per tale impresa. Certo è, invece, che in origine la chiusa era una costruzione modesta, collocata in un punto non ricostruibile con precisione[2] e successivamente migliorata e ampliata in base alle funzioni e alle potenzialità che con il passare degli anni le erano richieste.
Il 23 giugno 1208 quarantatré Ramisani, insieme ad altri interessati e aventi diritti sul canale di Reno, stipularono col Comune di Bologna un accordo per cui il Comune stesso si impegnava nella costruzione di una nuova chiusa, provvedendo alla sua regolare manutenzione, e di un nuovo ramo del canale, introdotto nella città di Bologna dalla Grada[3].[1] Fra i Ramisani sottoscrittori compaiono nomi di famiglie di nobiltà feudale, di famiglie d'origine mercantili, futura aristocrazia cittadina, e di persone legate all'Università. La nuova chiusa fu effettivamente costruita poco dopo il 1208 e garantiva un maggior afflusso di acqua di fiume verso la città.
Esistono tuttavia versioni differenti da questa, ritenute da alcuni meno plausibili, riguardo alle dinamiche di costruzioni dei rami del canale, che derivavano le proprie acque dalla chiusa di Casalecchio. [1]
Fino a metà del secolo XIII la chiusa era un semplice sbarramento di legno simile a una palizzata. La costituivano grossi pali di legno infissi sul fondo dell'alveo fluviale e collegati gli uni agli altri tramite traverse, ferle e funi di canapa. Non era particolarmente alta, poiché non era necessario che lo fosse per resistere a correnti e piene, e probabilmente era rinforzata da grandi massi disposti a scogliera. Si trattava di una struttura piuttosto vulnerabile, bisognosa di costanti e costose manutenzioni.
Per ovviare a tali costi, il Comune di Bologna fece costruire nel 1250 una chiusa in pietra più a monte della precedente in legno; a questo si aggiunse lo scavo del "ramus vetus", un tratto di collegamento fra la nuova struttura e il canale già esistente. Tali compiti furono gestiti da una commissione tecnica costituita dall'ingegnere Alberto, mastro Giovanni da Brescia, mastro Michele Delamusca e mastro Michele Lamandini. Il lavoro fu terminato nel 1278. Nonostante i buoni propositi, però, anche la nuova costruzione si rivelò bisognosa di frequenti manutenzioni, dovute dalle piene del fiume Reno e dall'erosione causata dalle acque. Si parla, per esempio, di riparazioni eseguite negli anni 1288, 1289, 1294, 1295 e 1299.[2] Interventi di riparazione riguardano anche la vecchia chiusa lignea, forse considerata un impianto sussidiario, che fu ritenuta non più necessaria e quasi del tutto smantellata solo nel 1309.
Il 29 aprile 1310 una piena del Reno arrecò danni talmente gravi alla chiusa da impedire che l'acqua giungesse ai mulini bolognesi, lasciando così la città senz'acqua. Le necessarie operazioni di ripristino, in atto già il giungo seguente, furono supervisionate dai frati Predicatori e Minori [4], a cui il Comune di Bologna decise di affidare il complesso chiusa-canale. Episodi come questi non erano inusuali, in particolare nel primo trentennio del Trecento; non risulta tuttavia possibile ricostruire esattamente il numero e i dettagli degli interventi effettuati per via delle versioni contrastanti dei fatti fornite da cronache e studi. [1]
Nel 1317 si parla di interventi di tipo strutturale, e così anche nel 1324, anno in cui l'allora al governo cardinale Bertrando del Poggetto (Bertrand du Pouget) affidò a due frati dell'ordine degli Eremitani[5], frate Giacomo e frate Bartolomeo, la definitiva sistemazione della Chiusa. Tale lavoro venne compiuto ma ebbe vita breve. Nel 1325, infatti, a seguito della battaglia di Zappolino, Passerino Buonacossa devastò il territorio casalecchiese e, in quella stessa occasione, molto probabilmente aiutato da una violenta piena del fiume, rovinò anche la chiusa, così da privare Bologna dell'acqua.
I ruderi della chiusa distrutta da Buonacossa sono oggi ancora visibili a valle della Chiusa attuale. Sono localmente chiamati "il Pracinino" (dal termine dialettale "Prè-zinèn", ovvero "prato piccolo") e "i Masgnòn" (i Macignoni). Osservandoli, è chiaramente visibile la composizione della chiusa: un conglomerato di pietre e sassi legati da calce e ricoperti, su almeno parte dello scivolo della chiusa, da pietra ofiolitica. Si notano anche segni di una struttura di travi lignee, probabilmente impiegata per la sopraelevazione delle parti superiori della chiusa, e, nella calce, tracce di carbonella, che fanno pensare a fuochi accesi dagli operai nei momenti di sosta. La chiusa presentava gravi errori di progettazione, che la costrinsero a cadere sotto l'attacco congiunto del legato e della piena: la costruzione era eccessivamente lunga, sprovvista di elementi interni capaci di opporre resistenza a una forte pressione dell'acqua, e appoggiata direttamente sulla pietra, senza scavo di fondazione. Le sue fondamenta affondavano infatti solamente in un alto e poco solido cuscino di ghiaia.
Nella successiva ricostruzione, indetta dal Legato de Albornoz fra il 1360 e il 1363 [2 pag.28], la chiusa fu ulteriormente spostata a monte, nel sito in cui ancora oggi si trova. Seguirono miglioramenti, aggiustamenti e rinforzi.
Fino alla fine del XV secolo non vi fu un organo specifico a cui erano affidate le manutenzioni ordinarie e straordinarie della chiusa. Ognuna di queste, infatti, era gestita da una commissione di mastri e ingegneri, scelti dal governo cittadino e diretti a loro volta da frati Predicatori e Minori. A partire dall'1 febbraio 1416, invece, fu obbligato allo svolgimento delle manutenzioni il Reggimento, come riportano due memoriali del XVII secolo.
Custodi
La chiusa oggi
Curiosità
Nella sala Farnese del palazzo comunale di Bologna
Note
- ^ Si tratta della seconda delle tre cinte murarie che Bologna ebbe nella sua storia: la cinta dei Torresotti
- ^ Ne è causa il fatto che, col passare dei secoli, i livelli del letto del Reno si sono vistosamente modificati.
- ^ Apertura nel muro della città, dotata di solida ferriata che è possibile alzare e abbassare mediante un apposito meccanismo.
- ^ Si tratta, rispettivamente, dei frati Domenicani e Francescani
- ^ Si tratta di frati Agostiniani