Papa Sisto I
Sisto I (in latino Xystus; Roma, 42 – Roma, 126/128) è stato il 7º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica, che lo venera come santo. Fu papa orientativamente tra il 117/119 e il 126/128.
| Papa Sisto I | |
|---|---|
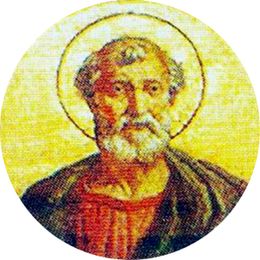 | |
| 7º papa della Chiesa cattolica | |
| Elezione | 117/119 |
| Fine pontificato | 126/128 |
| Predecessore | papa Alessandro I |
| Successore | papa Telesforo |
| Nascita | Roma, 42 |
| Morte | Roma, 126/128 |
| Sepoltura | Necropoli vaticana |
| San Sisto I | |
|---|---|
 | |
Papa e martire | |
| Nascita | Roma, 42 |
| Morte | Roma, 126/128 |
| Venerato da | Tutte le Chiese che ammettono il culto dei santi |
| Santuario principale | Necropoli vaticana |
| Ricorrenza | 3 aprile |
| Patrono di | Alife e Alatri |
Biografia
modificaEra figlio di un certo Pastor, romano della regione di via Lata, dalle parti dell'odierna via del Corso. Il suo nome, Xystus, probabilmente di origine greca, è stato in seguito erroneamente confuso con Sistus (che ne ha proseguito la numerazione) in riferimento al fatto che fu il sesto successore di Pietro.
Pontificato
modificaEletto con i voti di tutto il clero romano, secondo il Catalogo Liberiano dei papi, svolse il suo pontificato sotto l'imperatore Adriano, «a consulatu Nigri et Aproniani usque Vero III et Ambibulo» («dal consolato di Nigro e Aproniano a quello di Vero III e Ambibulo»), ovvero dal 117 al 126. Il Liber pontificalis, che omette il riferimento alla data di inizio del suo episcopato, riporta la stessa data per l'anno finale, parlando di una durata di dieci anni, due mesi e un giorno.[1]
Lo storico Eusebio di Cesarea invece, in due scritti diversi riporta due periodi diversi: nel Chronicon dice che fu papa dal 114 al 124, mentre nell'Historia ecclesiastica[2] afferma che regnò dal 114 al 128. In ogni caso, tutti gli studiosi concordano sul fatto che regnò circa 10 anni.
Contesto storico
modificaDurante il suo pontificato, la situazione dei cristiani nell'Impero romano era caratterizzata da un clima di relativa tolleranza ma ancora precario. Negli ultimi anni del suo regno, l'imperatore Traiano aveva mitigato la politica persecutoria nei confronti dei cristiani, come testimonia la corrispondenza con Plinio il Giovane, governatore della Bitinia. Con l'ascesa al trono di Adriano, questa politica di cauta tolleranza proseguì.
Adriano scrisse al proconsole d'Asia che i cristiani dovevano essere puniti solo se si dimostrava che avessero effettivamente violato delle leggi e che le loro calunnie dovevano essere sanzionate. Tuttavia, questo non significava che i cristiani potessero professare liberamente la loro fede. Restava sempre il rischio di persecuzioni locali e di accuse basate sul semplice fatto di essere cristiani.
Le riforme
modificaSecondo il Liber Pontificalis, durante il suo pontificato emanò 3 disposizioni:
- nessuno, ad eccezione dei ministri del culto, durante la consacrazione può toccare il calice e la patena;
- i vescovi che si sono recati presso la Santa Sede, al loro ritorno nella diocesi devono presentarsi con una lettera apostolica, secondo il modello della formata, che conferma la loro piena comunione con il successore di Pietro;
- dopo il Prefazio della messa il sacerdote deve recitare il Sanctus con l'assemblea.
La seconda disposizione a lui attribuita è desunta dal canone III della raccolta di un ipotetico concilio di papa Silvestro I e di 275 vescovi, stesa all'epoca di papa Simmaco. Il canone in questione era inteso a garantire la comunione di ogni vescovo con la diocesi di Roma. Riguardo le altre due, gli storici della liturgia ritengono che siano attribuzioni anacronistiche, riferite ad un periodo successivo della storia della Chiesa.
Inoltre, è verosimile che sia lui il vescovo proveniente dall'Oriente a cui nel finale della Passio di Alessandro, Evenzio e Teodolo si rivolge Severina perché assegni un vescovo per la celebrazione della messa presso il sepolcro dei tre martiri.
Al periodo del suo papato forse, risalgono le prime divergenze tra la Chiesa di Roma e le chiese d'Oriente. Infatti si ha notizia da Ireneo di Lione, che papa Sisto I non impose alla Chiese che celebravano la pasqua secondo il calendario giudaico, cioè il giorno 14 del mese di Nisan, di cambiare data seguendo la prassi della Chiesa di Roma.[3] Pare invece che sia stato lui ad inviare i primi missionari ad evangelizzare la Gallia, tra cui san Pellegrino.
A lui furono attribuite due lettere, sulla dottrina della Trinità e sul primato del vescovo di Roma, che sono considerate apocrife.
Morte
modificaAlla sua morte, il suo corpo fu inumato nella Necropoli vaticana, a fianco al corpo di san Pietro.
Il Catalogo Feliciano dei Papi e i vari martirologi lo citano come martire, ma poiché non vi sono dettagli sul tipo di martirio, né altri documenti, il Calendario Universale della Chiesa attualmente non lo annovera nell'elenco dei martiri. Però è significativo che Ireneo di Lione non lo menzioni tra i martiri.
Culto
modificaMemoria liturgica
modificaLa memoria liturgica di San Sisto I ricorre il 3 aprile. Dal Martirologio Romano:
Il suo nome è compreso nella lista di vescovi di Roma alla data del 23 dicembre nel Martirologio geronimiano, ma la sua commemorazione compare alla data del 6 aprile, salvo in alcuni casi, dove è registrata alla data del 3 aprile, corrispondente a quanto scritto nel Liber pontificalis.
Reliquie
modificaViene venerato come patrono di Alife e di Alatri, nelle diocesi di Alife e di diocesi di Anagni-Alatri. Variegate sono le tradizioni locali per cui le reliquie di san Sisto I si trovino in queste due città. Dal Medioevo, fino a pochi anni or sono, la questione delle reliquie ha diviso le città di Alife e di Alatri, ognuna delle quali riteneva di detenere per intero il corpo di san Sisto. Recenti studi, condotti sia ad Alife che ad Alatri negli anni ottanta, mostrano che entrambe le città hanno circa il 50% del corpo del Santo.[4]. Queste tradizioni locali hanno solide origini medievali.[5] In modo particolare, la traslazione ad Alatri verrebbe confermata in documenti reperiti durante una ricognizione delle reliquie fatta nella concattedrale di San Paolo nel 1584
Alcune altre reliquie sono conservate in San Sisto a via Appia, dove, nella parete sinistra della chiesa, è murato, dietro una lapide, un cofanetto che le contiene, insieme a quelle di altri martiri.
Risulta inoltre che il capo e gran parte del corpo siano conservati a Savona nella cattedrale di Nostra Signora Assunta, in una teca sopra l'altare della cappella in testata alla navata laterale destra. Le reliquie, come riporta una lapide murata nella parete sinistra della cappella, sono state donate sotto il pontificato di papa Paolo V e trasferite a Savona il 12 agosto 1612 in un primo momento nella chiesa di San Giacomo. Da qui furono poi traslate in cattedrale nel 1801 e collocate nella loro posizione attuale nel 1814.
Note
modifica- ^ Liber Pontificalis - In formato testo, su Fontistoriche. URL consultato il 1º maggio 2025.
- ^ Storia ecclesiastica (Eusebio di Cesarea) - Cathopedia, l'enciclopedia cattolica, su it.cathopedia.org. URL consultato il 1º maggio 2025.
- ^ Tale comportamento di papa Sisto I è descritto in una lettera di Ireneo di Lione a papa Vittore I. cfr. I papi, vol. I, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014, ISBN 978-88-12-00521-5, p. 216
- ^ Dopo aver effettuato anche un gemellaggio nel 1984 tra le due diocesi, la comune devozione per il santo pontefice Sisto I ha fatto sì che, annualmente, un gruppo di alifani si rechi in visita ufficiale ad Alatri il mercoledì in Albis (giorno in cui la cittadina laziale festeggia il santo patrono) e, allo stesso modo, gli Alatrini si rechino ad Alife nel pomeriggio del 10 agosto per trattenersi ad Alife durante i giorni della festa
- ^ La Historia della traslazione sistina in Alife, opera di Alessandro Telesino, redatta fra il 1131 e il 1134 per intervento di Roberto, vescovo di Alife, era ancora nelle mani dei vescovi alifani del XVI secolo tra cui Antonio Agustín, e nota a Ignazio Danti vescovo di Alatri, che la ricordano in proprie lettere. Il contenuto della historia, per quanto sfuggita ad una vera e propria edizione, fu però ripreso dagli eruditi e antiquari del XVI e XVII secolo, in modo da tramandarne il ricordo prima della perdita del codice manoscritto. La Narrazione historica alatrense del XIV secolo sostiene che nel 1132 parte dei suoi resti sarebbero stati traslati nel duomo di Alatri (tali resti furono rinvenuti nel 1584 e sono conservati in un'urna di piombo che riporta la scritta Hic reconditum est corpus S. Xysti PP. Primi et Martiris) e nella cattedrale di Alife.
Bibliografia
modifica- Catholic Encyclopedia, Volume XIV. New York 1912, Robert Appleton Company. Nihil obstat, 1º luglio 1912. Remy Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur +Cardinale John Murphy Farley, Arcivescovo di New York;
- Liber Pontificatis, ed. Louis Duchesne, I, Paris, 1886, pagina 128;
- Marini, Cenni storici popolari sopra S. Sisto I, papa e martire, e suo culto in Alatri, Foligno, 1884;
- N. Giorgio, Notizie istoriche della vita, martirio, e sepoltura del glorioso San Sisto I. papa, e martire di varie traslazioni del suo Sacro Corpo, e dell'ultimo ritrovamento fattone nella città di Alife, Napoli, 1721;
- De Persiis, Del pontificato di S. Sisto I, papa e martire, della translazione delle sue reliquie da Roma ecc., memorie Alatri, 1884;
- Piercostante Righini, Storia dei Papi, Imprimatur Curia Episcopalis Tusculana 18 dicembre 1969, Editrice Domani, Roma, 1969.
- Claudio Rendina, I papi: storia e segreti, Newton & Compton, Roma, 1983
- Angelo Gambella, La documentazione esistente sulla Historia Allifana di Alessandro di Telese in Annuario dell'Associazione Storica del Medio Volturno 1998, Edizioni ASMV, Piedimonte Matese, 1999.
- Filiberto Sasso , San Sisto I , Alife , 2017
Voci correlate
modificaAltri progetti
modifica- Wikisource contiene una pagina dedicata a papa Sisto I
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su papa Sisto I
Collegamenti esterni
modifica- (EN) St. Sixtus I, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (FR) Bibliografia su Papa Sisto I, su Les Archives de littérature du Moyen Âge.
- (EN) Papa Sisto I, in Catholic Encyclopedia, Robert Appleton Company.
- Francesco Scorza Barcellona, SISTO I, santo, in Enciclopedia dei Papi, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2000.
- (EN) David M. Cheney, Papa Sisto I, in Catholic Hierarchy.
- Papa Sisto I, su Santi, beati e testimoni, santiebeati.it.
- Papa Sisto I, in Enciclopedia dei Papi, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2000.
- Opera Omnia, su documentacatholicaomnia.eu. URL consultato il 16 agosto 2007 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).
- San Sisto I, sesto papa della Chiesa e martire, su santogiorno.it.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 816928 · ISNI (EN) 0000 0000 2011 0910 · BAV 495/40461 · CERL cnp00404728 · LCCN (EN) nb2007022964 · GND (DE) 11922125X · BNE (ES) XX1588105 (data) · J9U (EN, HE) 987007397420105171 |
|---|